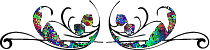Il rapporto fra i Rabbini e le Comunità.
Rav Roberto Della Rocca, Rabbino capo della Comunità Ebraica di Venezia.
Considerata la complessità e la vastità dell'argomento, ritengo impossibile operare una sintesi che pretenda di affrontare ed esaurire tutte le problematiche. Ho pensato quindi di affrontare alcuni degli aspetti principali del rapporto Rabbino-Comunità, presentandoli in cinque nuclei distinti, al centro di ognuno dei quali ci sono uno o più spunti narrativi tratti dalla letteratura rabbinica e dal pensiero ebraico.
1. Trasformazione o continuità?
Un giorno un anziano ospite della Casa di Risposo di Venezia mi confessò bonariamente che non riusciva a capire come mai l'ebraismo fosse così cambiato rispetto a cinquanta anni prima, e che vedeva anche i rabbini di oggi comportarsi molto diversamente rispetto a quelli del suo tempo. Questa sua franca osservazione mi ha rammentato un famoso Midrash del Talmud babilonese, Menachot 29b, che racconta di Mosè che, salito sul Monte Sinai, trova il Signore occupato ad attaccare delle coroncine alle lettere della Torah. Mosè chiede il senso di tutto questo, e Dio risponde che verrà un giorno un uomo di nome Akiva' ben Josef, il quale dedurrà da questi puntini tante nuove halakhot. Mosè chiede a Dio di poter vedere questa persona, e Dio gli concede di entrare nella scuola di Rabbi Akiva'. Mosè si siede a uno dei banchi, non comprende assolutamente nulla della lezione che Rabbi Akiva' sta insegnando, e si sente molto abbattuto. Arrivati a un certo punto, i discepoli chiedono a Rabbi Akiva' da dove egli deduca le sue argomentazioni, e lui risponde «è una halakhah che è stata data a Mosè sul Monte Sinai!». Solo allora Mosè, rassicurato sulla continuità della Tradizione, si tranquillizza. Da questo Midrash emerge, fra l'altro, l'evidenza di come nell'ebraismo la Torah orale, e quindi il contributo rabbinico, nella sua dinamicità, prevalgano sulla Torah scritta. Akiva' supera così Mosè nell'interpretazione, ma nello stesso tempo questa possibilità infinita di interpretazione trova il suo limite in ciò che Dio ha dato a Mosè. Ne deriva che da Mosè ad Akiva' si è meglio delineato il mondo dell'halakhah, pur nel rispetto della continuità. Questo perché quando nell'ebraismo si parla di Torah ci si riferisce non a un libro da leggere, ma a un libro da vivere: un libro che contiene in sé tutto il bagaglio di esperienze, di saggezza umana e, insieme di dubbi, problemi, interrogativi e interpretazioni che, dalla Torah e all'interno del sistema della Torah, traggono ispirazione. La parte insostituibile apportata da ognuno di noi al messaggio ricevuto, fa sì che questa ricchezza si manifesti soltanto nella pluralità degli individui e delle generazioni. Ma il Midrash ci dice che l'apporto di ciascuno, in ogni epoca, si confronta con le lezioni di tutti gli altri, nel presente e nel passato. Dunque, la Torah non si accontenta di essere modello di riferimento, ma si propone come punto di partenza per un incessante sviluppo e come stimolo per un dialogo tra le generazioni. La Torah è un testo aperto, teso per sua stessa essenza alla continua evoluzione. In tal modo, anche dal punto di vista meramente testuale, la Torah sceglie la vita: la Torah non accetta, infatti, la morte di sé come testo - che sarebbe rappresentata dalla chiusura interpretativa di una conclusione dogmatica. Il nostro Midrash ci racconta come, per un favore divino, Mosè possa vedere le generazioni future ed udire le loro interpretazioni, senza però riuscire a comprenderle. Quanto a noi, almeno, con l'aiuto di questa Tradizione, possiamo contemplare le generazioni passate, comprenderne le interpretazioni ed utilizzarne l'esperienza. La rivelazione che noi, anello di questa catena ininterrotta, invochiamo ed otteniamo, nel nostro sforzo di interpretare e vivere la Tradizione non solo equivale alla prima rivelazione, ma è anche superiore ad essa e abbraccia tutte le rivelazioni che si sono succedute da Mosè ai nostri giorni. Ma il Midrash prefigura anche lo iato che traspare fra rabbini e comunità nell'ebraismo odierno. È indubbio che il rabbinato italiano sta attraversando oggi una fase di profondo cambiamento. Si sono delineati nuovi modelli di riferimento negli studi e nelle altre attività di competenza rabbinica. C'è stato in gran parte delle Comunità un notevole ricambio generazionale: la maggior parte dei nuovi rabbini è nata dopo la guerra, non ha vissuto l'esperienza delle persecuzioni né la nascita dello Stato di Israele, e ha come modelli di riferimento realtà non soltanto italiane. Tutto ciò sta avendo conseguenze innegabili: l'ebraismo non è visto più come cultura di reazione rispetto agli stimoli, negativi e distruttivi, del mondo esterno; si tende a uscire dagli schemi del provincialismo, che è un difetto diffuso dell'ebraismo italiano. Oggi esistono oggettive possibilità di scambio di esperienze con rabbini ed educatori di altri paesi; si riconosce l'importanza centrale dello studio della Torah. Tutto questo crea anche delle tensioni, in particolare per quel che riguarda l'osservanza delle mizvot e l'adesione all'Halakhah.
2. L'Halakhah come elemento fondante.
Dal punto di vista concettuale, nel momento in cui ci si riferisce alla Torah intesa nella sua accezione più ampia, ognuno può scegliere la sua strada. Basta ricordare la conclusione celeste alle discussioni tra la scuola di Hillel e la scuola di Shammai: «queste e quelle sono le parole del Dio Vivente. Ma l'halakhah è secondo la scuola di Hillel.» la norma di comportamento, e non solo l'etica e la storia, è ciò che permette di chiamare ebraismo quel fenomeno di cui stiamo parlando. L'etica, innanzitutto, non è certo retaggio esclusivo del popolo ebraico. Che ebraismo è quello che non riconosce l'halakhah come elemento fondante? È possibile considerare l'halakhah un elemento di valore pari alla storia, alla memoria, alla tradizione? Io ritengo l'halakhah il punto di partenza; certo non l'unico elemento su cui si fonda l'identità ebraica, ma sicuramente il punto di partenza. Credo che l'halakhah sia la garanzia della stessa pluralità di aspetti garantita dall'ebraismo e nell'ebraismo; certamente non la negazione di questi. Se si vuole individuare fra i vari aspetti dell'ebraismo un momento unitario, e non solo in prospettiva storica o etica, si deve trovare un qualche punto di incontro nella prassi. Credo che anche questo ritornare più volte sul concetto di pratica vista come forma vuota sia da approfondire, anche in termini puramente semiotici: nessuna pratica - ovvero nessun segno - può mai essere vuoto, perché inevitabilmente veicolo di significato; il contrasto tra contenuto e forma, tra dentro e fuori, non mi sembra essere uno schema di interpretazione ebraico degli avvenimenti e delle azioni. L'interiorizzazione pura e semplice della Torah altro non è che la sua abolizione, ed è esattamente ciò che propugnarono tutte quelle correnti antinomistiche (il Cristianesimo, il Sabbatianesimo e, più tardi, la Riforma) che finirono poi tutte per distaccarsi dall'ebraismo. Presentare l'ebraismo come un complesso di valori, implica a mio avviso un altro errore: l'ebraismo è una realtà collettiva: un uomo non può essere ebreo in quanto individuo a sé; egli è viceversa ebreo in quanto appartenente alla comunità del popolo che vive la Torah. La conoscenza, la percezione, i valori, appartengono a una dimensione generalmente suggestiva, che non lascia necessariamente spazio al rapporto collettivo e prescinde dalla necessità della comunicazione e dell'interazione. Quel che è percepito dal singolo è realtà soggettiva, e non è oltre tutto comunicabile agli altri, poiché il linguaggio non è coestensivo con i sentimento, e non sa comunicare emozioni e percezioni. Su concetti, percezioni e sentimenti non si può fondare il senso della collettività, che si attualizza invece nella sfera dell'azione e della realizzazione comuni, ossia nella prassi oggettivata delle mizvot. C'è un racconto riportato in un libro di Elie Wiesel, "Contro la malinconia" che narra: «Quella note rabbi Meir di Peremyzljany era solo con Rebbe Arie' suo amico. Il maestro meditava, Rebbe Arie' recitava i Salmi. Fuori scendeva la neve, le strade parevano solchi. Il villaggio dormiva sotto il cielo che riluceva. A mezzanotte, Rabbi Meir sospirò e, secondo la Tradizione, si sedette per terra a piangere sulla distruzione del Tempio e a lamentare l'esilio di Dio da un'eternità all'altra. Nella stanza c'era freddo, ma Rabbi Meir non lo sentiva; il suo pensiero l'aveva tratto altrove. Nel silenzio del suo cuore mormorava: "Fai presto Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe; la tua pazienza non è più una virtù; noi tuoi figli siamo allo stremo. Guardaci, siamo estenuati, piegati dalla fatica, fiaccati. Fai qualcosa, Signore. Se non per noi, fallo per amore del Tuo Nome..." All'improvviso Rabbi Meir si irrigidì: bussavano alla porta. Rebbe Arie' impallidì: "Chi è, amico o nemico? Un emissario del diavolo o la sua vittima?" "Apri!" ordinò Rabbi Meir "Ma non sappiamo chi è!" "Apri ti dico!" "Ma, Rabbi, se è un ubriaco che vuole farci del male?" "Apri, forse è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Un marito in ambasce, un padre disperato, un prigioniero un fuga, che aspetti ad aprire?" Rebbe Arie' aprì, e si trovò di fronte un sodato che in yiddish chiese il permesso di entrare. "Ho fame," disse. Rabbi Meir si precipitò in cucina e tornò con pane e latte che posò sulla tavola. Il soldato mangiò in silenzio. "Dimmi" fece Rabbi Meir, "sembri affamato. in caserma non ti danno d mangiare?" "Oh, sì." "Ma allora?" "Semplicemente il loro cibo non fa per me. Io sono ebreo, capite? Mi hanno arruolato di forza quando ero ancora bambino. Non aveva avuto il tempo di imparare cosa un ebreo deve o non deve fare. So soltanto che un ebreo deve mangiare kasher. Perciò dovunque passi il mio reggimento cerco una casa di ebrei per mangiare kasher, per ricordarmi che sono ebreo." Rabbi Meir turbato si avvicinò alla finestra e contemplò la neve che piano piano seppelliva il villaggio. Taceva, poi sospirò e disse: 'Arie', amico mio, ascolta, un giorno verrà il Messia, è sicuro. Ma verrà grazie a chi? Grazie a Meir? No! Grazie a te, forse? Nemmeno! Verrà grazie a questo soldato che bussa alle nostre porte per ricordarci chi siamo.» Anche secondo il racconto scelto da Wiesel, la pratica delle mizvot è il segno tangibile della volontà di rimanere collegati all'ebraismo attraverso l'azione. L'halakhah continua quindi a rappresentare il limite, la soglia fra un ebraismo che è cultura e vita, fra un ebraismo proiettato nel futuro e un ebraismo che si rifugia eccessivamente nella contemplazione del proprio passato.
3. Rabbini e tradizione nella Comunità italiana.
Io credo che le tradizioni proprie della nostra storia non possano essere considerate soltanto folklore: esse hanno un valore storico, di identità e, non ultimo, legittimazione halakhica. Ma, sempre in virtù della non rigidità dell'halakhah, non possiamo individuare nella tradizione italiana un valore assoluto e fondante al solo scopo di crearci un alibi per la nostra mancanza di studio della Torah e delle fonti della nostra cultura. Quello italiano si è ridotto a un ebraismo troppo etico e storico, ma privato del legame con quello che è il suo testo originario. È su questo poi che si gioca il vero confronto tra l'ebraismo italiano attuale e gli altri ebraismi del mondo. Nel pianeta dei media è impensabile l'isolamento: sarebbe un atto di presunzione che potrebbe comportare l'emarginazione dall'ebraismo mondiale. E, d'altra parte, i grandi Maestri dell'ebraismo italiano tra questo e l'altro secolo (Margulis, Chayes, Elborgen) sono la cifra dello sforzo cosciente che fece quell'ebraismo, di mantenere una valenza europea non restando ancorato ai miti del passato (Shadal, Reggio, Benamozegh). L'ebraismo italiano è in gran parte assimilato, ma soprattutto ignorante, pur con varie sfumature e distinzioni, dei propri fondamenti culturali e religiosi, perfettamente in linea con un'identità mascherata che continua a vivere tranquillamente nel compromesso tra un'ortodossia di facciata e un riformismo di prassi, tra un conservatorismo di idee e una sostanza evanescente. Rav Menachem Emanuele Artom, z.l., nel 1976, in un articolo sulla R.M.I. dal titolo "Tentativi di riforma in Italia e analisi del fenomeno nel presente", scriveva: «...Gli ebrei italiani, vivendo in un ambiente cattolico e non protestante, quale era per esempio la maggioranza della Germania nel secolo scorso, sono stati più inclini a trovare naturale che la vita del "clero" fosse diversa da quella del laico, cioè non chiedeva riforme alle norme tradizionali, che magari era bene, anche a parer suo, che fossero seguite più o meno scrupolosamente dai "preti" (rabbini), mentre per se stesso, che non faceva parte del clero, non avevano più valore le innumerevoli regole religiose che trasgrediva, senza cercare a ciò nessuna giustificazione teologica o ritualistica. In realtà, ci si poteva allontanare da quell'osservanza che però si teneva a lasciare intatta. Basti pensare come le Comunità hanno continuato a dichiararsi fedeli alla corrente così detta "ortodossia", e anche, praticamente, hanno mantenuto questa linea in gran parte, mentre i singoli nella grande maggioranza non seguono né una linea ortodossa, né una linea riformata...». È indubbio che la vittima principale di questa ambiguità, frutto dell'illusione emancipazionistica coltivata e caldeggiata dall'alta borghesia ebraica italiana, è stato proprio il rabbino, che ha visto minata la sua identità, delegato il più delle volte a ricoprire un ruolo a cui non veniva più riconosciuto alcun valore o significato. Nascosti dietro il luogo comune per cui "l'ebraismo ognuno lo interpreta a suo modo", comodo quanto banale, buona parte dell'ebraismo italiano sta andando alla deriva nell'inconsapevolezza, nell'ignoranza e nella confusione. Io non credo che l'ebraismo debba essere di un solo tipo, magari ortodosso e fondamentalista (accusa spesso rivolta con frettolosità e cattiva coscienza a quei rabbini che svolgono il loro istituzionale operato). Credo però che sia doveroso essere quello che si è consapevolmente e su basi culturali ed esistenziali meditate. Questo all'ebraismo italiano, nella sua maggioranza manca. Non si è mai affrontata culturalmente e concettualmente in maniera seria questa questione, lasciando che l'ebraismo italiano mostrasse così un volto diverso da quello suo vero. Siamo e non siamo ortodossi? Qual è il nostro rapporto con le forme tradizionali di studio della tradizione ebraica? Cosa intendiamo quando parliamo di Torah: cultura, etica, norma, oppure quello che gli ortodossi chiamano Torah? È chiaro quindi che persistendo in questa pericolosa mistificazione, il rabbino diviene inevitabilmente non solo un esecutore e un testimone solitario di un sistema di vita estraneo ai più, inascoltato predicatore di scomodi doveri ed elargitore di "dispense" da obblighi rituali, ma sarà sempre più svilito alla funzione di un intransigente e insensibile gendarme. D'altronde, l'alternativa sarebbe quella di un notaio compiacente, strumentalmente interpellato per legittimare e avallare consolidate abitudini - talvolta in pieno contrasto con l'halakhah - in nome di una malintesa antica tradizione.
4. Guardiani o Maestri della Legge?
C'è un racconto di Kafka (inserito ne "Il Processo") che mi sembra possa essere preso come simbolo di una certa condizione di molti ebrei oggi: «Davanti alla legge c'è un guardiano. Davanti a lui viene un uomo di campagna e chiede di entrare nella legge. Ma il guardiano risponde di non poterglielo permettere per il momento, forse in seguito, e gli spiega che la legge è un susseguirsi di stanze davanti alla porta di ognuna delle quali c'è un diverso e terribile guardiano. Impressionato, l'uomo decide di attendere finché non gli verrà concesso di entrare. Dopo una inutile e interminabile attesa, quando sente che le forze lo stanno abbandonando, l'uomo trova il coraggio di chiedere al guardiano come mai, se tutti tendono verso la legge, nei lunghi anni che ha passato davanti alla sua porta nessun altro è mai venuto a chiedere di entrare. Anche il guardiano si rende conto che l'uomo sta per morire, e così gli dice: "nessun altro poteva entrare qui, perché questo ingresso era destinato soltanto a te, e ora io vado a chiuderlo"». Ecco: spesso siamo come l'uomo di campagna, ci fermiamo all'esterno di quella porta che è l'entrata della nostra specifica "strada ebraica." Aspettiamo lì una vita, affascinati e al contempo distaccati dalla luce della Legge, ma restiamo fuori, in attesa che le difficoltà che ci pone il guardiano (è per noi un guardiano, purtroppo, piuttosto che un Maestro), si risolvano da sole. E invece la sfida da raccogliere sarebbe proprio quella di oltrepassare la porta, nonostante le apparenti difficoltà. Sta a ciascuno di noi conquistarsi la Legge che è retaggio collettivo comune, superando gli ostacoli, a volte fittizi, che ci separano da essa. Sono ostacoli interiori che manifestano la loro presenza piroettando all'esterno altri ostacoli, distanze e porte sprangate. Bisogna allora sforzarsi di cercare la chiave che apra le porte che ci conducono alla Legge, cercando di vedere davanti a noi Maestri e non guardiani... Ciò dipende anche dai Maestri che non devono presentarsi come guardiani, che sappiano spogliarsi dei loro abiti ufficiali, che siano capaci di parlare alla gente, di rispondere a domande e siano aperti al dialogo e non solamente a lezioni ex cathedra. I rabbini devono mostrare la massima disponibilità verso tutti gli stimoli di qualsiasi provenienza, soprattutto sul piano dell'umano dialogo, ed è loro compito far capire che si può far cultura con Torah e Talmud, almeno tanto quanto con la Letteratura e la Filosofia. È compito del rabbino essere rabbino di tutta la Comunità, anche se questo non è solo compito suo, poiché spetta ai dirigenti della Comunità creare i presupposti affinché il rabbino sia il Maestro di tutti, e ciò in termini di servizi religiosi e culturali anzitutto. Compito del rabbino è quello di applicare l'halakhah con coscienza e intelligenza, anche se ciò non deve significare necessariamente morbidezza, e soprattutto amplificazione di ciò che la gente vuol sentirsi dire. Ma è il compito della Comunità favorire e sostenere il rabbino, e non solo formalmente, nel fissare e nell'adottare gli standard di applicazione dell'halakhah nella Comunità stessa, anziché l'inverso, non senza che si tenga conto nei rapporti con il pubblico, della clausola talmudica per cui non si può imporre più di ciò che il pubblico può reggere (Talmud babilonese, Bava' Batra' 60b). Se non si è d'accordo su questo ruolo del rabbino come Maestro di Halakhah, egli può essere tranquillamente rimpiazzato da un tecnico del culto e da un dotto professore di ebraistica. E allora si arriva al problema della rispettabilità dei Maestri e dei rabbini, nella loro capacità di far vivere l'halakhah; penso che anche su questo si debba in qualche modo riflettere: interpretare l'halakhah e farla vivere, può essere inteso in tanti e diversi modi. Da un parte c'è la tradizione che si concretizza, ad esempio, nella produzione di "sheelot utshuvot" - "responsa" che, con criteri di derivazione giuridica uniti ad una effettiva conoscenza del mondo moderno e delle problematiche dell'uomo, dà risposte normative ed esistenziali al contempo: dall'altra c'è l'abbandono del concetto di halakhah stessa, per giungere a qualche cosa d'altro. A questo punto deve essere dato il giusto rilievo: è infatti vero che, secondo la Tradizione ebraica: "Kocha' dehettera' 'adif...", "la capacità di permettere è preferibile..."; e cioè il bravo rabbino non è quello che dice sempre di no, ma colui che riesce di dire di sì; è chiaro, tuttavia, che il sì va ricercato all'interno della Tradizione dell'Halakhah, e non al di fuori di essa, influenzati da pure esigenze contingenti. D'altra parte, credo che se le decisioni, anche "impopolari" o difficili, vengono motivate con chiarezza ed onestà, chi rigetta la via dell'halakhah non solo propone una soluzione su misura a un problema personale, ma chiede di fatto al rabbino di essere ciò che egli non è. Risposte praticabili possono essere di vario genere, forse dipende anche da quanto è rigida e talvolta precostituita l'aspettativa di chi pone la questione, da quanto quest'ultimo è veramente aperto ad ascoltare e ad apprendere. I dirigenti comunitari dovrebbero rivedere quel frequente atteggiamento di malcelata "antireligiosità" in nome di un universalismo laico che svuota di universalità quello stesso ebraismo in nome del quale si intende operare. Non è sufficiente, per quanto importante, sostenere e garantire la continuità ebraica in occasione di convegni e riunioni pubbliche, considerandola invece, nell'intimo, un'attività speciale da delegare e scaricare a qualcun altro. Quando la cultura ebraica rimane essenzialmente passiva, non frequentemente vissuta, un'esperienza vissuta da spettatore, o un semplice processo di conoscenza, finisce col divenire irrilevante perfino banale quando viene paragonata alla cultura dominante in cui viviamo.
5. Lo studio come sfida all'estinzione.
Nel Talmud babilonese, Temura' 16a, si racconta che il giorno del lutto per la morte di Mosè, vennero dimenticate tremila halakhot. Fu chiesto a Giosuè: «Chiedi aiuto allo spirito profetico per ritrovarli!» Ma lui rispose: «La Torah non è in cielo...» Fu chiesto a Samuele: «Chiedilo tu!» ed egli rispose: «nessun profeta ha più il diritto di rinnovare la Torah!». La stessa richiesta fu rivolta a Pinechas e a Eleazar; tutti risposero allo stesso modo e conclude il Midrash che l'enigma delle tremila halakhot dimenticate sussiste ancora ai nostri gironi. Secondo Rav S. R. Hirsch, questo ci insegna che solo la Chochmah, e non la Nevuah, cioè lo studio basato sul testo e sulla tradizione e non lo spirito profetico, hanno valore nei confronti degli insegnamenti e dell'essenza della Torah. Anche l'ebraismo italiano ha dimenticato molte halakhot, e nessun profeta e nessun rabbino con la bacchetta magica potranno restituirci le halakhot dimenticate, ma solo lo studio. Lo studio come superamento della lettera: solo in questo modo è ammessa quella polivalenza esegetica dello stesso versetto, dello stesso personaggio biblico e perfino dello stesso evento fondatore. Lo studio della Torah come possibilità umana e non come privilegio, come assunzione di responsabilità e non come diritto acquisito. Lo studio e la conoscenza della Torah non sono valori di natura che l'ebreo trova a sua disposizione, bensì sono valori che l'ebreo deve conquistarsi e coltivare con amore e con umiltà, spesso anche con grandi sacrifici, come quello del nostro grande Rabbi Akiva', colui che, nel nostro primo Midrash, ha superato Mosè il primo Maestro del popolo ebraico. Pensate: proprio lui, un convertito all'ebraismo. Possiamo allora comprendere quel drammatico e terribile Midrash che spiega perché il nostro patriarca Isacco prediligeva Esaù a Giacobbe. Malgrado da Esaù discendano Amalek, Haman, l'impero romano e tanti altri terribili nemici del popolo ebraico, è proprio dalla stirpe di Esaù che nascerà Rabbi Akiva'. Isacco nella sua cieca preveggenza aveva intuito tutte le sofferenze che sarebbero derivate da Esaù, ma l'acquisizione al popolo ebraico di un Talmid Chacham come Rabbi Akiva', dice il Midrash, vale anche le grandi sofferenze che dallo stesso Esaù sarebbero scaturite. Quindi a noi ebrei italiani accettare la stessa sfida: ricominciamo a studiare.
Rav Roberto Della Rocca.
Cliccando sull'immagine puoi leggere «Le radici del presente», dialogo fra un Rabbino e un Filosofo.