| introduzione innovazione pt.1a innovazione pt.2a innovazione pt. 3a |
Riflessioni sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica
Interventi su il Sole 24 Ore
Parte IIa: Elementi per una politica della ricerca e dell’innovazione
2.1 Perché la ricerca va fatta in azienda
Tra Stato e impresa: un rapporto da rivedere
In Francia il governo Mitterrand punta su un ambizioso programma di rilancio della ricerca con un obiettivo di destinarvi il 2.5% del Pnl, oltre il 50% in più delle risorse attuali. Molti sono gli scettici sull’effettiva possibilità di far crescere così rapidamente le spese per la ricerca senza peggiorare di molto l’efficienza e mantenendo una ripartizione equilibrata tra i vari settori applicativi e la ricerca di base.
Le difficoltà economiche, a partire dalla seconda metà degli anni '70, sono state certamente responsabili della riduzione o del non aumento delle spese di ricerca in rapporto al Pnl. Tuttavia vi è stata anche una certa delusione da parte degli ambienti economici per via della sensazione di una riduzione della produttività delle spese di ricerca. Un libro di Orio Giarini e Henry Loubergé, pubblicato in Francia nel 1979, ha un titolo molto eloquente: La civiltà tecnica alla deriva: i rendimenti decrescenti della tecnologia.
Diciamo anzitutto che il problema se l'intensità di ricerca sia così alta da doversi preoccupare di possibili rendimenti decrescenti di un aumento delle risorse destinatevi, non è un problema italiano: se in Italia l'intensità di ricerca è di 4 addetti alla ricerca per ogni 1000 di popolazione attiva, in Francia e Germania siamo ad 8 e negli Usa 12. Tuttavia val la pena di approfondire la discussione.
Fiducia o «grandeur»?
Innanzitutto, ha senso parlare di «produttività della ricerca»? Ricordiamo che la produttività è data dal rapporto tra la quantità di beni prodotti e la quantità dei fattori di produzione - capitale, lavoro - necessari per produrre tali beni. Per tutte le attività del terziario sì pone il problema di come misurare i «beni» prodotti. La ricerca è una tipica attività di servizio. Come si fa allora a parlare di rendimento decrescente della ricerca se non si può misurare il prodotto della ricerca stessa?
Qualcuno ha tentato di avere delle indicazioni per lo meno qualitative. Secondo il rapporto settoriale nell'industria farmaceutica dell'Ocse del 1980, su 195.000 composti esaminati dalle autorità sanitarie all'anno, 100 sono accettati, 15 arrivano sul mercato, ma solo 3 permettono di realizzare dei profitti che coprano gli investimenti fatti. Nel passato il successo della ricerca, misurato dal rapporto 'prodotti di successo ai prodotti proposti, era più alto.
Il rilancio francese è dunque un'azione isolata, controcorrente e all'insegna di una riscoperta «grandeur», oppure è il segno di un ricupero di fiducia generale nella tecnologia?
Prima di tentare una risposta, sarà opportuno fare una sintesi delle argomentazioni esposte da Giarini e Loubergé. L'ipotesi che si sia in presenza di un rallentamento nel progresso tecnologico sarebbe una conseguenza anzitutto di una diminuzione del tasso di successo della ricerca in termini di innovazione tecnologica come nei casi sopra illustrati. Questa diminuzione sarebbe legata alla complessità crescente dell'attività e delle strutture dí ricerca e del sistema scolastico che aumenta l'età media dei ricercatore, al di là dell'ottimo per la creatività. Una seconda causa sarebbe l'aumento dei tempi intercorrenti tra la ricerca e l'invenzione e tra l'invenzione e l'innovazione.
Vi sono poi fattori esterni che contribuiscono alla riduzione dell'efficacia globale della tecnologia. Lo stesso successo tecnico dell'innovazione che ha ridotto la quantità di lavoro e di capitale per produrre, ha portato ad aumentare enormemente la produzione, il che richiede più risorse per organizzare la produzione e per distribuire il prodotto e quindi porta ad una riduzione dei rendimento economico dell'innovazione. Inoltre la diffusione del prodotto e delle fabbriche per produrlo ha raggiunto soglie di densità tali per cui si manifestano diseconomie esterne, legate all'inquinamento fisico ed alle inefficienza nell'uso (ad esempio intasamenti nel traffico).
L'accenno alle «diseconomie esterne» rende necessario esaminare il problema della produttività in generale e non solo per la ricerca. A livello aziendale è semplice calcolare la produttività come rapporto tra quantità prodotta e costi totali. Quando si cerca di valutare la produttività a livelli più aggregati macro-econonúci, la contabilità non è più così semplice. Vi sono anzitutto delle risorse (infrastrutture, ecc.) che la comunità mette a disposizione dell'attività produttiva che è difficile contabilizzate ripartendole tra di esse. Si è inoltre, da qualche decennio, posta enfasi sulla necessità di conteggiare anche gli effetti negativi legati all'attività produttiva. Per una parte di questi effetti negativi, ad esempio per l'inquinamento delle fabbriche, si è sviluppato il principio di chi inquina paghi e quindi si interiorizzano i costi nell'azienda. La produttività definita a livello aziendale in questo caso si riduce per i conseguenti aumenti dei costi. Ma per altre parti delle diseconomie esterne non è possibile agire così semplicisticamente sia perché gli effetti sono indiretti o spostati nel tempo. La comunità accetta quindi di prendere a proprio carico questi effetti.
L'intervento pubblico
Per quanto riguarda l'attività di ricerca si può fare un discorso simmetrico ma di segno opposto. L'attività di ricerca produce degli effetti positivi, delle «plus-economie» esterne, solo una parte delle quali può essere «interiorizzata» nella contabilità aziendale. Per aumentare la parte interiorizzabile, la contabilità aziendale ha da tempo imparato, ed il fisco lo accetta, a tener conto che non tutta l'attività della ricerca eseguita nell'anno dà risultati utilizzabili nello stesso anno. Parte delle spese di ricerca escono dal conto economico per venire capitalizzate nello stato patrimoniale.
Tuttavia più la ricerca deve guardare lontano, minore è il successo conteggiabile nel breve termine e maggiori sono le difficoltà per l'azienda di «interiorizzare» tutte le spese di ricerca. Poiché si è dibattuto a lungo sul concetto che l'attività produttiva genera diseconomie esterne, è ora che si parli con altrettanta enfasi delle «plus-economie» e dell’importanza di generare quel patrimonio di conoscenze, di idee, di brevetti, di tecnici preparati che derivano dall'attività di ricerca sia interna che esterna all'azienda.
La collettività, per la parte non interiorizzabile aziendalmente, deve farsi carico dei costi per creare questo patrimonio, così come si fa carico di altri investimenti infrastrutturali. In effetti, in quanto nel terziario pubblico vi sono università e laboratori di ricerca, la collettività fa questo da sempre o quasi. Vi sono tuttavia due osservazioni importanti:
·
Una riguarda la intensità delle risorse destinate alla ricerca. Vi è certamente una soglia minima per un paese industriale che si debba confrontare con gli altri. L'Italia, come abbiamo indicato sopra, deve incrementare notevolmente le risorse per la ricerca per entrare nella media europea.·
Ma vi è un secondo punto molto importante e riguarda l'efficienza dell'attività di ricerca nel senso non solo dell'elevata creatività ma di una elevata capacità di trasferimento in innovazione tecnologica. Per massimizzare, in un mondo ad alta intensità di ricerca, questa efficienza di trasferimento, una parte crescente di risorse di ricerca deve risiedere all'interno delle aziende produttive.Ma l'azienda non può interiorizzare tutti i costi relativi e si rivolge quindi all'intervento del finanziamento pubblico. Anche questo è ormai un fatto acquisito anche nei paesi meno favorevoli all'intervento dello Stato.
In un momento di crisi generalizzata, quando da tutte le parti si richiede l'intervento dello Stato, chiedere un maggior intervento dell'incentivazione pubblica per la ricerca privata sembra poco originale. Tuttavia, per quanto sopra detto, vi è una netta distinzione da fare.
Un patrimonio comune
L'intervento della collettività per prendersi carico di una parte delle spese della ricerca aziendale ha una giustificazione precisa compatibile con una concezione liberistica dello Stato moderno
. L’attività di ricerca aziendale contribuisce infatti, con le «plus-economie» esterne alla creazione di quel patrimonio di cui tutta la collettività beneficerà. Poiché non tutti i risultati possono venire conteggiati a favore dell'azienda, non è da meravigliarsi che non tutti i costi vi siano contabilizzati.Torniamo ora alla domanda iniziale, se vi sia contraddizione tra la decisione francese ed il presunto rendimento decrescente della tecnologia.
Come abbiamo visto non ha molto senso parlare di produttività della ricerca perché, oltre che essere difficilmente misurabili, i risultati vanno suddivisi tra quelli visibili a breve e quelli che contribuiscono a creare un patrimonio sfruttabile nel futuro. La ripartizione tra le due categorie varia nel tempo. Vi sono dei cicli di sfruttamento dell'attività creativa con picchi di innovazione dopo periodi di lento accumulo di invenzioni.
Proprio quando a livello aziendale minore è la parte contabilizzabile dei risultati della ricerca, maggiore è allora la necessità di intervento della collettività per assicurare che l'intensità dell'attività di ricerca non ne abbia a risentire.
da Il Sole 24 Ore, 5 Ottobre 1982
2.2 Un iniezione di camici bianchi per rilanciare la ricerca
Perché lo Stato dovrebbe incrementare le attività di R&S nelle aziende
Il sistema ricerca è certamente molto complesso e legiferare per favorirne lo sviluppo al servizio del Paese non è certamente facile. Il legislatore italiano sembra quasi impotente rispetto a questa complessità. Quando il legislatore riesce a varare leggi con contenuti innovativi, come la 46/82 sul Fondo Innovazione e sulle nuove disposizioni per il Fondo lmi Ricerca Applicata, allora sono i criteri, le delibere, le normative di applicazione che hanno difficoltà ad emergere. Immagino il senso di frustrazione dei politici più impegnati nel varo delle leggi, di fronte alle difficoltà di predisporre i successivi meccanismi di attuazione. Oppure, de mininis non curat praetor?
Ma è poi così difficile isolare i problemi rilevanti della ricerca e per ognuno di essi varare leggi chiare, applicabili senza necessità di chiarimenti successivi e interpretazioni a livello dell'esecutivo? Vorrei lanciare al riguardo una piccola sfida, cercando di illustrare nella brevità dello spazio di queste colonne,
una proposta di intervento legislativo con tutti gli ingredienti necessari per la sua formulazione e applicazione per un problema che considero prioritario.Innanzitutto l'obiettivo. L'intensità di ricerca in Italia misurata in numero di addetti alla ricerca per mille di popolazione attiva, varia dalla metà ad un terzo di quella degli altri Paesi industriali. Nel ventennio '60 - '80 vi è stata una crescita indubbia degli addetti alla ricerca. Prendendo come riferimento il decennio 1963-73, che termina con la crisi del Kippur, la crescita negli addetti totali alla R&S è stata di circa il 60%. C'è da chiedersi se sia possibile in questi anni di crisi generalizzata, ricuperare tassi di crescita paragonabili, per far sì che il Paese si trovi meglio piazzato come patrimonio di risorse umane ad affrontare gli anni novanta.
L'obiettivo che proponiamo è l'aumento nei prossimi cinque anni del 50% della popolazione degli addetti alla R&S. L'intervento legislativo che proponiamo per incentivare il raggiungimento di detto obiettivo è limitato alla R&S svolta nelle imprese. Negli enti pubblici (Università, Cnr, ecc.) lo Stato può intervenire con strumenti più diretti per raggiungere un obiettivo del genere.
In termini assoluti si tratta di creare 25.000 posti di lavoro in cinque anni per la R&S nelle imprese, nei ruoli scientifici e tecnici (esclusi gli amministrativi). Detta cifra può essere così ripartita: 5.000 laureati tecnici, 12.000 diplomati tecnici, 8.000 ausiliari tecnici.
Una prima osservazione: non vi dovrebbero essere difficoltà a coprire detto fabbisogno con l'offerta di neo-laureati, neo-diplomati e giovani con diploma di scuole professionali nell'arco di 5 anni, tuttavia la dimensione è tale da rappresentare un forte contributo al problema della disoccupazione giovanile in Italia.
Secondo punto: quale onere per lo Stato? L'intervento deve essere, in questa condizione di crisi economica, fortemente incentivante. La proposta è che lo Stato copra i costi diretti (stipendio ed oneri sociali) per ogni neo-assunto per 5 anni dalla data di assunzione. Inoltre copra le spese di formazione iniziale e fino a un dato massimale, i costi per l'acquisto di apparecchiature scientifiche ed attrezzature di laboratorio e prove per favorire il lavoro di ricerca. Le assunzioni potranno venir fatte entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge. L'arco temporale di validità della legge sarebbe di 10 anni (5 anni per l'assunzione e 5 anni successivi per i benefici relativi al personale assunto il quinto anno).
In termini quantitativi, a valori 1982, si può parlare di 150 milioni per oneri di formazione iniziale, stipendi ed oneri sociali nell'arco di 5 anni, e 50 milioni per acquisto di apparecchiature, per ogni neo-assunto. Quindi 5000 miliardi a carico dello Stato da spendere su un arco di 10 anni (con un picco di spesa al quinto anno, pari a circa 1000 miliardi). E' una cifra non indifferente. Tuttavia misurata sulle spese pubbliche attuali di ricerca (2800 miliardi nel 1982) richiederebbe un incremento di meno di 1/3. Siamo ben al di sotto dei programmi di incremento di Paesi come la Francia, che partono da una intensità di ricerca doppia della nostra.
Terzo punto: il meccanismo dell'intervento. Deve essere automatico, senza necessità di fare proposte, ottenere approvazioni iniziali, ecc. Un meccanismo del genere potrebbe essere il credito di imposta sugli utili dell'impresa. Sugli utili e non sulle altre imposte (ad esempio Iva), purché nelle aziende in crisi profonda la ricerca può fare ben poco nel breve termine e difficilmente vi troverà un ambiente stimolante. Tuttavia, per tener conto di variazioni a breve sui risultati aziendali, il credito di imposta che non fosse del tutto esigibile nell'anno di esercizio, per mancanza o livello basso di utile, può essere ricuperabile in esercizi successivi nell'arco dei 10 anni di durata della legge.
Quarto punto: le condizioni per ottenere i benefici della legge. L'azienda che intenda avvalersene dovrà notificare, ciò al Ministro della Ricerca, fornendo informazioni sulla formale esistenza di una unità di R&S, indicandone l’inquadramento nell'organigramma aziendale, con nomi del responsabile ed addetti. Non occorre risposta, basta la ricevuta di ritorno fiscale. Al termine di ogni esercizio l'azienda invierà al ministero della Ricerca il resoconto delle spese sostenute che rientrano nei dispositivo di legge ed un breve riassunto delle attività di R&S cui il per sonale nuovo assunto è stato assegnato. Di nuovo, nessuna approvazione è richiesta, salvo quella di avvenuto invio.
Eventualmente il Ministero delle Finanze, in collaborazione con quello della Ricerca potrà formare un piccolo nucleo di ispettori specializzati. La certezza del diritto sarà un elemento importante e le uniche clausole sono legate, come già detto, alla esistenza formale di una unità di R&S (non al contenuto dei suo programma di attività) ed alla congruità delle spese per formazione e per investimenti fissi (tipologia apparecchiature). L'azienda non è obbligata a mantenere per 5 anni il personale neo - assunto nelle unità di R&S, ma in tal caso scade il diritto al credito fiscale relativo. Le sanzioni contro i contravventori possono essere quelle della legislazione fiscale normale. La legge porrà dei limiti all'intervento. Anzitutto la dimensione minima dell'unità di R&S preesistente (5 di-; pendenti tecnici, eventualmente riducibili a 3 per una P.M.A.) e I’incremento massimo di personale per anno (20% l'anno) e cumulabile sull'arco di validità della legge (50% elevabile a 100% per P.M.A.).
Quinto punto: cumulabilità con altre incentivazioni. L'azienda che ricorrendo ai dispositivi della legge proposta prende a suo rischio la creazione di nuovi posti di lavoro nella R&S, deve poter mantenere il diritto a tutti gli altri interventi previsti dalla legislazione vigente, in particolare il ricorso al Fondo Imi per la Ricerca Applicata, conteggiando anche le spese dei personale neo-assunto.
da Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 1982
2.3 Una serra per il prototipo
Il confine tra ricerca e produzione rischia di diventare «terra di nessuno»
E' importante sperimentare l'innovazione tecnologica prima che il sistema produttivo si impegni senza riserve alla sua utilizzazione. Parliamo di una zona di transizione tra la ricerca e la produzione che in alcuni casi rischia di avere le caratteristiche di terra di nessuno.
Il rischio è minore quando la responsabilità di portare avanti la sperimentazione dell'innovazione è nelle stesse mani di chi produce per il mercato finale il prodotto che dovrebbe includere la soluzione innovativa. Ad esempio, consideriamo il caso di un'azienda chimica dai cui laboratori di ricerca sia venuta la proposta per innovare il processo produttivo di un prodotto già esistente (nel cui mercato l'azienda ha una solida posizione). Il processo decisionale è chiaro, con una prassi normale di esame e valutazione della proposta per decidere se passare o meno alla realizzazione dell'impianto pilota che ha appunto il compito di sperimentare l'innovazione, sciogliendo le riserve sia sul costo che sull'affidabilità dei nuovo processo.
Analogamente, nel caso di un'azienda automobilistica, prima di passare agli impegni di investimento per un nuovo modello vi è tutta una fase estremamente complessa e costosa di realizzazione di lotti di vetture sperimentali, contenenti varianti di disegno e soluzioni tecniche e della loro sperimentazione nelle più estreme condizioni di esercizio. In alcuni casi, come recentemente la Fiat per un nuovo cambio a variazione continua del rapporto, l'azienda può addirittura consegnare un certo numero di vetture prototipo a dei clienti per sperimentare la reazione dell'utente all'innovazione.
Il rischio della terra di nessuno cresce invece quando l'innovazione riguarda un prodotto o componente intermedio. In questo caso l'azienda potenzialmente produttrice del componente non si lancerà nella sperimentazione dell'innovazione se non otterrà garanzie sul mercato dall'azienda cliente. Quest'ultima difficilmente si impegnerà se non potrà disporre di lotti del componente innovato da sperimentare su isole dei prodotto finale. Poiché l'investimento nella realizzazione degli impianti prototipi può non essere indifferente, si arriva facilmente ad un circolo vizioso ed alla perdita di opportunità di innovare.
Due casi chiariranno meglio il problema.
Consideriamo dapprima il caso di un nuovo materiale che può migliorare le prestazioni del prodotto finale: per esempio i nuovi ceramici ingegneristici per applicazione in turbine e motori. Dai laboratori di ricerca risulta chiara la potenzialità innovativa. Tuttavia occorre sperimentare il materiale su larga scala e conoscerne non solo l'affidabilità, ma anche costi ed effettive prestazioni. Chi assume l'onere ed il rischio di realizzare un impianto pilota per produrre prime serie di componenti in tali materiali? L'azienda acquirente dei componente o l'azienda fornitrice? Teniamo presente che spesso la ricerca di laboratorio sul materiale è stata fatta nel grande centro di ricerca dell'industria responsabile dei prodotto finale e non nella piccola industria fornitrice del materiale. Vi è quindi anche un problema di trasferimento dell'idea da un'azienda all'altra.
Il secondo caso esemplificativo riguarda l'uso delle nuove tecniche di intelligenza artificiale elaborate nelle università o nei grandi laboratori di ricerca per analizzare i linguaggi naturali. Queste tecniche possono, ad esempio, essere trasferite per diagnosticare se un meccanismo complesso come un motore o un veicolo è o no in perfette condizioni di salute, attraverso l'analisi dei «linguaggio» che emette il meccanismo (rumorosità. vibrazioni, ecc.). L'ipotesi innovativa passa attraverso realizzazioni molto costose di prototipi di apparecchiature e una sperimentazione di messa a punto sul problema specifico. L'azienda produttrice di strumentazioni analoghe è di solito troppo piccola per affrontare le spese di progetto. Inoltre non sempre ne vede l'opportunità.
Questa terra di nessuno può diventare una opportunità per nuovi imprenditori per entrare nel mercato.
In un Paese come gli Stati Uniti in cui non solo lo spirito di imprenditorialità è diffuso, ma vi è anche forte disponibilità di capitale di rischio, il nuovo imprenditore facilmente è impersonato dallo stesso ricercatore che esce dall'università o dal grande centro di ricerca industriale dove ha avuto l'idea.
L'esperienza mostra che il 90% delle iniziative è destinato al fallimento, ma il rimanente 10% ripaga la comunità per il resto.
C'è da chiedersi se esista la possibilità in un Paese come il nostro, di favorire la spinta imprenditoriale di quelli che potremmo chiamare Laboratori della Transizione SpA.
La legge per il rifinanziamento del Fondo Imi per la Ricerca Applicata ha previsto novità come il contratto di ricerca ed automatismi di interventi nel caso di ricerche svolte per conto di piccole e medie aziende.
Vorremmo mettere sul tavolo dei ministro della Ricerca la problematica suddetta per tenerne conto. Ad esempio il mercato delle produzioni «prototipali» e delle «piccole serie» di componenti sperimentali per gli ipotizzati «Laboratori della Transizione SpA», sarebbe facilitato se si potesse fare affidamento su una procedura rapida, con interventi prefissati (percentuale di fondo perduto e massimale di finanziamento) per proposte presentate assieme dai «Laboratori della Transizione» e dall'industria cliente per realizzare prototipi e prime serie, purché la proposta risponda ad un «capitolato standard» che assicuri la potenzialità innovativa e la novità dell'applicazione.
Da Il Sole 24 Ore, 18 Luglio 1982
2.4 L’incentivazione pubblica della ricerca e le P.M.A.
Una Proposta
Le varie forme di intervento pubblico, sia a livello nazionale che comunitario, per incentivare la sviluppo della attività di R&S industriale ed il trasferimento dell'innovazione tecnologica prevedono, di regola espressamente, delle priorità a favore delle P.M.A., Tuttavia, a fronte di un evidente impegno politico di favorire le P.M.A., é spesso difficile sviluppare degli strumenti adatti per attuarlo.
Il fatto, ad esempio, di riservare una quota delle cifre disponibili per
l'incentivazione pubblica (come nel Fondo IMI per la Ricerca Applicata) per le
P.M.A., di per se non assicura che queste ultime siano in grado di avvalersene
con facilità. Il problema di fondo da risolvere, riguarda la difficoltà di
accoppiare meccanismi burocratici centrali - che per loro natura richiedono iter
identici sia per progetti di grandi dimensioni che per progetti piccoli - con
una realtà varia, diffusa, decentrata e di piccola mole, caratteristica delle
P.M.A. L'iter richiesto, sia per le carte da preparare ma soprattutto per i
tempi di attesa, é spesso tale da scoraggiare l'utilizzazione dei dispositivo
esistenti.
Per ovviare a questi inconvenienti, si é pensato di sviluppare degli
automatismi come ad esempio il rimborso (previsto dalla legge n° 46/1982) del
50% delle fatture pagate da P.M.A. a Centri e laboratori di ricerca per
attività di R & S svolti loro incarico. Il tempo impiegato per dare pratica
attuazione a questo tipo di automatismo conferma la difficoltà di gestire
centralmente il rapporto tra P.M.A. ed interventi di incentivazione pubblica
della ricerca.
Il problema si presenta anche per altre politiche di incentivazione, ad esempio per quanto riguarda la promozione degli investimenti. La B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) per risolvere il problema ha sviluppato uno strumento particolare, quello del "contratto globale". La B.E.I. per arrivare facilmente alle P.M.A., delega ad istituti bancari speciali il compito di attuare le sue politiche di prestito attraverso, appunto, dei contratti globali tra la B.E.I. e l'Istituto. Nel contratto globale è fissata sia la cifra totale disponibile per l'insieme dei progetti, sia le regole per la accettabilità dei progetti (delimitazione dei settori, deI tipo di intervento: ad esempio per il risparmio energetico, ecc.). L'Istituto, per la sua presenza locale e diffusa, assicura anzitutto che il tipo di intervento disponibile venga percepito dagli interessati. Per la delega che gli è stata data può assicurare di espletare rapidamente le pratiche per la concessione di prestiti, con modalità non diverse da quelle note agli operatori industriali locali nei loro normali rapporti con il sistema bancario.
C'è da chiedersi se questo esempio del contratto globale B.E.I. non possa servire per sviluppare strumenti equivalenti nel campo della incentivazione pubblica della R&S e del trasferimento innovativo. Benché non sia da nascondere che il problema si presenta più difficile, non fosse altro per la difficoltà - ben superiore a quelle per investimenti produttivi - di delimitare nelle condizioni del contratto globale le modalità delegate per l'intervento a favore di progetti di R&S e di trasferimento innovativo.
Tuttavia la rilevanza del problema fa sì che valga la pena di approfondire, per risolverle, quali siano le difficoltà relative.
Per mostrare che dovrebbe essere fattibile
realizzare una procedura analoga, un contratto globale per un programma quadro, descriviamo a titolo indicativo, una possibile procedura.Uno dei tanti enti creati a livello regionale per aiutare le P.M.A. nei problemi di trasferimento delle tecnologie (si faccia riferimento ad esempio al CESTEC sorto per la collaborazione tra la regione Lombardia e I'Assolombarda o all'ERVET in Emilia) prepara, sulla base delle conoscenze che ha del tessuto industriale locale e delle esigenze relative di ricerca e di innovazione, una proposta quadro che descrive il tipo di programma (di R&S, di trasferimento tecnologico, di dimostrazione, a secondo dei casi), ed in quanti diversi casi specifici esso verrebbe realizzato sulla base di contratti da stipulare - se il programma quadro verrà accettato - tra l'ente ed altrettante P.M.A. operanti nella regione di competenza. La proposta viene presentata, a seconda dei casi, al Fondo IMI per la Ricerca Applicata, ad uno dei programmi di R & S Cee (ad esempio al programma BRITE recentemente approvato per la ricerca tecnologica di base), al Programma Dimostrativo Energia Cee, o altro. Al termine dell'iter di valutazione della proposta, se essa é accettata, viene firmato un contratto quadro sulla base del quale l'ente proponente si impegna a realizzare il programma quadro stipulando dei contratti specifici con varie aziende. Il controllo della adeguatezza e rispondenza agli obbiettivi stipulati nel contratto quadro verrà fatta dall'ente erogatore dei Fondi (IMI, Cee ed altri) in sede di erogazione dei fondi ad avanzamento lavori. L'ente locale pertanto si assume il rischio di vedersi non approvati contratti che non rispondano agli obbiettivi ed ai requisiti del contratto quadro.
Fin qui la procedura formale. E' però fattibile in pratica fissare un capitolato quadro per tanti progetti di ricerca simili, ma non ancora definiti? In generale, sarebbe difficile dare una risposta affermativa. Il problema si presenta tuttavia in modo più semplice se ci si limita a casi di interesse delle P.M.A. Qui infatti gli obbiettivi di R & S sono prevalentemente legati alla applicazione di risultati di ricerca già noti, adattandoli ai casi di specifico interesse. Ad esempio, si può trattare di diffondere l'applicazione di nuovi materiali in prodotti diversi, ma appartenenti ad uno stesso settore merceologico. Oppure, diffondere l'applicazione di tecnologie "pulite" al posto di tecnologie inquinanti, estendere l'uso di tecniche CAD/ CAM a settori fornitori di altri (ad esempio nell'indotto auto), e così via.
L'esercizio di preparare proposte di programma quadro che rispondono ai particolari obbiettivi del programma di ricerca o dimostrazione cui l'incentivazione pubblica é connessa (ad esempio i progetti dimostrativi per la conservazione energetica promossi dalla Cee) è un occasione per gli enti regionali di promozione del trasferimento tecnologico, per approfondire l'indagine sul tessuto industriale peculiare del territorio. Ed in questa indagine preliminare, l'ente avrà modo di assicurarsi che se il programma verrà approvato, vi saranno aziende interessate ad applicazioni particolari, e quindi a proporsi come contraenti in fase di attuazione. Il rischio che il programma non venga attuato nella sua globalità - e quindi che tutti i fondi riservati a tal fine non siano utilizzati - non é molto diverso dal rischio che una grande impresa rinunci strada facendo a portare a termine la ricerca per cui ha avuto i finanziamenti.
La difficoltà della proposta risiede invece nelle procedure esistenti, sia per il Fondo IMI che per i programmi di R&S e di dimostrazione C.E.E. che non prevedono la possibilità di deleghe del tipo descritto dei "contratti globali" o dei "contratti quadro". In attesa che si possano modificare dette procedure (il che può richiedere interventi legislativi), si potrebbe procedere in via provvisoria in modo diverso, L'Ente locale di trasferimento tecnologie potrebbe farsi promotore di raccogliere delle specifiche proposte di programma - aventi una certa omogeneità di settore e di tipo di intervento - preparate da singole aziende e farsi carico di presentarlo in modo omogeneo e di curare l'iter burocratico per l'insieme di dette proposte, riducendo così l'onere alle singole aziende, e l'effetto negativo di lontananza tra la periferia, diffusa e piccola, e la burocrazia centrale.
Perché non provare fin d'ora in occasione della pubblicazione delle richieste di proposta per programmi Cee di R&S?
Testo per premiazione AIRI del libro R&SxP (20/12/84).
2.5 Ricerca: forse più che i soldi sono necessarie le idee
Anche gli scienziati hanno delle responsabilità
Vi è una certa tendenza quando si parla di ricerca a mettere l'enfasi sulla scarsità delle risorse che ad essa sono destinate. Da parte dei ricercatori che accusano i politici di non comprendere bene l'importanza e la priorità della ricerca, ma anche da parte di chi ricercatore non è. Forse per una certa reverenza verso un mondo che poco si conosce, ma che ha certamente molto condizionato negli ultimi due secoli la nostra esistenza. C'è da chiedersi pertanto se, nel caso del mondo politico, si sia di fronte ad un atteggiamento ipocrita, a quello che gli americani chiamerebbero "lip service" (parliamone, parliamone bene, ma poi occupiamoci di cose più serie).
In realtà se si guarda da vicino quanto è successo negli ultimi decenni si
ha l'impressione che le risorse destinate alla ricerca siano in qualche modo
proporzionali alle richieste, quando queste sono state espresse in modo
esplicito. E' stato questo il caso, a partire dagli anni 50, dell'energia
nucleare, dei programmi di fisica sub-atomica e piùrecentemente dei Progetti
Finalizzati CNR.
Questa affermazione può sembrare paradossale. Certamente, nel breve termine, vi
sono stati ritardi nelle decisioni di stanziamenti di fondi. Ma guardando un po'
più da lontano, quanto è stato chiesto su base di una motivazione dettagliata
alla fine è stato stanziato.
Il problema va quindi, almeno in parte, spostato verso il mondo stesso della ricerca, chiedendoci quale sia il "portafoglio di idee" elaborate e proposte dalla ricerca e rimaste inevase. Parliamo di "portafoglio di idee" a tutti i livelli: da quello della ricerca di base,alla ricerca applicata, allo sviluppo.
Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del ricercatore, proiettato in avanti alla scoperta di nuove conoscenze o alla soluzione di problemi complessi spesso mal definiti, in cui quindi la creatività è la regola più che l'eccezione, c'è da aspettarsi un portafoglio stracolmo di idee e proposte. Ma è questo veramente il caso?
Sarebbe interessante un'indagine quantitativa che, ad esempio, per la ricerca universitaria indagasse in dettaglio la ripartizione delle attività tra le principali discipline scientifiche importanti per lo sviluppo di un paese industrializzato. Non vi è stata forse una eccessiva localizzazione su alcune aree più alla "moda" scientifica, o se si vuole più di frontiera, rispetto ad altre più vecchiotte, ma non per questo meno ricche di prospettive per gli sviluppi di applicazione? In proposito, va notato un fenomeno interessante degli ultimi decenni, l'apparire di nuove discipline scientifiche, che in realtà sono la combinazione di discipline esistenti a due a due: biologia e chimica combinate in bio-chimica, elettricità ed acustica in elettro-acustica, idraulica, pneumatica ed elettronica in servosistemi, e cosi via.
Non è da nascondersi che le responsabilità della ricerca sono grandi se il Paese lamenta carenze importanti nei settori scientifici da cui dipende il nostro sviluppo tecnologico industriale.
Non sarebbe male se il mondo della ricerca iniziasse dal suo interno un esame di coscienza al riguardo. Non sembrano tuttavia molti i segni in questa direzione, perché vi è una certa tendenza a giustificare la carenza di attività in settori importanti della ricerca con la mancanza di pianificazione generale, di obiettivi posti dal mondo esterno alla ricerca stessa. Quindi è colpa del pianificatore - sia esso pubblico o privato, rappresentante degli interessi economico-sociali generali del paese, o quelli settoriali industriali - che non ha definito gli obiettivi e le scelte fondamentali sulla base delle quali destinare risorse sufficienti.In effetti vi è stato negli ultimi decenni una convinzione generale che i problemi di una società sempre più complessi vanno affrontati con una pianificazione estesa sia in senso temporale (breve e lungo termine) sia settorialmente. Vi era convinzione che fosse possibile con un approccio razionale partendo dallo studio generale dell'evoluzione della società e dei fabbisogni, definire prima obiettivi generali per poi da questi, per trasformazioni successive, obiettivi via via sempre più specifici fino ad arrivare appunto alle scelte delle aree più rilevanti per lo sviluppo per la ricerca applicata, per la ricerca di base.
L'insuccesso in generale, e non solo per l'Italia, della pianificazione cosi intesa (come un processo dall'alto verso il basso) ha spinto a rivedere queste convinzioni cercando di capire, nei casi dove vi è stato successo, quali siano stati i veri meccanismi. Se pianificare significa intervenire sul naturale sviluppo di un sistema (sia esso il più generale sistema socioeconomico, o sistemi più limitati come ad esempio quella della produzione e della relativa connessione con l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo) per modificarlo verso la direzione "gradita", si scopre che pianificare significa soprattutto applicare una scelta, una "selezione", tra le molte alternative di sviluppo sempre presenti e in competizione tra loro in un sistema complesso.
Più sono queste alternative e migliore può essere la scelta. Come analogia si può pensare all'evoluzione biologica ed al ruolo della "creatività" dovuta al "caso" nel generare cambiamenti ("mutazioni") che poi l'ambiente seleziona. Nell'evoluzione biologica le mutazioni che non siano letali vengono accumulate in "serbatoi" di potenziale cambiamento (il DNA) per poi venire selezionate quando se ne presenta l'opportunità. Nel caso dell'innovazione tecnologica è importante che i "serbatoi" della ricerca (di base, applicata, sviluppo di pre-industrializzazione) siano pieni quando il fabbisogno sociale o settoriale emerge e la pianificazione può operare delle scelte.
La grande responsabilità della ricerca, che non può essere delegata ad altri è di assicurare una creatività continua ed estesa a tutti i settori importanti. La società deve certo favorire l'esistenza e lo sviluppo con una dimensione adeguata dell'attività di ricerca. La coscienza di questa necessità non può essere tuttavia sviluppata in astratto, ma sulla base della spinta delle idee che la ricerca ha nel frattempo accumulato. Le difficoltà operative, burocratiche, di incomprensione od altro, che il ricercatore può sentire attorno a sé, non deve per questo trasformarlo in un rinunciatario e comunque non elimina le sue responsabilità, per uno sviluppo armonico del Paese.
Per fare un esempio prendiamo il caso della ricerca universitaria. La rigidità delle sue strutture è certo una remora ad un approccio aperto e flessibile alla ricerca, alla capacità di gestire risorse crescenti tecniche e finanziarie. Tuttavia non sempre è necessario attendere riforme legislative per un più efficiente modo di fare ricerca. Creatività "organizzativa" è stata già mostrata nel passato dai ricercatori italiani. Un esempio è rappresentato dai Gruppi Nazionali di Ricerca sorti per meglio gestire i rapporti tra i ricercatori di una certa area disciplinare (ad es. Struttura della Materia) e la distribuzione delle risorse destinate alla ricerca dal CNR. Associazioni di persone senza fini di lucro sono state fatte per permettere la collaborazione, a fianco dell'Università, tra professori di varie discipline su un tema di comune interesse "interdisciplinare". Si può citare il caso a Torino del Centro Studi Sistemi.
Con determinazione e buona volontà molto si può ancora fare.
Da Il Corriere della Sera, 12 luglio 1983
2.6 Un «gap» tra università e impresa
Perché la ricerca universitaria subisce il fascino della frontiera e disdegna l'industria. Il personale docente non è incentivato a lavorare su progetti di utilizzo pratico immediato
Da più parti e da più tempo si insiste sulI'importanza per l'Italia di aumentare la intensità di ricerca, misurata in termini quantitativi (ad esempio le spese di R&S rapportate al Pnl) per cercare di allinearsi sulla media dei Paesi industrializzati. Ma c'è un altro problema su cui è molto più difficile dare suggerimenti concreti: quello del miglioramento dell'efficienza e della qualità della ricerca.
Si è parlato molto nel passato - e sembra se ne riparli ora - del problema della fuga dei cervelli all'estero, che ha in parte impoverito la capacità di tenere elevato il livello di insegnamento e ricerca all'università. Tuttavia ben più danno ha prodotto un altro tipo di fuga: dai problemi di ricerca rilevanti per la realtà dei nostro Paese.
Il danno in questo caso è maggiore per due motivi: il primo, che il contribuente italiano sostiene le spese per ricerche di frontiera troppo lontane dalla nostra capacità di utilizzazione; e il secondo, che i giovani più promettenti vengono attratti dal fascino della frontiera e disdegnano l'idea di occuparsi ad esempio di ricerca applicata nelle vecchie discipline della meccanica, della termo-tecnica e via discorrendo.
Per le persone più dotate, rimane certamente la soddisfazione personale di contribuire allo sviluppo delle conoscenze a livello mondiale e il contributo all'immagine del Paese.
Tuttavia sembra legittimo chiedersi se non sarebbe più utile, per noi stessi e per la comunità, che ricercatori di capacità media si dedichino a problemi magari meno «à la page» scientifica, ma di più pratico interesse.Per inciso, si può notare che è tutt'altro che scontato che i temi di rilevante pratico interesse non siano altrettanto stimolanti e difficili da risolvere di quelli alla frontiera di discipline scientifiche. Anzi, vi è una vera e propria sfida al riguardo, che la ricerca industriale per settori cosiddetti maturi, come quello automobilistico, sta lanciando all'Università.
Il fenomeno sopra accennato, di fuga verso la frontiera delle conoscenze, è particolarmente rilevante nelle facoltà scientifiche. In altri casi si tratta forse di semplice accademismo: l'autoporsi i problemi da risolvere secondo logiche interne alla carriera accademica.
Cosa si può fare per ridurre il distacco tra Università e realtà? Come definire quali sono i problemi rilevanti per il Paese, per l'attività produttiva e per i fabbisogni sociali?
Non è possibile individuare questi problemi senza una stretta interazione tra l'Università e la «domanda» di ricerca, sia essa esplicita od implicita. Purtroppo in questi ultimi anni si è assistito ad un peggioramento nel rapporti tra mondo esterno ed Università, anche nelle facoltà di regola più vicine ai problemi pratici, quelle di Ingegneria ed i Politecnici. Sembra quasi che I'Università, e la ricerca universitaria in particolare, tema di venire «inquinata» dai problemi pratici, i quali minerebbero la purezza e la libertà della ricerca di base.
Inoltre, quale incentivo esiste per il personale universitario ad occuparsi di problemi di interesse pratico, per risolvere i quali la «domanda di ricerca» pone non solo obiettivi tecnici, ma anche obiettivi temporali, cerca scorciatoie utilitaristiche, si accontenta dei «buono abbastanza», e così via? Chi se ne occupa deve avere pertanto spirito missionario. Ma poiché difficilmente tale spirito viene riconosciuto, spesso egli è ripagato col sospetto di interessi personali particolari.
Nel passato gli introiti derivanti da contratti e convenzioni con enti privati si trasformavano in parte in premi ed incentivi al personale che lavorava su tali ricerche. Anche l'insegnamento di corsi, aggiuntivi a quello cui il personale docente era tenuto, venivano, sia pure di poco, remunerati. La legislazione introdotta negli anni '80 ha voluto dare un taglio netto a situazioni forse in parte equivoche, ma che permettevano qualche flessibilità. Un docente da allora deve scegliere tra il tempo pieno (cioè in pratica non dedicarsi ad altro che agli impegni formali di insegnamento) ed il tempo «definito». In quest'ultimo caso si tratta chiaramente di un contratto di impiego a tempo parziale, che lascia libertà di svolgere attività di tipo professionale all'esterno.
Se si confronta la differenza di ore formali di impegno nei due casi (350 contro 250) essa è abbastanza modesta, tanto che sembra lecito porsi una domanda. O la differenza tra le ore formali di insegnamento e le ore di un normale calendario lavorativo (40-50 ore settimanali) è necessaria per l'attività (non formalizzata, ma comunque parte integrante del «contratto» di lavoro) di preparazione all'insegnamento, di ricerca e di partecipazione alle attività gestionali, oppure si può parlare di un effettivo impiego a tempo parziale in tutti due i casi, con la differenza di avere autorizzato il professore a tempo definito ad esercitare attività professionale in proprio.
Sviluppiamo qui l'ipotesi che l'impegno di base per l'attività di insegnamento, di studio e ricerca connessi, sia un impegno a tempo parziale uguale a quello dei professori che hanno optato per il «tempo definito». Si pone allora il problema di come utilizzare il tempo rimanente. La dicotomia attualmente prevista, tra il dedicarlo ad attività di ricerca interne (docente a tempo pieno) ed attività esterno private, sembra troppo semplicistica.
Innanzitutto l'Università ha bisogno, come qualsiasi altra organizzazione, di «managers» che assicurino le funzioni direttive (rettori, presidi di facoltà, direttori di dipartimento, ecc). Perché non riconoscere questa attività come saturante, per chi la svolge, il tempo rimanente rispetto a quello base, e remunerare adeguatamente chi è chiamato a svolgerla?
Chi è dotato di genuine capacità di svolgere attività di ricerca (ricordiamo che questa capacità varia non solo da persona a persona, ma anche con gli anni) ha diritto a chiedere all'Università che gli venga riconosciuta una remunerazione aggiuntiva per questa attività. Tuttavia la sua attività di ricerca dovrà poter venire «verificata» attraverso non solo i normali strumenti utilizzati dalla comunità scientifica (numero e qualità delle pubblicazioni) ma anche attraverso uno sforzo preventivo di programmazione da parte dell'interessato, che dovrà presentare al Senato Accademico un esplicito programma (o agenda di ricerca). Ciò permetterebbe tra l'altro di assicurare una certa «persistenza dell'attività di ricerca e di delineare i «filoni» di ricerca per i quali una certa università si distingue dalle altre. I docenti più dotati di spiriti applicativo potranno utilizzare, come già fanno, il tempo rimanente per attività esterne all'Università. Nel caso di verifica negativa circa l'attività di ricerca, il docente dovrebbe venir trattato alla stregua di chi ha scelto il tempo definito.
E tra i due estremi? Ed in particolare per quelle discipline scientifiche per cui è meno facile sviluppare lavori da consulente professionista? Non vi è forse qui una notevole potenzialità di utilizzare questo surplus di capacità, a costi marginali, per risolvere problemi di rilevanza pratica, in particolare per un Paese come il nostro così poco ricco di risorse tecniche? E' qui che deve intervenire la capacità organizzativa dell'Università.
Potremmo al riguardo considerare l'Università come per metà svolgente un ruolo di servizio sociale (insegnamento e sviluppo conoscenze) e per metà impresa che opera nel mercato della richiesta dei servizi applicativi (di insegnamento e di ricerca). In parte l'Università ha sempre risposto ad una domanda proveniente dai privati o dai pubblici. Basti pensare ad esempio ai corsi accelerati e specialistici di ri-orientamento di tecnici in nuove tecnologie.
Per svolgere la prima funzione (il servizio sociale) è utilizzato il tempo base del personale docente, dei ricercatori e tecnici, il tempo di ricerca di chi ha così scelto, oltre al tempo per i compiti gestionali. Le spese relative sono coperte dallo Stato. L'università invece può fungere da imprenditore rispondendo alla domanda di mercato, utilizzando il resto del tempo dei personale dipendente.
Il personale che non abbia scelto l'alternativa del tempo pieno per la ricerca (o per il quale l'alternativa non venga accettata per carenza di risultati) potrà ottenere dall'Università specifici incarichi, retribuiti di volta in volta in funzione delle prestazioni, volte a soddisfare la domanda esterna o di formazione specialistica o di ricerca applicata, o di consulenze a pubbliche amministrazioni, e così via.
Tutto questo richiede che l'Università sviluppi delle capacità imprenditoriali, innanzitutto di «promozione vendita» come ogni altro centro di ricerca per conto terzi e come fanno le Università americane. Diventa pertanto fondamentale riconoscere uno «status» specifico ai docenti che svolgono funzioni manageriali, che dovranno venire utilizzate anche per questo scopo.
Il successo di «vendita» è legato allo sviluppo di linee specialistiche di ricerca in modo da attrarre, per l'eccellenza e la specializzazione, domanda di servizi. E, quindi, l'attività va pianificata e programmata con persistenza, identificando la domanda specifica. La parte di attività di servizio sociale non potrà che beneficiarne. E' ovvio che l'Università dovrà essere in grado di riconoscere i propri genuini talenti per la ricerca di base, e su questi fare affidamento per il servizio sociale di sviluppo delle conoscenze. Inoltre la «persistenza in filoni di ricerca» sopra ricordata, rappresenta un «punto di forza» per la vendita di ricerche e servizi all'esterno, caratterizzando una università rispetto alle altre.
E' attuabile in Italia una schema come quello sopra delineato? Diciamo anzitutto che la legislazione introdotta negli anni '80 ha ridotto anche quel poco di possibilità di remunerare attività didattiche «applicative». Mi riferisco alla regolamentazione per le Scuole di Specializzazione, per i Corsi di Perfezionamento, per le Scuole a fini Speciali. L'attività didattica al riguardo, è sostitutiva di quella svolta per i corsi normali di laurea, fino al completamento delle ore formali di impegno. Quindi nessuna possibilità o incentivo per chi volesse dedicare parte dei suo tempo a corsi brevi di perfezionamento.
L'ipotesi fatta è quindi controcorrente. Tuttavia la domanda di interventi applicativi all'Università sta crescendo, come dimostrano anche il successo dei corsi brevi di perfezionamento e il tentativo di utilizzare le capacità di ricerca universitaria nell'ambito dei Progetti Finalizzati CNR.
E la domanda da parte aziendale? Sarebbe interessante sperimentare l'effetto sull'utente-impresa di una decisa promozione, con caratteristiche imprenditoriali (e con gli impegni relativi), da parte dell'offerta universitaria.
Potrà l'autonomia universitaria aiutare a realizzare tutto ciò?
Da Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 1983
2.7 Che fatica innovare nella CEE
Ancora troppi Paesi della Comunità escludono i servizi dal raggio di azione delle loro strategie economiche. Per essere più efficace la politica industriale non può ignorare i problemi dei settori e dei prodotti "maturi"
L'Europa sta perdendo terreno nella sua capacità di innovare le proprie attività produttive rispetto agli USA e Giappone? E l'Italia come si classifica rispetto agli altri paesi? Sono domande cui non è semplice dare una risposta, perché il concetto di innovazione non si presta ad una definizione del tipo tutto/niente. Chi denuncia la perdita di capacità innovativa in Europa si riferisce, spesso senza esplicitarlo, ad innovazioni tecnologiche di tipo radicale riguardanti i prodotti o i processi produttivi.
In realtà quando si parla di innovazione non ci si deve limitare al puro aspetto tecnologico degli oggetti "fisici" prodotti e del modo di produrli. Si può parlare di innovazione anche per i servizi, per le tecniche organizzative. Inoltre, vi é tutta una gradazione di intensità innovativa che và dall'innovazione radicale o "break through" al miglioramento.
Visto che il dibattito sull’innovazione e sulla politica migliore per spronarla non cessa di essere attuale, può valer la pena di soffermarsi su cosa vada inteso veramente per innovazione. La Commissione Cee ha commissionato uno studio sugli l'ostacoli all'innovazione nei paesi della Comunità europea, al francese A. Piatier.
Il rapporto fa una analisi articolata della definizione della attività innovative, e propone una matrice che classifica l'innovazione distinguendo ben 308 casi. (La tabella in figura è una versione semplificata con solo 126 casi). Un tale numero di casi possibili é cosi alto che a prima vista si é tentati di respingere l'analisi come un esercizio accademico di non rilevanza pratica. Sarebbe tuttavia una reazione troppo frettolosa. Se il fenomeno della innovazione è complesso, una eccessiva semplificazione é restrittiva ed impedisce di capirlo. Un primo punto fondamentale é quindi quello di cercare di classificare il fenomeno, cercando naturalmente di individuare, ove esistano, possibilità di aggregare gerarchicamente i casi per una comprensione sintetica che non sia sovra semplificazione. Vediamo di riassumere l'analisi di Piatier.
I criteri base per classificare una novità sono tre: il grado di "intensità" della novità, la sua "estensione" (geografica e settoriale), il suo "campo di applicazione" (non solo prodotti e processi, ma anche le altre funzioni aziendali come le procedure organizzative, ed i prodotti "immateríali", come i servizi forniti dal terziario.
Piatier, aggiornando un famoso studio di C. Freeman sull'innovazione, propone cinque gradazioni nella "scala di novità": novità radicale, novità, design, miglioramento e perfezionamento, combinazione nuova di vecchi elementi. Il sesto gradino é non-innovativo e si riferisce all'uso di tecniche antiche o tradizionali, incluso la banale imitazione.
La scoperta della penicillina rappresenta una novità radicale. Lo sviluppo di un film fotografico in bianco e nero senza sali di argento é una novità. Una vettura di forma aerodinamica particolarmente spinta rappresenta una innovazione di design. Al livello del miglioramento e perfezionamento si possono citare le modifiche in un prodotto per facilitarne l'uso. Infine é innovazione la combinazione di tecniche note per farne un prodotto nuovo, come ad esempio l'uso di plastica, colla, e segatura per fare dei pannelli.
Per quanto riguarda "l'estensione", una novità può essere assoluta se appare per la prima volta a livello mondiale. E' relativa quando appare in un paese, dopo essere già stata sviluppata in altri. E’ monosettoriale se appare per la prima volta in un dato settore. Infine si può considerare il caso della novità "trasferita da altri settori".
Si possono ora combinare i gradi di intensità della innovazione con la sua estensione, per avere tutta una serie di casi innovativi.
Si tratta ora di distinguere l'innovazione riferendosi ai campi di applicazione. L'innovazione é un insieme di attività, un processo, che partendo dalla creazione di nuove conoscenze con l'attività di ricerca, ha come obbiettivo finale il cambiamento, la novità appunto nell'attività produttiva. Per quest'ultima và inteso sia la attività che arriva fino alla "realizzazione" del prodotto che l'attività della sua "diffusione" sul mercato.
L'innovazione può riguardare "l'oggetto" stesso prodotto, il "processo" di fabbricazione, una "procedura" tecnica od amministrativa, un "servizìo", una "tecnica organizzativa".
Se la novità modifica direttamente l'oggetto venduto, essa é visibile dal cliente, altrimenti può non essere direttamente visibile. (E' da notare che, a seconda dell'azienda, l'oggetto venduto può essere un processo produttivo, od un servizio, od una tecnica organizzativa come nel caso di una azienda di consulenza aziendale. In questo caso l'innovazione risulta invece ben visibile al cliente).
Si può avere innovazione anche solo riguardo alla diffusione del prodotto, come nella "distribuzione" (se ad esempio si cambia canale o metodo di distribuzione), nel "mercato" (se ad esempio si offre lo stesso prodotto in un nuovo mercato), o nel "modo d'impiego" (ad esempio diverso modo di applicazione di un antiparassitario) o nel "bisogno coperto del prodotto" (un medicinale esistente che si riveli adatto anche per altre malattie).
Si é così ora in grado dì costruire la matrice dell’innovazione mettendo nelle linee "l'intensità e la estensione" e nelle colonne il "campo di applicazione".
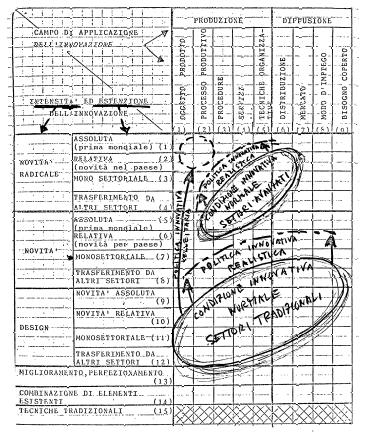 |
Ognuna delle 126 caselle nella matrice (escluso le caselle dell'ultima linea) rappresenta un caso innovativo. In generale si può dire che l'innovazione cresce salendo verso l'alto e spostandosi verso sinistra. Una "politica innovativa" deve avere per oggetto quindi la transizione verso l'alto e verso sinistra. Tuttavia, molte delle politiche pubbliche nazionali e della Comunità tendono a considerare come casi innovativi solo quelli delle due prime caselle della prima riga. Tendono cioè a fare oggetto della politica innovativa solo casi di "innovazione radicale assoluta" che riguardi "prodotti o processi produttivi". Se la realtà di un dato settore o di un dato paese é ben lontana dall'essere posizionabile all'estremo in alto a sinistra della matrice, una tale politica pubblica é velleitaria.
Il paese od il settore possono avere una buona dinamica innovativa pur non trovandosi in detta situazione. Oggetto di una politica a favore dell'innovazione é di accelerare detto processo, tuttavia tenendo conto della situazione reale di partenza. Il pericolo di una eccessiva "radicalizzazione" e "tecnologicizzazione" della visione di cosa sia innovazione diventa ancora più grande quando si voglia definire una "politica per l'innovazione" a livello comunitario.
Ciò infatti tenderà a far beneficiare degli interventi di accelerazione della dinamica innovativa solo i settori di frontiera, nei paesi che sono più attivi in detti settori. L'intervento comunitario finisce così per aumentare le "disomogeneità" tra i vari paesi.
Ma vi è un altro effetto di una tale visione semplificata della realtà industriale. Che cioè la Comunità usi i suo poteri di veto sulle politiche nazionali a favore dell’innovazione, quando si applichino realisticamente a settori che si trovano più in basso nella matrice. Vi è infatti il pericolo di interpretare detti interventi non come a favore dell'accelerazione del processo innovativo ma come "distorcenti della concorrenza".
Lo studio di Piatier é stato svolto per conto della Commissione Cee. C'é da augurarsi quindi che il messaggio circa la complessità del fatto innovativo sia stato da essa ben recepito.
da Il Sole 24 Ore, 13 Luglio 1984