AHASVERO
Riduzione teatrale di un estratto dal racconto per il web
“Il violoncello errante”, di Claudio Ronco.

Introduzione
Alle ragioni del far musica e dell’inciderla, e sul valore spirituale della musica come mezzo di conoscenza, sono dedicate molte delle pagine dei miei scritti. Fra queste, un lungo racconto che in circa trecento dense pagine indaga sulla ragione della memoria e della verità storica, interrogandosi sui doveri della testimonianza, attraverso la storia immaginaria di un violoncellista che riceve in dono il violoncello ritrovato ad Auschwitz dalle truppe americane di liberazione. A offrirglielo è un uomo che si fa chiamare Ahasvero, l’ebreo errante, e che attenderà tre anni prima di svelarne il segreto, raccontando, in quattro giornate determinanti per la carriera del giovane concertista, la leggenda di quello strumento presentata come verità storica. In questo racconto, il violoncello fu costruito nella bottega cremonese di Giovan Battista Guadagnini, quando nel 1745 uno strano uomo giunse da Livorno portando con sé del legno straordinario: quello delle travi del Tempio che Salomone edificò a Gerusalemme.
C.R.
Ahasvero! Quale veleno avevi fatto scivolare nelle mie vene? Cosa mi avevi fatto mentre cedeva la mia resistenza al sonno, e mi abbandonavo al ricevere il riposo? O mentre ero così attento, e prudente, all’ascolto di uno solo dei tuoi cuori? Quale virus insidioso avevi saputo inserire di nascosto, nelle reti del mio cervello?
Ormai ero null’altro che un automa nelle tue mani invisibili! Una dopo l’altra, ogni molecola della materia del mio corpo cambiava e s’adattava al tuo volere, come sequenze numeriche in continua trasformazione, frazione dopo frazione si sottraeva da me qualcosa, e svaniva nel nulla, mentre si moltiplicavano nuove coincidenze, dentro ai canali industriosi in cui crescevano le nuove cellule d’un essere che apparteneva sempre più soltanto alla terra: alla terra di cui tu eri il prigioniero e il condannato, non io!
Anch’io, ormai, stavo dissolvendomi velocemente, e la mia atroce metamorfosi in te era vicina! In equivalenze, in armonie ancora stridenti, ma solo per poco: già stavano allineandosi pian piano tutte le corrispondenze; e le tue cellule si legavano alle mie, s’adattavano l’una all’altra in automatismi perfetti; attendevano il loro turno appartate, rifugiate, nascoste nelle cifre ultime di quegli scarti troppo lontani dallo sguardo affrettato, distratto del mondo.
Amore? M’avevi illuso che fosse simile all’amore...
Eri riuscito a farmelo credere, riflettendo di me ciò che nessuno specchio avrebbe mai mostrato!
Specchi! Specchi in frantumi, che non la smettono mai di riflettere! Schegge di realtà sparse tutt’intorno ai miei piedi!
Infiniti abissi di cielo, là dentro...
Variegata scelta di realtà possibili... d’altro futuro...
D’altri destini! Illusioni! Incantesimi! Stregonerie!
Anch’io perduto nel limbo, in cerca dei miei frammenti scartati e gettati dalla finestra del mio edificio, nella fabbrica del mio divenire!
E il tuo amore per me era solo il tuo bisogno di un calore, di un fuoco per dare energia, per far muovere gli ingranaggi di quel tuo maledetto meccanismo!
Sì: energia, solo mera energia! Pila elettronica a due poli opposti: il vero e il falso, l’inganno e la realtà!
Chi ero diventato? Un essere anch’io di doppia natura, come fauno, metà simile al dio e metà alla bestia: ero solo un novello Marsia, ingannato dal caso di trovare un nuovo strumento musicale rigettato dagli dèi, pronto a sfidare nuovamente Apollo, a ottenere infine la sua rivincita sull’arroganza di Dio! Vincerlo, finalmente, con la forza tellurica, la bellezza struggente del NOME di Auschwitz; con le sue infinite fughe prospettiche di fascino, di abissi d’intenso piacere narrativo...
Sì, la narrazione di Auschwitz: racconto dall’effetto garantito, maestro dell’arte tragica, dove “orrore” è parola necessaria a oliare l’ingranaggio dell’emozione!
Noi, nelle nostre tiepide case!
Noi annoiati osservatori, indigenti mendicanti di storie, insaziabili divoratori di sogni altrui...
Noi leccavamo vogliosi le ultime briciole, le ultime gocce, in quella tazza che nacque per essere calice pietoso e nobilissimo!
Un calice d’oro, fuso nel fuoco del dolore.
La scodella della fame di Auschwitz, delle bucce terrose di patata, dell’acqua lurida...
Alluminio alchemico, nel fuoco bianchissimo di sangue già marcito nelle fosse. Tutta la nostra storia condensata in una briciola di pane raffermo e sporco!
Pane dell’odio!
Quanti libri erano stati scritti su Auschwitz? Quanti libri stampati e venduti nel mercato intorno al Tempio? Quale libro non ci allontanava da sé con quel senso del dejà vu, con quell’impressione del già letto, già scritto, già vissuto, già studiato, già divorato, già rigettato, già risorto, già riscritto, già ripubblicato...
Chi poteva più dire il nuovo?
Bestie! affamate di emozione, bestie malate di stress e depressione, bestie vogliose di tragedie, di libidinosi drammi, di lacrime, di sangue!
Quale cancro lentissimo si sostituisce alla nostra vera anima? Riempie il nostro inconsapevole cervello, confondendosi all’occhio fra ramificazioni sottili e belle come coralli, di capillari e arterie confezionate ad arte da demoni abili e precisi, ricamatori eccellenti della tela sottile che regge il nostro peso, nell’inganno d’un cammino sull’infìda piattaforma che hanno sospesa sopra i loro abissi!
Ahasvero, ormai m’avevi imprigionato al mio mostruoso millennio, a questa nostra era infame! Al limbo zeppo di parole babeliche, ammucchiate negli immensi magazzini della carta stampata, delle vanità letterarie! Degli slanci lirici proiettati ai soffitti irraggiungibili della nostra biblioteca universale: miliardi di miliardi di parole, vive per un’illusione di eternità, dentro a un inferno di fiamme che bruciano, eppure nulla consumano di quella materia maledetta!
E ancora là, quando ancora io avrei potuto salvarmi, correre al richiamo del vero, del giusto, io invece restai, mi ricomposi allo specchio, ritrovai i miei contorni passati, ricongiunsi le mie fratture con quel che c’era - colla di modernità industriale, di sicurezze d’un mondo ricco, d’un mondo colto, saggio, disincantato, libero - e continuai a suonare la mia nuova cornamusa alchemica, il mio violoncello di Auschwitz, errante, non ebreo, non vero.
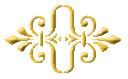
«Hans, mi sembra di impazzire! Non posso più credere a questa storia! E poi, perché a me? Perché io, che non sono ebreo?»
«Io che sono ebreo, tu che non sei ebreo... essere, o non essere... ma che vuol dire essere o non essere ebrei? Calmati, Romano... trattieniti... Che altro ti potevi aspettare?
A-usch-witz...: Auschwitz è un nome difficile da pronunciare, se solo smetti di spenderlo con leggerezza, di parlarne come fanno tutti, con tutto il suo bel contorno di frasi fatte, di buoni sentimenti...
Adesso capisci qual è stato il mio tormento per così tanti anni? Lo capisci, adesso, il mio silenzio? Il perché ho atteso tanto, prima di parlarti? »
«Sì, sì, capisco, capisco, lo so... »
«Davvero capisci? Non credo...
Io te l’ho consegnato, quel violoncello, e poi ho atteso, per vedere cosa sarebbe successo a te nel suonarlo, fintanto che di Auschwitz non ne sapevi nulla... E poi?...
Poi ti ho seguito, per osservare cosa sarebbe successo a me, agli altri, al mondo, nel sentirlo suonare da te, artista ignaro, innocente, libero...»
«Ma che m’importa di quel che volevi osservare tu?
Io da te non ho mai le risposte alle mie domande! Perché a me, se non sono ebreo?»
«Ma caro amico... l’O-lo-cau-sto... la Sho-àh...
La Shoàh non è mica una tragedia di famiglia! E perché soltanto chi è ebreo dovrebbe caricarsi del peso di questa memoria?»
«No: non voglio dire questo.
Ma perché io, che non c’entro nulla, che non so nulla di nulla... Insomma: come faccio a gemere io per quei morti? Che senso ha che sia uno come me a dargli voce?»
«E perché dovresti gemere e basta?»
«Perché? Ma dimmi tu che altro potrei fare, con quel violoncello fra le mani?»
«Perché è solo un violoncello? Solo perché un violoncello può esprimersi soltanto nel suono, e non con la parola? Ma tu, con le parole, cosa pensi di poter fare? Pensi davvero che un ragionamento, un pensiero razionale, la logica, ti aiuterebbero a dare un senso a tutti i gemiti di questo violoncello, di un oggetto costruito solo per far musica? Pura musica, e non parola?»
«Io, ormai... in quel suono... voglio dire: nel suono di quel violoncello... anche solo a ricordarne il timbro, la voce... Dio! Come faccio a non sentire lo strazio? Gli gridano dentro i gemiti, l’accusa! Le urla della rabbia, l’impotenza, il soffocarsi in gola della parola non detta, di tutte le parole che implorano pietà!...
Hans, uno come me come può vivere con questo peso addosso, senza impazzire?
E chi dovrei essere, io? Cosa dovrei diventare? Ma mi ci vedi, tu, a strapparmi le vesti a lutto, come fossi davvero un ebreo?
Hans, io non sono mai stato neppure capace a pregare... Che posso farci? Devo mettermi a gridare il dolore dell’offesa di Auschwitz come se l’avessi subito io, il martirio?
Io non sono un testimone!»
«Già... E quindi non vorresti neppure il martirio...
Sai, in greco queste due parole erano una sola: martire e testimone. È come dire: non c’era differenza, in origine.»
«Che vuoi che m’importi degli antichi greci?
Ti prego, Hans, aiutami a capire... dammi almeno una sola ragione per essere proprio io a evocare tutto questo dal legno di quel violoncello!»
«Questo? Davvero non so se posso farlo io.»
«Almeno provaci.»
«E allora ascoltami: sai cos’ero andato a fare a Torino, quel giorno d’autunno in cui ti ho conosciuto?
E perché ero proprio in quella strada?»
«Non lo so, dimmelo tu.»
«Ero lì, proprio in quella strada, perché volevo provarmi a recitare lo Shemà Israél di fronte alla casa in cui era vissuto lo scrittore ebreo, il sopravvissuto che più mi aveva turbato: Primo Levi.»
«Santo cielo, Hans! Cosa vorresti dire, con questo “provarti a recitarlo”, come se la preghiera dello Shemà fosse nient’altro che una bella poesia?
Gli ebrei religiosi, tutti, lo recitano ogni giorno. Ma per precetto, per confermarsi nella loro fede...
Ogni giorno: coricandosi e alzandosi; dovresti saperlo bene.»
«Lo so, ma io, in gioventù, non sono stato una bella persona, Romano, non lo sono stato affatto. E se ti prende il rimorso... ebbene, l’unica cosa che riesci a pensare è a come liberartene.»
«Che vuoi dire? Che hai fatto, in gioventù?»
«Tu vorresti sempre tornare ad essere innocente, pulito, e magari diventare un giusto, un santo. Ma nessuna preghiera riesce a farti sentire diverso, a darti almeno l’impressione di aver fatto qualche cambiamento.
Per tutta una vita hai esercitato il tuo cuore a non farsi sollecitare, hai abituato la tua mente a non rispondere al richiamo dell’altro, del tuo simile.
Per quanto ti provi e riprovi a pregare, più preghi e più il suono della tua preghiera ti rimbomba dentro sordo, inutile... Ti scheggia l’anima, ti frantuma i pensieri.
E finisce col farti vedere bene cosa sei, e su che misera cosa si reggono le tue conoscenze, i tuoi ricordi, le tue percezioni; capisci che tutto ciò che fai, tutto quel che pensi, fuori dalla tua animalissima natura, è sempre insufficiente, incompleto, instabile...»
«E questo cosa c’entra con Torino e Primo Levi?»
«Io ero nella città della sua culla e della sua tomba, nella strada del suo palazzo, di fronte alle sue porte. Per quattro giorni avevo camminato avanti e indietro, sempre lì intorno, in quel maledetto freddo. Fissavo a vuoto il portone di casa sua, senza riuscir a pensare.
Poi scivolavo via, vergognoso per tutto quel tempo buttato alle ortiche. E camminavo, camminavo spedito, senza distrazioni, senza rallentamenti, fino alla grande sinagoga. Là me ne restavo muto, a contemplare quelle cupole a cipolla in stile orientale, neo-moresco, squamate in verde e giallo dalla fantasia errante dell’eclettico architetto...»
«La conosco. Parlami di te, non della sinagoga!»
«Camminavo: prima per linee rette e veloci, poi per spirali sempre più vertiginose; mi muovevo come sulle caselle di una scacchiera immaginaria, nella mappatura squadrata dell’antico Castrum romano... Guardavo, contemplavo la Mole dell’Antonelli, quell’immenso miraggio di conquista dell’emancipazione e della libertà: il primo grande Tempio israelitico dell’Italia dei Savoia! Chissà quale buffo destino l’aveva innalzata in quel modo così maldestro, così ridicolo?
Una cupola immensa, spiovente come un’ampia gonna da signora fine Ottocento, e sopra, al posto del busto, solamente quella sottile, lunghissima spina nerastra conficcata dentro al cielo!»
«Abito lì vicino, Hans... la conosco benissimo...»
«Quelli erano i resti di un progetto rifiutato a metà della sua edificazione, quando gli operai erano già arrivati proprio in cima alla grande “gonna” alla moda.
I committenti avevano cambiato idea: avevano deciso di farsi costruire un Tempio più discreto, più prudente, meno vistosamente trionfale.
Ed erano quei signori dai volti intelligenti, ma comuni, con alti cappelli a cilindro in testa, che alle cinque del pomeriggio del venerdì salutavano educatamente i loro operai con un democratico “ciaréa!” per recarsi a benedire il pane e il vino del sabato nelle loro belle case signorili, con le mogli eleganti, ben pettinate, che già avevano acceso le candele di Shabbàt, preparato i figli coi vestiti della festa, e una ricca cena con la challà.
Carlo Alberto li aveva integrati, premiati, rassicurati...»
«Hans, li aveva solo illusi!»
«Può darsi, però nel Tempio c’era un piccolo Aròn, l’Armadio Santo in cui si conservano i rotoli della Legge, ed era dipinto tutto in nero, in segno di lutto per quel Re illuminato che aveva “fatto l’Italia”: Carlo Alberto di Savoia, “che Iddio lo benedica!”
Ah, sì, certo: il male poteva ancora rigenerarsi, ma ora era tempo di vivere, di innalzare glorie e lodi a Dio con le fanfare di organi maestosi e trombe egizie, e l’orchestra di violini e arpe, e salmodiare col grande coro maschile, le donne separate solo dalle altezze di un matroneo aperto e luminoso. E poi, su tutto il solenne incedere del canto, si sollevavano ancora squarciando i cieli, facendo tremare la terra, gli acuti degli Schofàr, i corni del capro offerto sul monte dove Abramo era salito, al culmine del supremo sacrificio, alla prova più alta della fede nel suo Dio...
Un Dio geloso, che pure non aveva preteso il sangue d’Isacco...
E la voce del Rabbino si alzava commovente, col tono squillato e vibrante dei grandi Tenori dell’epoca, con l’emozione, il singhiozzo, la spinta del celebre Tamagno, articolando con torniture maestose le punte e gli apici delle sillabe nella lingua santa, la lingua del Dio unico:
“Shemà Israél! Adonài Elohènu, Adonài echàd!”...»
«Sì, la conosco: “...Ascolta, Israele!
Il Signore è il tuo Dio, il Signore è Uno...”»
«No, no Romano: non “Dio”, ma il Nome!
Barùch haShèm: Sia benedetto il Nome!
Il NOME è il tuo Dio! Quella breve, arcana, maestosa, silenziosa sequenza scritta-incisa-scolpita, di quattro consonanti ebraiche: YOD - HE - VAV - HE... Il Nome!
Il Nome è Uno!
“...Amerai haShèm, il Nome, il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona, con tutte le tue facoltà. Queste parole che Io ti comando oggi, saranno sempre presenti alla tua mente!
Le ripeterai ai tuoi figli, e parlerai di esse quando te ne stai in casa e quando cammini per strada, coricandoti e alzandoti!
Le legherai come segno al tuo braccio e saranno come frontali fra i tuoi occhi! Le insegnerai ai tuoi figli parlando di esse, quando te ne stai in casa e quando cammini per strada, coricandoti e alzandoti, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte delle tue città in modo che siano molti i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, sulla terra che il Signore haShèm, il NOME, ha giurato ai vostri padri di dar loro.
Adonài Elohìm Emèth.”»
«“Il Signore Dio è Verità. Amèn.”
Grazie... grazie davvero, Hans, per aver recitato questa preghiera con me! È stato come una liberazione! Che Dio m’aiuti, Hans! … Sono un uomo disperato...»
«Tu? Tu disperato? Senza speranze?
Io ero disperato! Io che rubavo il tempo al sonno – ore, minuti, qualche secondo – pur di avere l’opportunità di diventare un altro: un uomo nuovo, con un’altra storia, altro destino, altre speranze!
Io volevo studiare la Volontà di Dio, vivere con Dio...
E la vita non me l’aveva concesso...
“Non l’ha messa lontano”, ci diceva Mosè, “non l’ha messa al di là del mare o in cieli inaccessibili! Perché così nessuno potrà mai dire: non ho potuto recarmi a prenderla...” Queste erano le ultime parole di Mosè, lo sai? Diceva: “Quella cosa che Dio ti ha ordinato, quella cosa che ti ha donato, non è lontana! È sulle tue labbra, è nella tua bocca, affinché nessuno debba andarla a prendere per te! ” E io, nella mia bocca, cosa avevo?
Solo il sapore della mia morte, i gusti ormai nauseanti delle cose dolci della vita! Sulle mie labbra non c’era proprio niente, capisci?
“È nel tuo cuore”, diceva Mosè; e io cos’avevo nel cuore? Sangue ispessito dagli stravizi, dall’alcol, dalle grasse carni di maiale mangiate con ingordigia, da sigaretta su sigaretta su sigaretta, fumate per riempire portaceneri fino all’orlo, e poi contemplarli come emblema del mio tempo consumato...
Che cosa devi rimpiangere della tua vita mancata, tu, Romano?»
«Scusami... non volevo...»
«Io non avevo più tempo: solo rimpianti, rimorsi, senso annichilente di fallimento. Io cercavo qualcuno che m’insegnasse una preghiera fatta solo per me... fatta su misura, come le scarpe e i vestiti che m’ero abituato a comprare.
Poi, per caso, solo perché tutti ne parlavano con entusiasmo, lessi il libro di Primo Levi; ed ecco: là dentro, di fronte a me, chiarissimo, proprio tutto quello che io stavo cercando! Quell’uomo era riuscito a raccontare l’inenarrabile, a trovare la chiave per liberare le anime come la mia!
Quell’uomo, per la prima volta nella mia vita, mi aveva dato la speranza di riuscire a pregare; di più: la certezza di poterlo fare, di poter chiedere perdono per la mia anima!
Ed era un ingegnere! Un ingegnere, capisci? Non un Rabbino, o un Santo, o un Profeta...
Prega, Romano! Prega con me, adesso! Io so che tu le parole di Primo Levi le conosci benissimo; non puoi non averle imparate a memoria! Ora dille tutte, una per una, parola dopo parola! Recitale insieme a me: “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case... voi che trovate tornando la sera... il cibo caldo e i visi amici...” »
«No, Hans, ti prego... Questa non èuna preghiera!»
«“...Considerate se questo è un uomo... che lavora nel fango...”»
«Fermati qui, Hans. Basta! Non è il momento...»
«“...Che non conosce pace, che lotta per mezzo pane... che muore per un sì o per un no... Considerate se questa è una donna... Senza capelli e senza nome... Senza più forza di ricordare... Vuoti gli occhi e freddo il grembo... Come una rana d’inverno... Meditate che questo è stato... Vi comando queste parole... Scolpitele nel vostro cuore... Stando in casa e andando per via... Coricandovi alzandovi... Ripetetele ai vostri figli... O vi si sfaccia la casa... La malattia vi impedisca... I vostri nati torcano il viso da voi.”»
«Hans, la conosco fin troppo bene... Ho studiato questa poesia a scuola... Hans, ti prego, ascoltami: l’ho recitata nel teatrino della mia scuola e i miei compagni applaudivano...
In sottofondo, ricordo che il Maestro mise un vecchio disco in vinile che faceva gracchiare un violoncello sulle note del “Kol Nidrei”, il canto del giorno dell’Espiazione...
Mentre scorrevano quelle note, scorrevano anche le mie parole. Io avevo soltanto paura di aver buchi di memoria, ero terrorizzato all’idea di far brutta figura con i miei compagni di classe, con i miei genitori, che erano fieri di me. E allora cercavo un appiglio per i miei pensieri, per distogliermi da quell’angoscia.
Così lasciavo che la mia bocca emettesse da sola tutto ciò che le avevo fatto memorizzare per giorni interi, perché fosse solo lei... – la mia bocca, e non io!...– perché solo la mia bocca ricordasse le parole per me.
Quel vecchio disco gracchiava, e io, pian piano, cominciai a notare, e poi isolare, dentro a quel rumore... come dei piccoli scoppiettii...
Concentrai tutto il mio ascolto solo su quelli.
Fu così che cominciai a immaginarmele: delle caldarroste che schioppettavano sul fuoco, spandevano profumi...
Mi piaceva pensare al loro calore, tenendole in mano nel freddo d’inverno... pensavo, e sentivo quel sollievo...
Ed è così, soltanto così, che alla fine, senza accorgermene, riuscii a recitare tutta la poesia senza inciampi, senza errori...»
«E così tutti furono contenti della tua recita.»
«Oh sì: tutti si complimentarono con me.
E il maestro mi abbracciò commosso; altri lessero dal diario di Anna Frank, poi il maestro recitò un brano di Elie Wiesel... e io mi vergognavo... io avevo soltanto mangiato caldarroste calde e croccanti, mentre la mia bocca diceva quelle parole...»
«Bravo... Io invece gustavo ostriche voluttuose, mentre quei fatti succedevano davvero.
E mi gettavo in gola lo champagne come fosse birra. Vivevo la notte, e correvo con grosse automobili... ed era il ’39, in America, e poi fu il ’40, e il ’41, il ’42, il ’43, ’44, ’45... E io stavo in braccio a belle fanciulle, a ridere, e ridere, e bere, e spogliarle, leccare i loro capezzoli e dire “mamma, mamma! dammi il latte!”...
Io vendevo bambine ai soldati, ai soldati ricchi, agli alti ufficiali, modelli di virtù... oh, diciottenni, s’intende! Con tanto di certificato medico di controllo! Tutta merce di qualità...»
«Questo è quel che facevi, Hans?»
«Che t’aspettavi? Un pio rabbino che studiava la Toràh? Ero un malvivente, un porco, un commerciante di carne umana.»
«Hans... tu avevi quindici anni, nel Trentanove...»
«No: ne avevo ventidue, ... e non mi chiamavo Hans.»
«Spiegami! Immediatamente!»
«Calmati. È duro da raccontare.
Te l’ho detto: non sono stato una bella persona...»
«Avanti! Racconta!»
«Sì, sì, d’accordo... non ti agitare...
La mia è stata la vita di un dissoluto, e poi di un dissoluto pentito, ma incapace di accettare il fatto d’essere cambiato e non veder scendere Dio in persona a congratularsi con me, a ringraziarmi, a dirmi “Bravo! ora puoi sederti qui, tra i Giusti, a goderti il mio Paradiso”... Io ho gettato dalla finestra una tale montagna di soldi, per pentirmi...»
«Voglio sapere, immediatamente! Qual è il tuo vero nome?»
«Io mi chiamavo Joseph Dutilo.»
«Sei tu?... Non è il nome dell’uomo che acquistò il violoncello?»
«Io ho comprato il Guadagnini che era stato ritrovato nel campo di sterminio. L’ho comprato a Los Angeles, nell’ottobre del ’55.»
«Ed era in vendita? Mi sembra una follia incredibile...
E allora chi è Hans Haas?»
«La mia falsa identità. Quella sì, ha 74 anni.»
«Devo tirarti fuori le cose con le tenaglie?
Dimmi tutto, una buona volta!»
«A dirti il mio vero nome rischio già anche troppo!
Sai cosa sono i programmi di protezione pentiti?»
«Quale tipo di pentito?»
«Quei dettagli della mia storia personale è troppo pericoloso farteli sapere. Per me, e anche per te.
E poi ti servirebbero a poco, dal momento che ti ho già detto cosa son stato...»
«Dimmi tutto! Subito!»
«Io sono cambiato, Romano: io non sono più quello che ero; ho dedicato anni a studiare, a dissodarmi, a coltivarmi, a redimermi.»
«Cioè tu avresti ottenuto una falsa identità protettiva?»
«Più o meno è così. La mia vita, in realtà, è appesa a fili sottili da molti anni.»
«È pazzesco! Ogni volta che tu mi riveli cose nuove, sono cose pazzesche!
Io non ce la faccio più a seguirti. A questo punto, sto distruggendo la mia vita dietro alle cose che tu mi offri, e adesso non riesco più a credere a una sola parola di quel che dici! Tu sei un pazzo, e vuoi far impazzire anche me!
Su, signor Joseph Dutilo, avanti, dimmi dove sono i documenti! Hai capito? Voglio i documenti! I documenti del violoncello: atti di vendita, di proprietà, attestati, dichiarazioni d’autenticità! Voglio foto, filmati, testimoni vivi e parlanti! Voglio la verità!»
«I documenti si falsificano con una facilità che neppure t’immagini...»
«Li voglio lo stesso! Tirali fuori subito!»
«Ecco, tieni, guarda! Questa è la mia carta d’identità! La vedi? Sai leggere?
“Hans Haas, nato a Vienna il 10, 11, 1924; celibe, commerciante, segni particolari: nessuno; abitante in Neulinggasse numero quattro; valida fino al 31 dicembre 1999”.
Contento? Annusala pure, guardala con la lente, col microscopio! È falsa; è solo una carta d’identità falsa. Eppure è vera...»
«E del violoncello cos’hai?»
«L’attestato di vendita e la sua autentica, redatta in America; dei Guadagnini non rimane più nulla: sai benissimo che durante l’ultima guerra uno spezzone incendiario cadde proprio sul loro laboratorio, a Torino, in piazza San Carlo, sicché tutto il loro archivio fu distrutto dal fuoco... Trovarono solo la cassaforte d’acciaio, intatta fra le macerie; era grande quanto una stanza: l’aprirono, ci guardarono dentro, ed ebbero la visione di tutti quegli strumenti ancora appesi l’uno accanto all’altro, che parevano essersi conservati in perfette condizioni...
Però, sai, appena cercarono di prenderli in mano... appena li sfiorarono... tutti quei violini e viole e violoncelli finirono di colpo in briciole e polvere: si erano carbonizzati, come fossero finiti in un orribile forno crematorio...»
«Smettila di cercar d’incantarmi con le tue storie favolose!
Dove sono i documenti? E le prove?»
«È tutto in una cassetta di sicurezza, in Svizzera, intestata a un altro nome di copertura: quello che avevo allora.»
«E qual era?»
«Basta. Ti ho già dato anche troppe informazioni pericolose. A suo tempo tornerò a Ginevra, prenderò tutte le mie cose, e ti prometto che avrai anche quei documenti e le prove che ho in mio possesso. Per il momento, se metto piede in Svizzera rischio di sparire per sempre. E non chiedermi il perché!»
«Sì, capisco... va bene.
E ti chiedo scusa; evidentemente sono davvero stupido... Stupido e sotto stress.
Ma capirai che tutto quello che mi sta succedendo è un insopportabile inferno!»
«No, no, caro mio! L’inferno è ben altra cosa. Tu, piuttosto, stai cercando in tutti i modi di sfuggire al tuo compito! Ma io ti comprendo, credimi...
Sai, dopo il ’45, quel violoncello è stato offerto, consegnato, persino imposto a diversi famosi violoncellisti. Nessuno l’ha mai voluto tenere, nessuno l’ha mai voluto suonare in pubblico! Nessuno ha mai avuto la volontà, il coraggio di promuoverne l’uso in concerti per la memoria dell’Olocausto, per meditarne l’orrore... e l’errore, per esortare il mondo al pentimento...
Hanno continuato a proporlo e riproporlo ovunque, ma tutti sempre, invariabilmente, hanno ripetuto: “Oh, no, è troppo, non possiamo”; oppure: “E che musica potremo suonare con quello? Non si può mica trattare un argomento come l’Olocausto a mo’ di spettacolo, con melodie strappalacrime!”. Uno aveva detto: “Quello strumento è diventato solo un’entità muta, il simbolo silenzioso d’un fenomeno terribile e indesiderabile: quello per cui, dopo Auschwitz, non si può più fare poesia.”»
«Ma non fu Theodor Adorno, a dire quest’ultima frase?»
«Sì, proprio lui. E se ne pentì quasi subito.»
«Se ne pentì?»
«D’altronde l’aveva detta...
E in quell’idea c’era una forza talmente penetrante, talmente angosciosa che, suo malgrado o meno, quella frase resta impiantata nel futuro: una sequenza di parole potenti che, una volta detta, vive nelle idee che ne conseguono...
«Questo, quindi, sarebbe il problema che io dovrei cercar di risolvere? Offrire all’ibridazione d’intelligenza e sentimento una nuova opportunità?»
«Questo, dopo tutto, è quanto parrebbe riuscito nell’opera di di parola, compiuta da Primo Levi...
Tu puoi esprimere in mille altri modi concetti simili o dissimili a questo; il punto è che quel violoncello, senza il suo violoncellista, è un oggetto inanimato quanto ogni altro oggetto, che esso sia una pietra o un’arca santa, o un tempio sacro, un luogo prescelto, o un’idea... o un nome... Ma se gli eventi della storia hanno l’hanno reso degno d’entrare nella mitologia, allora le azioni che noi compiremo con quell’oggetto avranno un senso e un valore diverso e più alto: quello della testimonianza.»
«Non ho fatto altro che ripetere questo per anni...»
«Può darsi, ma a chi l’hai detto? E a proposito di che cosa?»
«Ne ho parlato sempre nel senso della missioned’un musicista consacrato alla musica classica, ai suoi autori, ai loro nomi: Bach, Mozart, Beethoven... Testimoniare la loro grandezza, per preservarne il mito con il rito dei concerti, dell’insegnamento, del sacrificio dello studio...
Mai, però, avevo pensato che una simile testimonianza musicale comportasse l’obbligo di... un martirio...»
«In quel violoncello non c’è nulla che si possa o si debba teorizzare: tu sei violoncellista, e non devo insegnarti io che il violoncello non lo suona la teoria, ma la pratica. È nel suono che si manifesta la visione della sua verità: l’unica verità possibile, ovvero l’unica verità infalsificabile.»
«Me lo sono ripetuto mille volte, a me stesso e ad altri, e ora finisco con l’accorgermi che ho sempre, solo fatto teoria...»
«Parlami di questo, allora.»
«Proprio io, e proprio con quell’idea in testa, mentre cavavo suono dal mio violoncello dividevo e separavo due mondi: quello della parola a un tempo, e quello della visione acustica a un altro. Ma la realtà è un’altra: l’intelligenza rifiuta di contaminarsi con l’emotività, e viceversa...»
«Va’ avanti...»
«Quando quei mondi si incontrano, sembra nascere una ibridazione dissonante, qualcosa che si espande formando una sorta di limbo informe... è come un luogo sterile, chiuso e finito. Ed è una condizione pericolosa, perché genera caos, disordine incontrollabile.
Quell’ibridazione scavalca le barriere contro l’errore, che millenni d’esperienza sono riuscite a fabbricare nell’essere umano; disintegra in un istante quelle difese, e instaura una legge nuova, come fosse un nuovo “codice genetico”.»
«Ma questo non ti sembra un fatto naturale? È il peccato della hybris, per i greci; la più grave delle colpe: ogni cosa deve conoscere se stessa, i propri precisi limiti; l’acqua deve restare acqua: guai, dolori e catastrofe se solo le venisse il desiderio di diventare fuoco!»
«Eppure... in natura le unioni, gli accoppiamenti fra tipi umani diversi pare risolvano i danni genetici cui tende un gruppo troppo invecchiato...»
«Ah, certo: quello è il modo in cui i geni si rinnovano.»
«Sì, ma nell’arte e nel pensiero, al contrario, sembrano innescarsi processi autodistruttivi, strade senza ritorno...»
«Dunque tu non vuoi proprio credere che il solo, puro suono di quel violoncello possa portare con sé la sua storia? E che la possa comunicare, senza l’intervento della parola?»
«Santo cielo... non so: queste sono faccende da magia medioevale, o da narrativa gotica...»
«E dimmi, allora: che succede quando ti avvicini alla parola, col tuo violoncello?»
«Comunico, credo, con le assenze.
Credo che la sola impressione, il “calco sonoro” di una parola, possa esser percepita come una presenza ancora più forte, più penetrante, persino più significante di qualsiasi parola si possa dire...»
«E in tal modo, il “calco” di quella parola è pronto a riversarsi in infiniti significati, poiché non è imprigionato nel senso...»
«Infatti... Ricordo che una volta, giocando al paradosso, un amico attore mi disse di intrattenere il suo pubblico standosene tutto solo sul palco per l’intera serata a dire “parole”.
Una persona che era presente a questo dialogo, chiese: “Parole di chi? chi le ha scritte?”, e l’attore rispose con aria canzonatoria: “Colui che ha composto il dizionario!”;
“Sì, d’accordo, ma chi è l’autore del testo che reciti?”,
gli chiesero a quel punto.
E l’attore rispose: “Il mio pubblico!”.
“Cercate di capirmi,” spiegò, “la gente è così satura di parole, che io non gliene posso aggiungere altre in testa. Allora dico tante parole a caso, tutte di seguito, a volte arrabbiato, altre addolcito, poi triste, e poi, magari, euforico!...
Le scelgo tutte dal dizionario: le più belle, quelle col suono più ricco, più attraente. E la gente le ascolta contenta, ognuno immaginando di ascoltare la sua storia: quella che gli sto narrando io.”»
«Bella storia! E tu pensi che quell’attore avesse deciso di diventar musicista? Di far musica con quelle parole rese astratte, libere di essere soltanto... belle?»
«No: la musica non si può fare solo con delle parole.
Ma nel caso di quell’attore sarebbe stato ben peggio: un simile teatro avrebbe consegnato definitivamente la parola all’immagine, e l’immagine avrebbe imprigionato la parola nel caos; questo era successo a Babele, ed è ciò che ha messo in disgrazia il mondo.
Ricordi cosa dice il versetto di Genesi, al punto in cui inizia il racconto della torre?
Le sue parole sono ben chiare: “Orsù, venite, costruiamoci una torre la cui cima sia nei cieli, così da farci un NOME...”.»
«Cercavano di risolvere un problema di visibilità e potere, dunque... visto che all’epoca non avevano ancora il cinema e la televisione... e neanche la radio...
E tu pensi che il mondo l’abbia capita, quella lezione di Babele?»
«Credo proprio di no. Il mondo si riempie d’immagini, ogni giorno di più, e dei relativi nomi che servono a renderle visibili...
Ma nella saturazione, nei tempi sempre più congestionati delle nostre vite, l’immagine chiude la parola in spazi ogni giorno più ristretti, finché diventa impossibile liberarla.»
«Hai ragione, è vero.
E vedi bene: i cristiani, per secoli, hanno continuato a costruire un’immagine di noi ebrei deicidi, e così anche il mondo moderno, progredito, privilegiato, ha finito col trovar normale l’avvento delle leggi razziali, con tutto quel che ne è conseguito nel nostro secolo.»
«Già... e proprio nello stesso modo si costruisce un’immagine di cosa è buono per la società, e di cosa non lo è; così si dirige l’intera economia dei mercati, facendone subire le conseguenze all’intero pianeta.»
«Sagge osservazioni.»
«Ma se la musica non si può fare con la sola parola, di fatto ha comunque bisogno di qualcosa che abbia un senso, una direzione. E a risolvere questa necessità, a volte, può bastare un nome.
Io che ho sempre pronunciato con solennità, con fierezza, i nomi di Bach o di Beethoven, ora, qui, con questo violoncello, ora che devo aggiungere alla musica del mio strumento un nome come Auschwitz... quale senso potrò offrirgli?
E poi io, artista dei suoni e nient’altro, cosa dovrò offrire alla coscienza del mondo? Quale contributo alla verità storica potrò consegnare?»
«Se fosse solo un’emozione, un sentimento, temo che a quella verità giungerebbe un contributo assai fragile.»
«Allora aveva ragione Adorno, dicendo che dopo Auschwitz non si può più fare poesia.
Però... – e questo è ancora più grave! – forse non aveva tenuto conto del fatto che presto ci sarebbero state ben più parole e poesie inscritte nella musica, fuse nei suoni musicali, scolpite in profondità nelle note, di quante tutta la letteratura avrebbe mai potuto contenere!»
«E come?»
«L’ho già detto: perché proprio l’assenza della parola, del senso chiaro, compiuto della parola, fa sì che nella musica quel senso, quel significato – e la parola che lo dice, lo spiega, lo afferma – giunga infine a manifestarsi con la sua massima forza. Perché l’animo umano è impaurito dal non-senso quanto lo è dal vuoto, e allora in quell’assenza cercherà immediatamente, a tutti i costi, un senso...»
«Comprendo: l’uomo si fabbricherà a tutti costi un senso del suo esistere, ovunque non l’abbia trovato già pronto, allo stesso modo in cui si è dato da fare, nei millenni, industriosamente, per riempire “le sue assenze” con le belle immagini di Dio.»
«Questo è quanto mi è dato di capire, oggi.»
«E allora, a ben vedere, potresti notare, oggi, la somiglianza di un tetracordo straordinariamente antropomorfo com’è il violoncello, con il Nome del Dio d’Israele, ossia con le quattro lettere ebraiche che formano il Santissimo Tetragramma... Esse sono un nome, ma non puoi chiamare nessuno con quello; è una sequenza di lettere senza suono, perché non si può pronunciare, non si articola fra gola, naso, lingua e bocca, non lo si può sentire con le orecchie.»
«Sì, lo so, l’ho imparato: le quattro consonanti senza vocali del nome ebraico di Dio.»
«Quelle quattro sacre lettere esistono e vivono in due universi separati: consonanti mute in uno, vocali sonore e risonanti nell’altro, che però è luogo proibito e nascosto...
Così come sono conservate nel rotolo della Toràh, le lettere del testo sacro, e del Nome ineffabile, non hanno alcun suono che l’organo dell’udito possa intendere!
Forse, però, tutte le cose che il musicista mette in ordine chiamandole con un nome, possono giungere infine presso il Nome di Dio, per essere anch’esse “Nomi del Nome”, mostrandosi come un mondo separato, sì, ma ben ordinato ai suoi piedi, e secondo la Sua Volontà!
È in questo modo che i cabalisti presentano i cinque libri di Mosè, la Toràh: il grande, il lungo nome di Dio, e in quello leggiamo narrazioni, comandamenti, insegnamenti etici e morali, ma soprattutto il lungo nome di Dio, nel quale, un giorno, potremo apprendere a leggere la “partitura” della musica divina! Quella “partitura” in cui Dio guarda per creare l’universo e nella quale è cifrato l’ordine della Creazione, fissato e contenuto, appunto, nella chiave ineffabile del Suo Nome di quattro lettere!»
«Sebbene solo in lingua e scrittura ebraica...
Forse, per assurdo, abolire definitivamente ogni religione, ogni idea mistica, proibire la musica che si rivolge a quelle idee, cancellare il senso del divino nel suono, finirebbe per cancellare l’idea stessa di Dio, e allora chissà... forse diventeremmo davvero capaci di “creare” anche noi, come Dio, altri mondi nella materia fisica, col solo mezzo della “parola”: ossia con l’idea che forma altre idee che la realizzano.»
«Creeremmo mondi a nostra immagine e somiglianza, destinati a diventare vecchi e depressi nel breve tempo dell’uomo, e ci troveremmo ad osservarci l’un l’altro con lo sguardo vuoto e mostruoso del Gòlem...»
«Già, appunto quello: un mostro creato dallo sconsiderato recitare sacre permutazioni delle quattro lettere del Nome di Dio.
Si tacerà quel Nome: per rispetto del Comandamento divino, e per l’incapacità di pronunciarlo...
E forse io dovrò tacere anche il nome di Auschwitz.
Per ragioni simili, ma banalmente connesse all’imperfezione più grave del mondo: il suo sfuggire alla verità, la sua tendenza a volgerle le spalle.»
«Romano, tu hai mai letto le Toledòth Jéshu, le storie di Gesù che si leggevano di nascosto, nei ghetti medioevali?»
«No, non conosco quei testi; sono solo informato della loro esistenza, e poco più.»
«Fa lo stesso. In alcuni di questi scritti, il fatto che Gesù facesse miracoli prodigiosi e attirasse su di sé l’attenzione e l’amore delle folle, è attribuito al fatto che quel Jéshu, che era un bastardo nato da un adulterio fra una donna ebrea e un soldato romano, si fosse appropriato dell’ineffabile nome di Dio, rubandolo dal Tempio.
Ma come aveva fatto?
Il Tempio, ci raccontano quelle storie, era difeso da tre cani enormi e feroci; dunque era impossibile entrarvi, a meno che non si potesse diventare invisibili. Allora Jéshu entrò in una carcassa di maiale – animale impuro e proibito, ma tanto gustoso per i cristiani– e la abitò per un certo tempo, facendo riti per evocare il diavolo e congiurare con lui. Il diavolo, infine, acconsentì a concedergli il potere dell’invisibilità, e solo così Jéshu poté penetrare nel Tempio, rubare il Nome divino, e finalmente poter compiere tutti i miracoli meravigliosi per cui era noto, come resuscitare i morti, guarire gli ammalati, moltiplicare i pani e i pesci, e persino creare palazzi favolosi, o volare per i cieli.
Non è difficile da immaginare: questi racconti avevano un’enorme successo fra gli ebrei dei ghetti, oppressi e poverissimi, e imbarazzavano, anzi, terrorizzavano i rabbini, che vedevano bene quanto le violenze e le persecuzioni aumentassero proprio con la diffusione di quei testi.
Nonostante ciò, più forte di qualsiasi prudenza era il bisogno del conforto di quelle letture – soprattutto dopo le ore mattutine della domenica, quando gli ebrei erano costretti a starsene in piedi e zitti ad ascoltare le prediche coatte che i buoni e pii frati gli imponevano –, e faceva sì che si continuassero a copiare, conservare, leggere e raccontare tutte quelle storie...»
«Insomma, era il bisogno incontenibile, bruciante, di un’altra verità, di un’altra ragione che venisse a a spiegar loro la sofferenza cui erano costretti per il solo fatto di essere nati... Un’altra verità storica, a qualsiasi costo, da contrapporre a quella imposta dai buoni fraticelli di Cristo.»
«Medita su questo, Romano: non rendere il tuo violoncello uno strumento di musica al pari d’una cornamusa caduta dal cielo, come quella che finì tra le mani di Marsia! Quello era sì uno strumento creato dagli dèi, ma creato da una carcassa in decomposizione: la carcassa di un maiale, annegato nello specchio d’acqua delle vanità di Narciso... una carcassa rigonfia del fiato della morte!
Là, dentro quel cadavere dissonante, dèi e dèmoni t’illudono di ritrovarsi allegramente insieme, di danzare in bell’accordo al suono euforico e sensuale delle sue canne. Ma da quelle non si può espandere null’altro che la mera fascinazione del “corpo” dei suoni e delle note. Non cercare, non trovare, non dare al tuo violoncello proprio quel timbro di voce, giusto per compiacere i tuoi sensi! Cerca altrove l’emozione! Altrove è il segreto della vittoria! Là, dov’è conservata la speranza che il suono dell’ineffabile Nome di Dio torni ad espandersi nel vibrare dei legni del Tempio di Davide e Salomone, e inizi a cambiare il mondo nella sua materia, in ogni sua cellula, molecola, atomo!
Quello, e soltanto quello è il suono della guarigione dalla malattia, dell’ignoranza, il suono taumaturgico, il suono che redime il mondo, il volo che ci è stato promesso!
Medita, Romano! Medita e umiliati, di fronte al Nome!»
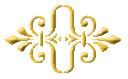
Sì, pazzo che sono stato! Avevo già capito tutto l’inganno, e non lo sapevo! Stupido mio cervello verboso, vanitoso!Stupidi miei occhi pieni di libri, di nomi, di parole di lettere di alfabeti di mondi di universi di illusioni di deità di vuoti di niente di nulla di fine di zero di idea di numero di bello di nuovo di parole di fatti di realtà di modernità di libertà di leggerezza!...
Memoria inutile! Perché non ha parlato solo il silenzio?
Cos’è, se non vanità, che ci spinge con così tanta forza nella spiegazione, nel possesso, nella libido del vedere la direzione del senso e del significato?
Quale rovesciamento dell’anima di Dio è il nostro rumoroso pensiero? Tutta la terra invasa, molecola dopo molecola, dalle nostre lunghe dita che indicano, scrutano, solleticano, spostano, svelano...
Guai a quel folle, allo sprezzante, superbo folle che cerca con la sua vanità nella parola, e trova il significato che la distrugge! Maledetto dalla terra e dal cielo! Cancro silenzioso e annichilente nell’anima immortale!
Un inferno musicale si creava nei suoni del mio strumento, formandosi dalle sue note poco a poco più insinuose, in figure di parole sonore, squillanti, stridenti, fragorose...
Terrificanti!
Idolo mostruoso di armonie spente! Gòlem dalla voce bellissima e ingannatrice! Organo formidabile, frammentato in suoni multipli e complessi, di follia e disordine.
Rituale rovesciato: nei suoi schemi svelava il nome, lo spiegava in parola, ne rubava il suono, se ne appropriava, vi indagava negli abissi del senso, forgiava il senso nuovo nel suono sensibile, lo innalzava nel sentimento, fino alla distruzione della parola, della struttura della parola, fino all’annichilimento del nome e della lettera, vittoria finale della follia!
Continuavano i miei passi nell’errore: ed ero fiero, orgoglioso di me stesso.Non m’importava più nulla del mio fallimento mondano: io ero destinato al sublime, alla gloria finale.
Né il mondo mi era nemico; contavo, anzi, sul suo appoggio incondizionato: bastava cercare e trovare la gente... Il mio pubblico! Che era già là, ad attendere la mia venuta! Io: Messia del violoncello di Auschwitz! Trionfante Lucifero nel mondo della velocità e leggerezza!
Nessuna parola umana è verità.
Claudio Ronco
Prima messa in scena a Vercelli il 17 ottobre 2010, nei sotterranei della Sinagoga, per la regia di Guido Zamara.
