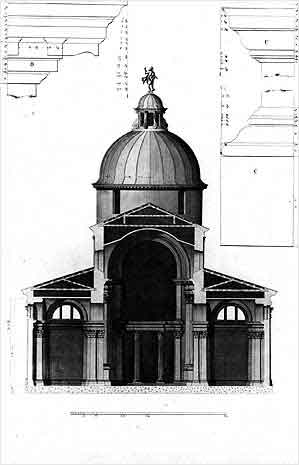|
Félix
Duque
IL
CANTO DELLA SERA
dedicato a Claudio Ronco.

Aber
Freund!
Wir kommen zu spät.
Aber
Freund! wir kommen zu spät. Così comincia Hölderlin
la sua imponente settima strofa dell'elegia Brot und Wein.
«Noi» arriviamo dunque troppo tardi. Ma chi viene nominato
qui dal «noi»? Forse soltanto lo sciagurato Heinse, il destinatario
del poema, ed il poeta stesso? Oppure qui si fa allusione a tutti noi,
cioè agli uomini dell'Occidente, agli abitatori di questa terra
che si estende verso sera?
Verso sera s'inizia appunto la fine della convivenza degli uomini e
degli Immortali, la fine cioè dello sforzo dei popoli di essere
in der Gegenwart der Himmlischen. Ma quella convivenza è
ormai finita con la morte di Cristo, di colui che è per Hölderlin
l'ultimo dei semidei: il figlio infatti, come Eracle e Dioniso, del
Padre —miticamente, Zeus— e di una donna mortale, ma contrassegnato
rispetto agli altri eroi dal paradosso di essere l'Unico, Der Einzige.
Poiché in Cristo non si mostra agli uomini un mero travestimento
o tutt'al più una veste, ein Gewand, del Dio, bensì Dio stesso
fatto carne:
...er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an Und vollendet'
und schloss trostend das himmlische Fest.
Er selbst, ossia il Dio in persona, di cui la sua figura, giacché
coincide con quella dei mortali, impedisce paradossalmente l'antica
ed armoniosa separazione tra le sfere che prima assicurava la convivenza
e più: la syngéneia degli uomini e dei Celesti.
Come si potrebbe infatti adorare il "figlio di un falegname"?
Soltanto la morte e l'apoteosi di Cristo —troppo tardi giustamente
per riconoscerlo in vita come Dio— "culminò perfettamente"
e "chiuse la festa celeste", a cui —come nelle nozze
di Cadmo ed Armonía— erano invitati i mortali.
Orbene, questa
idea di "chiusura" del Panteon (allargato fino ad includere
nella camera sepolcrale a Cristo come l'ultimo Dio) potrebbe convenire
senz'altro con una supposta tristezza per la perdita degli Inmortales,
se non fosse per la spaesante presenza del participio: tröstend.
Ma, in che senso strano si può capire la morte di Cristo come
una consolazione? E tuttavia, noi ci ricordiamo che quella morte è
stata non solo annunziata dal proprio Cristo, ma è stata da lui
stesso salutata per giunta come necessaria: "Ma vi dico la verità:
è conveniente che io me ne vada. Perché se io non andassi
via, allora l'Avvocato [hó Parákleitos: il Consolatore]
non verrà a voi; ma se io andrò via, ve lo invierò."
(Jn 16, 7). Che Cosa può significare questa "convenienza", prima facie così fuorviante? Forse non è bene che
il Dio rimanga con noi? Assolutamente no, contesterebbe a mio avviso
Hölderlin, adattando per questa deludente risposta una idea profonda
di Kant, che nei paragrafi 59 e 60 della sua Critica del giudizio riflette su quello che oggi denomineremo "il disagio della civiltà".
Infatti, la presenza costante del Dio tra di noi, uomini, finerebbe
ora necessariamente in una ripetizione meccanica di riti svuotati di
ogni significato religioso e sfocianti in una noia mortale, ora nello
sboccio di un pericoloso fanatismo degli "eletti'', i quali cercherebbero
allora di imporre tirannicamente la loro verità agli altri uomini
(forse non sono loro, gli «eletti», coloro che sanno ciò
che Dio desidera ed ordina, giacché in fin dei conti hanno con
Lui una communicazione diretta?).
Il primo caso è accaduto già
nella scomposizione del panteon greco da parte di Roma, ossia di quella
civiltà decadente nella quale ogni oggetto particolare era visto
come presenza degli dei e conseguentemente come possibile oggetto
di culto. Anche il forno per il pane (Fornax), come ci ricorda
Hegel in consonanza con l'amico di prima, parrebbe esser ritenuto come
oggetto di venerazione. La totalità o Allheit degli dei,
estesa fino alla coincidenza puntuale con tutto ciò che esiste,
finisce così in una sarcastica divinizzazione del reale, che
diventa addiritura una profanazione assoluta del mondo. Ed il secondo
caso si mostra nel destino del Popolo Ebreo (o mutatis mutandis nel Popolo Tedesco dei sinistri anni Trenta del nostro secolo). Perciò
fu necessaria la "fuga degli dei". Di Cristo e, con lui, di
tutti i suoi "fratelli", in lui riassunti.
E tuttavia, la "mancanza" del divino non significa la sua
morte. Neanche la dimenticanza della sua assenza. Ché questo
comporterebbe la caduta degli uomini in una cultura meccanica e fièvole,
esclusivamente attenta ai bisogni materiali, come quella propugnata
da un certo "Illuminismo" contro il quale s'importa Hölderlin,
non però nel nome di un presunto "irrazionalismo romantico",
bensì con la esigenza di una höhere Aufklärung (1),
di un illuminismo più alto che permetta di "sperimentare
che nel mondo c'è qualcosa di più che un corso meccanico
(Maschinengang), che c'è uno spirito ed un Dio, ma che
certamente si trova in un rapporto (Beziehung) più vivente
ed elevato sopra la indigenza dei bisogni, ed in virtù del quale
l'uomo è in relazione col mondo circostante. "Ma per questo
bisogna sentire la mancanza del divino. Se il Dio apparisse all'uomo
così come Lui nella propria essenza esiste, senza immagine né
travestimento, il suo fuoco fulminerebbe senz'altro l'uomo, così
come il fulmine bruciò la imprudente Semele, la madre di Dioniso
(cf. Wie wenn am Feiertage). E noi abbiamo visto sopra che la
presenza pure mediata del divino, sia attraverso vesti mitiche o mediante
la figura dei semidei, finisce per ingenerare noia o fanatica esaltazione.
Resta soltanto una soluzione. Una soluzione geniale che anticipa ed
in molti aspetti oltrepassa, la critica heideggeriana alla ontoteologia occidentale, cioè alla metafisica, nella quale l'essere si confonde
con la presenza costante di un sommo ente dominatore che racchiude in
sé, a sua volta, tutta la ragione e tutte le ragioni del mondo.
Infatti c'è per Hölderlin qualcosa tra la presenza e l'assenza,
tra l'essere e il non essere: una «cosa» strana e fuori
luogo, assurda appunto, cioè la sospensione: un "essere
pendente" (Ausbleiben), latente nella commemorazione
sacra (Andenken) ed imminente come der kommende Gott
(vid. Brot und Wein, estr. 3, ult. v.). Un Dio che così
si sottrae al presente mentre si nasconde nel massiccio di un passato
raccolto nella parola poetica e nell'avvenire che anima chiliasticamente
la parola profetica. Ché entrambe, il fiore del greco e la scintilla
giudeo-cristiana, si adunano nella voce di Hölderlin. Ciò
che noi insomma intravediamo è un Dio che manca, e che ci manca:
Furchtlos bleibt aber, so er es muss, der Mann Einsam vor Gott, es
schützet die Einfalt ihn, Und keiner Waffen brauchts und keiner
Listen, so lange, bis Gottes Fehl hilft.
(Dichterberuf, ult.
estr.).
"Intanto che aiuta la mancanza di Dio". Eccoci di fronte
alla parola decisiva, e strana. Dio "appare" difatti come
ciò che manca ed insieme come colui che palesemente ci manca
per il compimento del proprio essere (cf. il cor inquietum agostiniano).
E tuttavia, questa promessa di completamento è ingannevole. Ché
quel compimento significherebbe la morte del uomo, perché la
essenza umana consiste nella separazione dal divino. Ed è per
questa divisione, e solo in virtú di questa divisione, che l'umano
si apre allo stesso tempo a un rapporto infinito col divino. Certamente,
come dice la strofa settima di Brot und Wein, ancora "vivono"
gli dei: ma "in un altro mondo", cioè in un
mondo indolore, se è vero che l'essere immortale significa assenza
di sofferenze. Ma allora si tratta anche di un mondo privo di vita vera
ed individuata (ci si ricordi di Hegel: "il dolore è
la prerogativa dell'essere vivente"). Gli Dei sono privi di terra, perché manca loro l'elemento titanico o aorgico,
come lo denomina Hölderlin. Conseguentemente, neppure sarebbe possibile
per gli Dei abitare il proprio mondo, se un «altro» del
divino non soffrisse invece ed in favore di coloro:
...Denn weil
Die Seligsten nichts fühlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen
Teilnehmend fühlen ein Andrer
Den brauchen sie;...
(Der Rhein; str. 8, w . 5—10).
Delle ultime parole ci sono due versioni possibili ed in fondo convergenti.
Da un lato si potrebbe infatti leggere così: "Essi —cioè, gli dei— utilizzano, approfittano di lui".
Ovvero, e in maniera più vicina al senso nascosto del poema:
"Gli dei ne sentono il bisogno." In quest'ultimo caso,
gli dei hanno bisogno di ein Andrer per impedire la loro conversione
in esserci inanimati, cioè in statue apatiche e senza sentimento.
"Un altro" deve dunque "partecipare", sentendo e
patendo, alla sorte degli dei. In modo tale compie anche «l'altro»,
paradossalmente, il destino (moîra) a lui appropriato:
la sua "parte". Per ciò l'attitudine dubitativa e poco
meno che paurosa del poeta. Poiché il farsi carico del destino
degli dei e il vedere in tale compito il compimento della propria sorte,
non implica addiritura una titanica dismisura? E non cagionerà
questa hybris il male supremo: la morte? Certamente. Ma, la morte
di chi? Chi potrebbe essere "l'altro" degli dei? Forse l'uomo,
l'uomo qualunque? Senza dubbio, no. L'altro degli dei non può
essere nient'altro che un uomo, giacché questa alterità
comporta la figura logica della contrapposizione, ossia il reciproco
compromettersi di una sfera nell'altra, in maniera che alla fine divengono
entrambe l'altra da sé stessa. Essere l'altro degli dei (e non semplicemente la loro "creatura") implica poi dialetticamente
l'essere di un monstruum che raccoglie in sé il divino
immergersi nel proprio intimo, cioè lo hegeliano "essere
in sé", e la titanica ritrazione, il dissidio dalla
propria provenienza, cioè "l'essere per sé".
Il destino di questo essere mostruoso, dell'eroe, non può essere
altro che il sacrificio; dunque, non la mera morte subita, passiva,
come quella dell'animale, ma la morte sperimentata come apoteosi,
ossia come trasfigurazione nell'attimo della morte e nell'interno della
propria morte. Ed è in grazia di questo sacrificio che:
...kennet der Mensch
Sein Haus und dem Tier ward, wo
Es bauen solle,
(Der Rhein; str. 4 a, V. 10-12).
E per l'appunto il "prendere parte", come dire l'azione sofferente
di compromettersi nel destino del divino, la maniera in virtù
della quale l'eroe —come figlio di Zeus— assegna con giustizia
a ogni ente tutto ciò che gli è appropriato ed accordato
dalla moîra (per l'appropriazione diviene l'ente un singolo,
mentre per il suo essere posto d'accordo con sé stesso viene
cordialmente legato al fondo originario). Solo così diventa possibile
per l'uomo la "negazione" —benché effímera—
della terra di provenienza e l'inversione, la katástrophé di questa in soggiorno, innalzando la terra —contro la sua propria
pesantezza— verso il cielo. Anche in questo modo viene assegnata
all'animale l'occupazione del suo rifugio. Soltanto il Mediatore, appunto
colui che destina la sorte resta senza dimora fissa come qualcosa di átopon, d'assurdo. Un essere di troppo: "Il
Figlio dell'Uomo non ha luogo dove riposare la sua testa".
(Mt. 8, 20; Lc. 9,58). Così accade ai semidei:
... jenen ist
Der Fehl dass sie nicht wissen wohin?
In die unerfahrne Seele gegeben.
(vv. 12—14).
E qui di nuovo, ma adesso dall'altro lato degli dei, ci troviamo col
termine chiave: Der Fehl, "la mancanza" (anticamente
"la falta", da fallere, da dove anche il falso e il
fallimento). Ma questo "essere in falta" è per Hölderlin
una donazione, come dire una grazia! (nel testo si dice appunto che
"a quegli viene data la falta, l'errare"). Cosa dà
poi a intravedere questo errare in falta se non la síntesi-diáiresi,
il limes ovvero il crocevia dove si congiungono dei, uomini e
cose, conservando le distanze tra di loro? Così, anelanti
di Cielo ma appartenenti alla Terra, i semidei "non sanno dove
andare". Inesperta è la loro anima (contro l'«esperienza»
dell'uomo tecnico, lodata ambiguamente da Sofocle nel famoso
stásimo di Antígona). Il loro assurdo luogo è
l'interstizio, l'essere «incrociati», come dire «cancellati»
nella loro azione di assegnare luoghi, nella loro destinazione di spazi
aperti. Per di più: l'essenza mediatrice del semidio impedisce
la reciproca chiusura escludente di dei e mortali: impedisce insomma
che entrambi siano soltanto in sé stessi, senza mediazione
possibile. Perciò lo straordinario commento —inoltre
di chiaro sapore hegeliano— di Hölderlin alla sua traduzione
del pindàrico Das Höchste:
"Das Unmittelbare —dice—, streng genommen,
ist für die Sterblichen unmöglich, wie für die Unsterblichen;
der Gott muss verschiedene Welten unterscheiden, seiner Natur gemäss,
weil himmlische Güte, ihret selber wegen, heilig sein muss, unvermischet.
Der Mensch, als Erkennendes, muss auch verschiedene Welten unterscheiden,
weil Erkenntnis nur durch Entgegensetzung möglich ist. Deswegen
ist das Unmittelbar, streng genommen, fur die Sterblichen unmöglich,
wie für die Unsterblichen."
E conclude: "Die strenge Mittelbarkeit ist aber das Gesetz."
(WuB; II, 671; sottolineato da me).
Ebbene, non è palese che il bene celeste, come sacro (cioè,
come separato e allontanato dal profano e quindi puro, non mescolato
e immacolato), possa venir distribuito per il Dio in mondi diversi (lacerando così quello che Hölderlin denomina —con
Hegel— l'Aether, la pura trasparenza dell'essere) dalla
sola forza del Dio, giacché, così paradossalmente come
logicamente, il sacro deve essere ciò che rimane sempre intero
ed incontaminato. Per principio, dunque, il sacro sarà il tutto
ed il nulla come tali: l'assoluto e l'indeterminato: lumen
et lux insieme, l'essere incolume è allo stesso tempo ciò
che si ritrae e divide dal profano. Il sacro è poi assolutamente
non suscettibile ab origine di essere distribuito per mondi diversi
(come dire, non suscettibile di fondare epoche diverse). Per fare quella
ripartizione, Dio ha bisogno dunque di una forza negativa che
non gli appartiene propriamente, ma che procede —sia detto con
una immagine mitica— dall'elemento terrestre o aorgico:
l'elemento proprio invece dell'uomo. Ché questi, qua essere
conoscente, nel suo stabilire divisioni stà appunto nell'elemento
a lui appropriato. Queste separazioni, però, non si limitano
a fissare una diversità (come nel caso del Dio), cioè
una distinzione d'indifferenza, dove ciascuno dei due ambiti vive come
se fosse independente, senza rapporto con l'altro. E tale è la
ragione, inoltre, del fatto che in Brot und Wein si dice che
gli dei, assorti nel elemento celeste, non sembrano avere nessuna
cura di noi, mentre sia il compito proprio dell'uomo lo stabilire contrapposizioni,
ossia distinzioni tali che ciascuna trova la sua verità nel rapporto all'altra, la quale esiste soltanto come non mischiata all'altra distinzione
che la contraddice. Gli uomini sí, invece, si curano degli dei
(e talvolta lo fanno anche contro se stessi, poiché sanno
bene che l'ingresso nella sfera della indeterminatezza significa la morte). La cura mortale degli dei si realizza infatti tramite
l'introduzione nella sfera celeste della separazione e la distinzione.
A rigore, soltanto nella contrapposizione dell'uomo (come apparizione
della "mortalità") alla sua propria origine unitaria
(ecco, dalla sua essenza "immortale", solo adesso vista, ma
sempre troppo tardi e come alle "spalle", in quanto spostata
nel luogo a essa improprio) sorge d'un tratto la parvenza della
"diversità". L'uomo mantiene divise le sfere e progetta
su queste la forza propria di negazione che lo costituisce. In questa
maniera, la prima apparizione della divinità è necessariamente politeista. Soltanto nel ricordo che interiorizza, nella Erinnerung,
esce paulatim alla luce il fondo primordiale. Questo ricordare,
peró, non è permesso agli dei, ignoranti dunque della
loro apparizione a partire dall'umano ed attraverso il dolore umano.
Pertanto:
...immer
Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist
Zu behalten. Und not die Treue.
(Mnemosyne, 3 a vers.; str. 1 a, vv. 12—14).
La nostalgia che va verso lo slegato e sciolto significa poi la brama
incoscia degli dei (e quindi di quegli dei che l'uomo si è dato
per poter diventare se stesso) per ritornare al Padre, cioè all'Etere.
Il compito di conservare le distinzioni, la lealtà verso gli
dei (lealtà insomma dell'uomo verso se stesso, ossia verso il
sostegno della propria apparenza), rimane sempre faccenda degli uomini.
Sono loro che si curano degli dei, della distinzione tra di loro, manifesta
nella offerta e nel sacrificio. Nel culto latrèutico, l'uomo
si giuoca letteralmente la vita. La vita propriamente umana,
non animale né meccanicamente ripetitiva:
...Denn nicht vermögen
Die Himmlischen alles. Nämlich es reichen
Die Sterblichen eh an den Abgrund.
(Mnemosyne, 2a vers., str. 1 a, vv. 12—14).
I mortali sono dunque i custodi della memoria dell'abisso primigenio,
del caos che, contro l'odierno senso volgare, significa appunto: "gola",
"fauci", "apertura" (gr. chaein). E perciò
viene permesso all'uomo l'uso della negazione, la potestà di
dire: "no". Di questo sono incapaci gli Immortali. E tuttavia
è palese che gli dei conservano ancora come traccia (presente
nella loro ansia verso lo slegato) il secreto della loro origine.
Per l'appunto: la congiunzione del potere umano di distinzione e del
divino cenno impotente verso l'origine diviene così la pura positività,
il saldo fondamento del cosmo. Un fondamento che ricade a sua volta
sul fondo indifferenziato, se non altro perché l'apparizione
dell'uomo stabilisce ed instaura la prima differenza (la differenza
appunto tra Grund ed Erscheinung). E tuttavia, la congiunzione
stessa del potere umano (mortale) e dell'impotenza divina (immortale)
non può essere operata né dal uomo né dal dio.
Perciò sentono entrambi il bisogno di un Vermittler, di
un Mediatore che aggiusti i loro rapporti reciproci attraverso la fissazione
di limiti che impediscano la trasgressione. Questi rapporti sono in
principio quattro: la dominazione della terra dal fuoco celeste, l'ascensione
del sangue di una terra già ordinata verso il cielo, la restituzione
umana della scintilla divina al grembo tellúrico, e da ultimo
l'incrocio di cielo, terra ed uomo nella figura singolare di un Dio—Uomo
che col proprio sacrificio della Croce tende —al di là di
tutte le ragioni— verso il confine dove s'identificano nel fondo
Etere e Caos.
Da ciò deriva il fatto che il primo mediatore è per Hölderlin
Eracle, il semidio figlio di Zeus, che è lui stesso un mostruo
o íbrido divino—mortale. Un eroe dunque che distrugge l'ingens
silva (rappresentata per esempio dal leone, l'idra, il cinghiale)
e che finisce per essere bruciato dallo stesso fuoco esteriore (la túnica
di Deianira) acceso internamente nel suo cuore. E se in Eracle predominava
l'elemento ígneo, in virtù del quale si dissoda la terra
e la si prepara a essere la dimora umana contro la propensione aorgica
dell'uomo (si ricordi in merito il mito di Anteo), invece Dioniso, il
secondo semidio, ha la sua origine nell'autonegazione del fuoco (come
è noto Zeus, che con il suo fulmine riduce in brace Semele, ferisce
sé stesso e nella sua coscia serba —come in una cavità
tellúrica— la vita del non nato Dioniso). Eracle dominava
violentemente sulla natura, distruggendo il suo potere, mentre Dioniso
addomestica e dirozza le bestie, instaura il culto che lega uomini e
dei, e infine porta ovunque la pace che congiunge gli uomini tra loro
e forma i popoli e regola i loro rapporti fra popoli per formare il
mondo. I1 destino di Dioniso —contrariamente a quello di Eracle—
è quindi la sanguinosa lacerazione della propria carne per mano
delle baccanti, che, nella loro frenesía, non tralasciano di
compiere, addirittura ferocemente, la prescritta tendenza che culminerà
nella terza figura: restituire l'elemento celeste, ordinatore, alla
terra.
Dalle funzioni antitetiche che entrambi i semidei presentano (articolare
da un lato la terra col fuoco del cielo, innalzare dall'altro la terra
verso il cielo mediante il culto e l'istituzione della società),
palesemente si osserva che tutti e due rimangono ancora assoggettati
alla natura, senza la possibilità di venire riconosciuti
dagli dei, ovvero dagli uomini. Eracle e Dioniso si muovono ancora,
come esseri marginali, attraverso la linea della diversità
delle sfere, senza potere arrivare a una perfetta contrapposizione.
È dunque necessario considerare la possibilità tragica di un uomo che s'innalzi fino a essere Dio, e del Dio che si abbassi
fino a essere uomo. La prima, incompiuta figura è quella di Empèdocle.
In lui troviamo l'infinita tensione tra l'organico (e cioè l'ordine
e la cultura: l'arte) e l'aorgico (la natura selvaggia). Ma questa resta
ancora una figura tragica, e quindi intempestiva (e come annota Hölderlin: odia il dio cavilloso la maturità intempestiva). Empèdocle
è soltanto un uomo singolare che aspira a rivolgersi a Dio, affinché
vengano uniti gli oppositi (facendo in modo che essi zu Einem in
ihm werden) ma senza mediazione e contrapposizione tra loro, laddove
l'eroe rimane la sola mediazione. Perciò finisce per essere odiato
dal suo popolo. E perciò si celebra la sua immolazione soltanto
nel seno titanico e tellùrico dell'Etna, senza ascendere insieme
verso la vastità del firmamento.
È vero che lui serba così le distanze tra il suo popolo
e gli dei, e che attraverso il suo sacrificio il popolo dona a sé
stesso la costituzione repubblicana, perché "già
non è piú tempo di reggi". Ma il violento atto
del suicidio ci fa vedere palesemente che in questa figura non è
riuscita la vera conciliazione. E tuttavia il mondo greco non può
offrire un esempio più alto. Infatti Empèdocle muore
per amore degli uomini: ma non risulta ucciso dagli uomini stessi. E
lui s'uccide, credendo così di divenire un dio, mentre in realtà
si disgrega nell'indifferenziato grembo della terra.
Già il fallimento da parte di Hölderlin nella conclusione
del suo progetto del poema tragico Der Tod des Empedokles annunzia
a mio avviso una effettiva svolta del poeta verso Occidente, cioè
la terra dell'occaso. Ed è allora infatti che appare l'ultima
figura degli eroi. Inanzitutto in Brot und Wein e nei tre grandi
Inni: Friedensfeier, Der Einzige e Patmos, sorge
splendente la figura essenziale di Cristo, dove culminano e si
racchiudono tutte le manifestazioni possibili della congiunzione del
divino e dell'umano. È vero che ancora nella elegia Pane e
vino, l'apparenza di Cristo è quella propria di un Dio o
un eroe antico, e che lui scambia profilo e compiti con Dioniso, come
se Hölderlin cercasse disperatamente di tenere insieme il mondo
greco e l'espèrico. Ma risulta altamente significativo, lì
e ovunque, il fatto che il Cristo, contrariamente ai suoi arcaici "fratelli",
non riceve mai da Hölderlin un nome proprio. Come il Padre,
Cristo viene nominato sempre solo indirettamente. Lui è infatti
l'incrocio di una rete di rapporti: di preminenza (der Einzige),
di filiazione (der Sohn), di latría (Christus)
o di nascita (der Syrier). Mai viene chiamato invece col "dolce
nome" di Gesú.
Nei due ultimi versi della settima strofa di Brot und Wein, i
"sacerdoti sacri del dio del vino" rinviano ovviamente
ai riti dionisiachi. Ma il fatto "evangelico" del suo errare von Lande zu Land indica già il valore ecumènico
del cristianesimo. Allo stesso modo, è cristiano anche il loro
vagare in heiliger Nacht: il Cristo nato nel cuor della notte
per portare la luce al mondo, con la sua morte lo ha lasciato nelle
tenebre. Per questo Cristo è per Hölderlin: "welcher
des Tags Ende verkundet" (str. 8a, v. 6). Cristo: il Dio dell'Occidente,
il Dio del tramonto.
Cristo è venuto al mondo per morire. E soltanto con la sua morte
s'intravede una strana riconciliazione. È vero che così
il mondo resta immerso nella notte. Però, si tratta di una notte
sacra illuminata dalla luna (cf. la prima strofa di Brot und Wein),
la cui luce riflessa ci ricorda che il sole è da lungo tramontato.
Ma perché doveva morire il Cristo? Ebbene, lui è morto
per impedire l'eccesso d'entusiasmo del uomo. Certamente, una
volta c'era un uomo chiamato Gesú. Ma lui rimane adesso Uomo
soltanto come nascosto in un passato così irrimediabile come
indimenticabile. Ché l'uomo non deve insuperbirsi nella credenza
che a un suo congènere è riuscita la scalata dei cieli.
Esperia, la terra cristiana, la terra che guarda verso sera, ha quale
propria natura (secondo la celebre lettera di Hölderlin a Böhlendorff
del 1801) la chiarezza d'esposizione, l'arte di fare delle distinzioni
sulla base del fondo primigenio, giacché tutto un Dio —non
un suo messo, ovvero un simulacro— ha fecondato Tellure
col proprio sangue. Ma giustamente perciò (e qui ci troviamo
di fronte al paradosso massimo, al di là di tutta la dialettica)
l'Occidente deve imparare a far un uso libero di ciò che
gli è proprio soltanto nel seno dell'elemento a lui estraneo
e straniero: l'uso cioè del fuoco del cielo, il pathos proprio dei greci. E deve anche evitare la caduta in un pericolo inverso
a quello del popolo greco, il quale, nell'affanno di raggiungere la
contrapposta chiarezza espositiva, finì in un piatto alessandrinismo,
fissando ovunque divisioni, e magnificando il loro profilo e funzione
fino a identificare tutti i particolari del mondo col divino. Esaurita
d'erudizione, la Grecia si dilegua in Roma. Al contrario, Esperia corre
il rischio di confondere romanticamente tutti i generi nella "notte
delle vacche nere" e di lasciar così consumarsi ed assorbirsi
uomini e cose nel focoso Maëlstrom dell'Assoluto. Perciò
lo Hölderlin del 1800 non condivide la tradizione giovannea della
Redenzione come restitutio in unum, in integrum, esaltata in
altri tempi. Adesso, nei grandi Inni della piena maturità, viene
affermata invece una sorta di strana disseminazione spirituale,
sotto il riferimento certamente del Paracleto, presente agli eletti
nella figura delle lingue ígnee. Ma adesso sono queste
lingue plurali, come plurali sono i linguaggi umani, che parlano sul
e dal Medesimo (cioè dal Messaggio, da sempre già
scorso) sotto distinte configurazioni (oppure, nella terminologia Hölderliniana
del Tönenwechsel: che hanno lo stesso Grundton sotto
diversi Scheine o Kunstcharaktere). Ma ci resta ancora
da conoscere ciò che è a mio avviso il nucleo profondo
della concezione Hölderliniana. La morte di Cristo e l'avvento
dello Spirito ci porta alla fine la salvezza. Non si agisce qui però
della presunta salvezza dell'«anima immortale». Il
Cristo da sempre passato e lo Spirito da sempre a venire ci salvano
dalla presenza immediata del divino, trattenendo così a distanza,
tra la nostalgia e la speranza, il doppio giocare del lume e la luce.
Soltanto così è possibile la mediazione tra i due modi
estremi, ed indesiderabili, di vivere in der Gegenwart der Himmlischen:
da un lato lo sfrenato entusiasmo dello Schwärmer fanatico,
dall'altro l'abitudine ripetitiva e fredda, nella quale il culto diviene
finalmente cultura. La cultura morta di ciò che oggi chiamamo
«ragione strumentale».
Non con la sua nascita, ma con la morte di Cristo periscono anche gli
antichi dei: "Il grande Pan è morto". Ma questa
è ovviamente una morte sacra, e salutare per noi, uomini.
Infatti è la morte divina ciò che lascia essere il cielo
soltanto cielo, e non la dimora di Giove. È la morte del divino
ciò che lascia essere la terra soltanto terra, e non il regno
di Proserpina. Ma è inanzitutto la morte di Cristo ciò
che rende possibile ai mortali l'abitare, non la terra né
il cielo, ma sulla terra e sotto il cielo: la possibilità dunque
di conferire un senso poetico al giorno del geschäftiqe Markt (e cioè: della contraffazione temperata del cielo) ed
insieme alla Nacht / Voll mit Sternen, laddove brilla il Schattenbild
unserer Erde, der Mond (cf. Brot und Wein, str. la, vv. 6,
14, 15-17). L'immagine ombrosa della luna ci «redime» così
dalla troppo ardente luce solare della Grecia. E in questo modo si apre
uno spazio intermedio, guadagnato mediante la ritrazione del sacro...
Dove? Non certamente nel passato del Figlio, e nemmeno nell'avvenire
dello Spirito, perché entrambi restano per noi inconoscibili.
Il sacro si ritrae invece in uno «spazio» strano, in un'altra
presenza «lunare», tutta fatta di assenze che lasciano dietro
di sé un intreccio di orme silenti. Un allacciarsi, appunto,
d'impronte. Lo «spazio» del sacro è dunque la scrittura.
Ché ogni scrittura è sacra quando serba in sé i
confini del dicibile. Ogni scrittura può divenire così
poetica: canto della sera. E allo stesso tempo si apre così,
in virtù del ritiro del sacro nel canto poetico, la possibilità
del parlare profano. Con la Scrittura, laddove si nasconde la Parola
e il Silenzio di Dio, il sacro non è più presente, tanto
ierofanicamente (giacché la presenza immediata del divino è
mortífera per l'uomo) quanto in simulacro (il cui contenuto era
insomma preso a prestito, cioè provenente dai bisogni umani e
dalla disponibilità della natura). La morte di Cristo ha redento
dunque gli uomini della presenza dei Celesti, ed insieme da quella dell'aorgico
e del selvaggio. Ma il poeta mantiene, imminente ed a distanza, quella
presenza, spostata e quasi sospesa nel canto. Was bleibet aber, stiften
die Dichter. Così slegando l'origine dal suo impensabile
luogo, il poeta permette che ci sia una vita propriamente umana. Una
vita prosaica .
E tuttavia, una vita del genere non varrebbe la pena di esser vissuta
se non rimanesse tra di noi almeno "la traccia degli dei fuggiti"
(die Spur der entflohenen Götter. In: Brot und Wein,
str. 9a v. 5). Questa traccia si vede, in primo luogo, quasi come una
ferita sulla crosta del pane, contrassegnata dal fuoco. Del pane, che
lega gli uomini in comunità. E si vede anche nel vino, nel sangue
del profondo, se elevato al godimento del fuoco celeste, e che rinvia
allo Zwiefalt dell'ascosità di cielo e terra. Pane e vino:
sono, queste, donazioni di Dioniso. Di Dioniso, der Weingott.
Doni, presenti che ossequiano il tempo presente e che,
tuttavia, resterebbero insignificanti senza la loro consacrazione dalla
Parola, sospesa ed insieme imminente, del Dio morto e del Dio che viene.
Celebrazione dunque del Passato e dell'Avvenire. Mai presenti. Commemorazione
della Parola trattenuta nella memoria, detta par coeur, e «messa
in versi» nei versi del canto. La parola diviene così
l'incarnazione vivente della soglia mai oltrepassata. Se il
sacrificio di Cristo impedisce il fanatismo entusiasta di coloro che
con Lui hanno vissuto, l'orma di quella morte ed insieme di tutte le
morti degli innocenti (ma forse noi tutti siamo in fondo innocenti al
cospetto della morte), cioè la salda scrittura, impedisce
a sua volta la ripetizione meccanica e vuota del quotidiano commercium.
La parola scritta del poeta diventa così ricordo ed insieme promessa.
La promessa cioè des kommenden Gottes, del Príncipe
della Festa, colui che raggiungerà tutte le scissioni. Nel frattempo
(ma per l'uomo tutto il tempo della sua vita significa un «frattempo»),
è necessario serbare il presente della doppia minaccia del passato
e dell'avvenire. Tale è il Dichterberuf. Tra l'oscuro
servizio alla Madre Terra, proprio di Antígone, e la troppo focosa
attenzione edipica alla luce del Sole, a noi conviene adesso, a noi,
abitatori d'Occidente, onorare da un lato la memoria di una morte consegnata
nella scrittura, pronti all'impensabile e subitànea possibilità
di un ritorno del divino. Un ritorno sempre spostato e differito. Verso
la sera dei tempi. Ma d'altro canto veniamo anche chiamati al faticoso
compito di aprire, alla luce del laborioso presente, sentieri nella
zona temperata della vita, seguendo le traccie del poeta tedesco:
Wir haben gedienet der Mutter Erd
Und haben jüngst dem Sonnenlicht gedient,
Unwissend, der Vater aber liebt,
Der über allen waltet,
Am maisten dass gepflegt werde
Der feste Buchstab und Bestehendes gut
Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang.
(Patmos, ad fin.)

1)
Hölderlin. Werke und Briefe (cit. nel testo: WuB).
Hg. v. Fr. Beissner u. Jochen Schmidt. Frankfurt/M. 1969; II, 638.
|