 |
SCHERMA: LO SPORT |
Le regole del giocoGeneralità Come è noto lo sport della scherma prevede il confronto tra due atleti mediante l’utilizzo di particolari attrezzature chiamate armi. Nonostante il nome, gli attrezzi che vengono utilizzati hanno ben poco di offensivo e pericoloso: non c’è cosa più distante dal pensiero di uno schermitore che quella di cercare di fare male all’avversario e, d’altro canto, le normative che regolano la fabbricazione e l’utilizzo dell’abbigliamento e delle attrezzature in Italia sono talmente rigide da garantire un ampio margine di sicurezza. La scherma è uno sport individuale, gli incontri (assalti) avvengono sempre tra due atleti (tiratori) ed anche le gare a squadre non sono altro che sommatorie di incontri singoli. Questo naturalmente non significa che non esista spirito di squadra o strategie e tattiche da applicare negli incontri a squadre. Gli assalti si svolgono su particolari strutture (pedane), solitamente in materiale metallico, della lunghezza di almeno 14 metri e della larghezza di 1,5 - 2 m, anche se esiste comunque la tendenza ad accettare l’utilizzo di pedane larghe 1 metro. La lunghezza "utile" della pedana è di 14 m, anche se questa può raggiungere una lunghezza massima di 18 m. Ciò per permettere al tiratore, che eventualmente supera il limite dei 14 m, di indietreggiare su una superficie uguale ed unita. La scherma prevede tre diverse specialità. Queste prendono il nome dall’arma utilizzata ed hanno regole abbastanza differenti tra loro. Le armi utilizzate nella scherma sono il fioretto, la spada e la sciabola. Quest’ultima arma sarà probabilmente utilizzata nella scherma femminile a partire dall'anno agonistico 1998-99.
Sono poche le similitudini tra le diverse specialità, in tutte e tre scopo del gioco è toccare l’avversario con l’arma utilizzata (portare una stoccata), ma variano molto però la tecnica da utilizzare, la parte di attrezzo con la quale portare la stoccata ed il bersaglio da colpire.
Esistono armi convenzionali (ovvero regolate da convenzioni che stabiliscono un vantaggio da parte dell’atleta che sta compiendo una determinata azione) come il fioretto e la sciabola, e armi non convenzionali (la spada). |
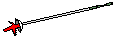 |
L’attrezzo prende il nome dallo speciale bottone, a forma di piccolo fiore, che veniva applicato in tempi storici sulla punta dell'arma per proteggersi da eventuali ferite. | Per la sua maneggevolezza e per la completezza del bagaglio tecnico richiesto per il suo utilizzo è l'arma che più si presta all’insegnamento di base della tecnica schermistica. Il fioretto è un'arma composta essenzialmente da:
La sua lunghezza complessiva non può superare 110 cm, mentre, quella della lama è 85 cm per le categorie giovanili fino ai 12 anni e 88-90 cm per tutte le altre categorie. Naturalmente esistono diverse tipologie di impugnatura (anatomica, francese, italiana ecc., ma quella sicuramente più utilizzata per il fioretto è l’anatomica), di presa di coccia (bipolare, a baionetta....), di punte (Carmina, Ponzi, ...) . In gara è obbligatorio utilizzare lame in acciaio Maraging: questa lega garantisce, in caso di rottura, un taglio netto della lama, in modo da ridurre la possibilità di formazione di pericolose estremità acuminate. Il peso complessivo dell’arma deve essere inferiore a 500 g.
|
Bersaglio valido: il tronco, ovvero tutto il corpo ad eccezione di gambe, glutei, fianchi, braccia e testa (vedi immagine). I fiorettisti indossano un particolare giubbetto in lamina metallica che delimita il bersaglio valido. Se questo indumento viene colpito con la punta del fioretto dell’avversario nell’apparecchio segna-stoccate si accende una luce colorata, (rossa o verde). Se un atleta viene toccato fuori bersaglio nell’apparecchio segnalatore si accende una lampadina bianca. | 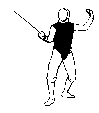 |
Convenzioni: come anticipato poc’anzi il fioretto è un’arma convenzionale, è quindi basata su particolari regole per l’assegnazione dei punti: Viene attribuito un vantaggio iniziale all’atleta che attacca, ovvero che avanza minacciando con l'arma l'avversario. Chi si difende può annullare questo vantaggio con una parata ovvero colpendo con la propria lama quella dell’altro atleta, in questo modo il vantaggio passa a suo favore e così via. Al primo dei due, in possesso di detto vantaggio, che colpisce con la punta del fioretto l’avversario in bersaglio valido viene assegnata una stoccata corrispondente ad un punto in gara. Quindi anche se entrambi gli atleti, nella stessa azione (nello spazio di 1/25 di secondo), vengono toccati in bersaglio valido: o soltanto uno viene considerato toccato (quello privo del vantaggio) oppure, se si tratta di un'azione simultanea di attacco, la fase viene annullata e si riprende l’assalto dal punto della pedana presso il quale è stato interrotto. Analogamente se chi attacca colpisce chi si difende in bersaglio non valido e chi si difende contemporaneamente colpisce in bersaglio valido, viene sancito un nulla di fatto e si riprende l’azione come nel caso precedente. L'attacco diretto e la parata non sono naturalmente che le più semplici azioni del fioretto, per ovvi motivi di spazio possiamo solo accennare ad altri movimenti basilari come la battuta e botta, azione di attacco che consiste nel toccare la lama dell'avversario prima di colpire il medesimo; la cavazione, che consiste nello spostare la propria lama, senza toccare quella dell'avversario, dopo aver fatto in modo che quest'ultimo andasse a cercare il ferro in una determinata posizione dello spazio; la chiusura, che consiste nel portare la stoccata in modo che la reazione dell'avversario sia in qualche modo bloccata da questo movimento; l'arresto che consiste nel colpire l'avversario mentre la sua azione di attacco è ancora in fase di preparazione. Viene considerato attacco, inoltre, il protendere l’arma verso l’avversario tenendo il braccio disteso in avanti e formando una linea (questo è il nome della posizione) continua tra spalla, braccio e arma. Questi concetti di base, apparentemente complessi per la difficoltà intrinseca del tipo di descrizione, ma in realtà relativamente semplici, si complicano, e non poco, quando si tratta di decidere a chi assegnare il vantaggio convenzionale (priorità). È infatti talmente ampia la casistica delle possibili azioni schermistiche e talmente rapido l’evolversi delle azioni e dei movimenti che risulta spesso difficile ricostruire lo svolgimento dei fatti per potere attribuire i punti. |
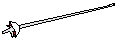 |
La spada è ritenuta da alcuni (quasi tutti spadisti) la vera scherma, sia per le caratteristiche dell'attrezzo, più simile degli altri alle armi utilizzate in passato nei combattimenti, sia perché non prevede convenzioni di sorta: chi tocca con la punta della spada l’avversario per primo fa punto, se lo tocca e contemporaneamente viene toccato (entro 1/25 di secondo) viene assegnato un punto a ognuno dei due atleti. | Convinti del fatto che non esista un'arma più "scherma" di altre, dobbiamo comunque dare atto a questa specialità che, grazie all'assenza di convenzioni, essa risulta essere una disciplina decisamente più comprensibile ai profani rispetto a fioretto e sciabola, anche se gli incontri offrono talvolta una dose inferiore di spettacolarità dal punto di vista atletico.
L'’attrezzo:
Come per il fioretto la sua lunghezza complessiva non può superare 110 cm, mentre, quella della lama non può superare i 90 cm. Anche in questo caso possono essere utilizzate diverse tipologie di impugnatura, molto diffusa risulta essere quella Francese. In gara è obbligatorio l'uso di lame in acciaio omologato FIE. Il peso complessivo dell’arma deve essere inferiore a 770 g. |
| Bersaglio: tutto il corpo. Proprio perché il bersaglio valido è tutto il corpo, piedi compresi, in questa specialità assume particolare importanza la messa a terra della pedana. Questo accorgimento, obbligatorio per tutte le discipline della scherma, impedisce che, qualora la punta dell'arma venga a contatto con la pedana, l’apposito apparecchio segnali la stoccata. | 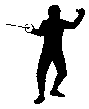 |
Convenzioni: come accennato precedentemente, nella spada non esistono convenzioni, fa punto chi tocca l'avversario almeno un venticinquesimo di secondo prima dell’altro, sia che questi sia in attacco, sia che si stia difendendo. Nel caso entrambi gli atleti vengano toccati contemporaneamente (sempre all'interno del venticinquesimo di secondo) viene attribuito un punto per ciascuno (punto doppio). |
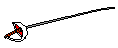 | L’arma, fino all'annata 1997-98, "per soli uomini" è anche quella che ha conosciuto più recentemente il sistema elettrico di segnalazione delle stoccate (1988) ed è anche la meno praticata in assoluto. Caratteristica peculiare di questa specialità è la possibilità di portare la stoccata, oltre che di punta (come nel fioretto e nella spada), anche di taglio e controtaglio. |
|
L'attrezzo: la sciabola è un’arma composta essenzialmente da
| |
| Bersaglio: la parte del corpo dal bacino in su, compresi quindi arti superiori e testa (vedi immagine). Gli sciabolatori delimitano la zona di bersaglio valido indossando un giubbetto in tessuto metallico a maniche lunghe ed una speciale maschera, anch'essa in grado di garantire la conducibilità elettrica. Dall'annata 2000-2001 il dorso della mano armata non costituisce più bersaglio valido. | 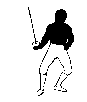 |
Convenzioni: le convenzioni nella sciabola sono grosso modo le medesime del fioretto, non sono però ammessi alcuni movimenti come l'avanzamento a passo incrociato o la fleche.
Oltre alle armi, già precedentemente descritte sono necessari:
Ulteriore complicazione legata ai materiali per la pratica della scherma è la scarsa diffusione di punti vendita. Pur esistendo in Italia diversi produttori di materiali, infatti, nessuno di questi vende la propria merce attraverso la normale rete di distribuzione commerciale di prodotti sportivi. Gli acquisti vengono solitamente fatti per corrispondenza tramite le singole società oppure presso gli stand presenti alle maggiori manifestazioni sportive di settore.
Per quanto riguarda le prove individuali: nella prima fase gli atleti iscritti alla gara vengono suddivisi, in base al loro ranking, in diversi gruppi (in media di 5-7 atleti) all’interno dei quali ognuno affronta tutti gli altri (girone all’italiana). In base ai risultati di queste poule iniziali viene stilata una prima classifica; da questa vengono eliminati gli ultimi classificati, fino ad un massimo del 20-30% degli atleti in gara e vengono suddivisi i restanti in base ad un unico tabellone ad eliminazione diretta.
Nei singoli incontri di poule viene considerato vincitore chi per primo raggiunge i cinque punti, oppure l'atleta che si trova in vantaggio al termine dei quattro minuti effettivi di assalto. Negli incontri della seconda fase (fase di eliminazione diretta) gli incontri terminano ai 15 punti e si svolgono su un periodo massimo di tre tempi di tre minuti effettivi intervallati da un minuto di riposo.
Nelle gare a squadre non vengono effettuati i gironi all’italiana della prima fase delle prove individuali e si procede direttamente al tabellone di incontri diretti stilato in base al ranking degli atleti che compongono la squadra. La finale è solitamente a quattro squadre.
|