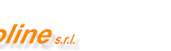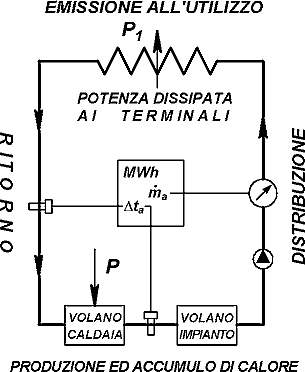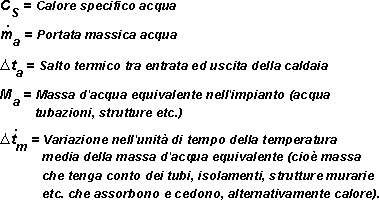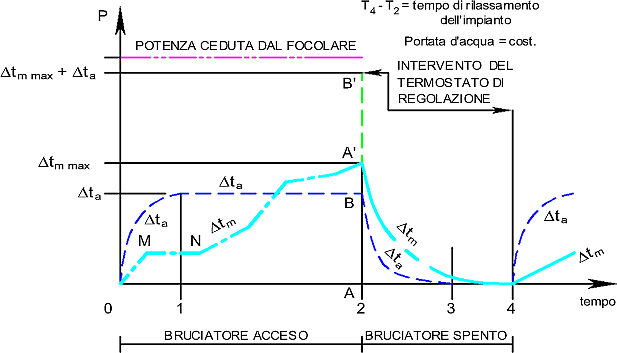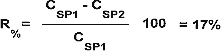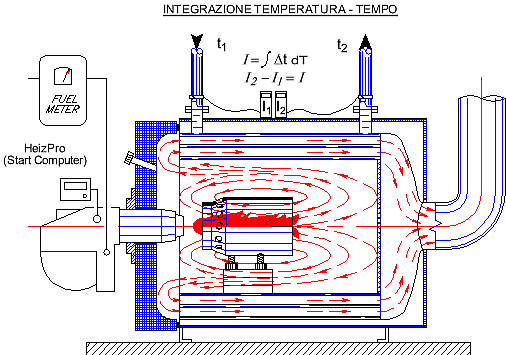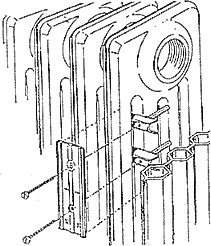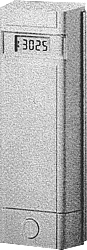La diffusione del contenuto del presente documento è consentita previa autorizzazione della Tecnoline srl
La diffusione del contenuto del presente documento è consentita previa autorizzazione della Tecnoline srl
1. PREMESSA
Da alcuni anni ci stiamo interessando ad interventi mirati al risparmio energetico nelle caldaie e, più in particolare, nei gruppi termici a bruciatore soffiato: avendo individuato dei dispositivi che ci hanno colpito per la loro efficacia, nel corso delle loro applicazioni abbiamo osservato che molti operatori, per le misure energetiche, seguono procedure che, per la loro complessità, implicano lunghi tempi di osservazione e, molto più frequentemente di quel che si potrebbe pensare, con risultati di dubbia attendibilità (come abbiamo intenzione di dimostrare).
E' tipico, ad esempio, che i protocolli di verifica si basino su una serie di misure quali
- portate d'acqua in circolazione
- differenze di temperatura tra andata e ritorno in caldaia
- portate di combustibile (per i combustibili liquidi spesso basate su portata nominale ugello e pressione misurata di
iniezione)
- tempi di funzionamento del bruciatore (ove occorre ben chiarire la necessità di escludere i tempi di preventilazione ed
annotare il funzionamento di ogni singolo stadio) senza tenere conto che i consumi energetici sono influenzati anche da altri
fattori, agenti a bruciatore fermo, come il volano termico dell'acqua contenuta nell'impianto e le perdite per tiraggio naturale.
Altre volte abbiamo visto questi protocolli avere la pretesa di raggiungere una precisione dell'uno per cento sui consumi ma che, in realtà, non riuscivano ad apprezzare nemmeno diverse unità percentuali di miglioramento del rendimento convenzionale di combustione (conseguenza diretta dell'abbassamento della temperatura dei fumi che normalmente si accompagna alle applicazioni dei dispositivi di cui stiamo parlando).
Un metodo assai accreditato consiste nell'applicazione di un megawattorometro (ci si passi l'apparente guazzabuglio verbale per indicare un misuratore di MWh) nell'impianto: ma ne abbiamo individuato una inevitabile fonte di errore quando si basa sulla misurazione della differenza di temperatura tra entrata ed uscita in caldaia del fluido vettore.
Questa metodologia implica l'installazione di un contatore d'acqua nella tubazione in cui scorre il fluido vettore di calore e di due sensori di temperatura a cavallo della caldaia: è tipicamente intrusiva, quindi, ma vedremo subito che non è in grado di apprezzare appieno gli effetti associati al volano termico dell'impianto.
2. IL METODO WATTOROMETRICO
Questo metodo si avvale del megawattorometro per misurare l'energia fornita all'acqua dalla caldaia; determinando separatamente i consumi di combustibile, relativi al medesimo periodo, è possibile stabilire quanto è il calore fornito all'acqua da ogni unità di massa (o di volume) di combustibile (Wh/kg oppure Wh/m3).
Eseguendo la misurazione prima e dopo l'applicazione dei dispositivi di risparmio sembrerebbe di poter confrontare con precisione le energie specifiche ottenute. Invece i risultati deludenti del metodo, diverse volte registrati, ci ha spinto a studiarne i limiti giungendo ad una inattesa quanto decisa stroncatura del metodo per i motivi che seguono.
Nella Fig. 1 è rappresentato un modello d'impianto di riscaldamento: ai nostri fini è importante distinguere l'effetto di volano termico della sola caldaia da quello della rimanente parte dell'impianto.
Abbiamo, perciò, segnato due volani termici distinti, concentrando e separando l'effetto inerziale della caldaia da quello dell'impianto, mentre gli altri simboli grafici hanno un significato ovvio.

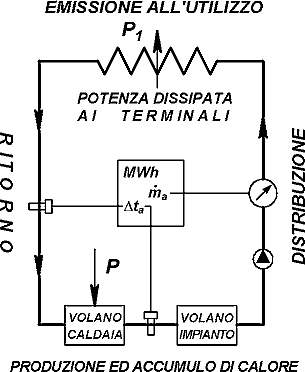
 Figura N° 1: Modello fisico-matematico d'impianto di riscaldamento.
Figura N° 1: Modello fisico-matematico d'impianto di riscaldamento.
La potenza termica fornita dal bruciatore in parte incrementa il delta t tra l'entrata e l'uscita dell'acqua in caldaia ed in parte aumenta la temperatura media di tutto l'impianto in modo da soddisfare in ogni istante la seguente equazione:

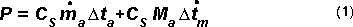
dove:
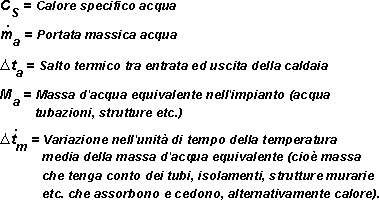
Innanzitutto si possono distinguere due casi limite: se l'impianto assorbe tutta la potenza ceduta dal bruciatore all'acqua il secondo addendo a secondo membro della (1) è nullo (il bruciatore lavora continuamente e la temperatura media dell'impianto non varia nel tempo, ovvero la sua derivata temporale è nulla, come nel tratto di figura2) invece il primo addendo è nullo quando la portata d'acqua è nulla (la caldaia diventa un pentolone ed il calore che vi viene introdotto contribuisce ad aumentare la temperatura media dell'impianto).
Dev'essere, inoltre, chiaro che in condizioni normali di funzionamento l'andamento di delta t a è funzione esclusiva della portata d'acqua in caldaia e della potenza termica ceduta all'acqua, mentre l'andamento di delta t m punto non è pilotabile in caldaia perché si tratta di una variabile che dipende dalla dissipazione dei terminali dell'impianto.
Nella figura 2 è rappresentato l'andamento nel tempo di un ciclo del bruciatore (costituito da una accensione e da uno spegnimento) con le variabili che ci interessano P, delta t a, delta t m punto da pensarsi in ordinata ciascuna con le proprie unità di misura.

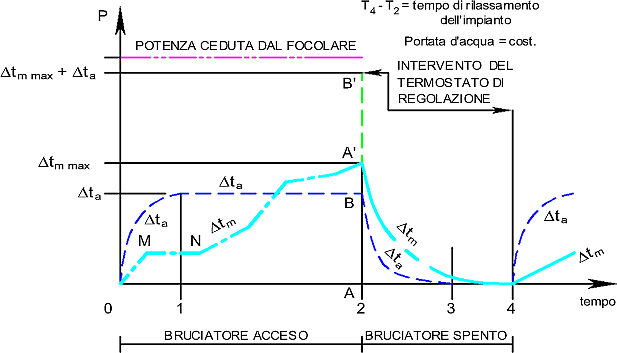
 Figura N° 2: Vicende termiche nel corso di un ciclo completo del bruciatore (a portata d'acqua costante).
Figura N° 2: Vicende termiche nel corso di un ciclo completo del bruciatore (a portata d'acqua costante).
Nell'intervallo di tempo tra 0 e 1 la potenza introdotta P è in parte dissipata dai terminali ed in parte "volanizzata" in tutto l'impianto: questa verrà restituita tra 2 e 4, in omaggio alla conservazione dell'energia.
Tra 1 e 2 il calore assorbito dai volani termici non è registrato dal megawattorometro (è registrata solo quella parte che provoca il salto termico stazionario delta ta) perché, pur continuando ad aumentare la temperatura media dell'acqua, le temperature all'entrata ed all'uscita della caldaia salgono parallelamente.
Quando si spegne il bruciatore, per il raggiungimento del valore prefissato sul termostato di regolazione (al tempo 2), i volani termici restituiscono ai terminali dissipatori l'energia accumulata: è, però, evidente che tra 2 e 3 l'energia restituita dal volano impianto non è rilevata dal misuratore che, addirittura, al tempo 3 cessa di contabilizzare energia (si è azzerato il salto termico in caldaia) mentre il volano impianto continua ad erogarne (forse ancor più della caldaia) perché, a bruciatore spento e con terminali dissipanti, è a temperatura media maggiore della caldaia.
Si verifica, pertanto, una situazione di conteggio energetico sempre in difetto in modo variabile e dipendente dall'incidenza dei volani termici (il che implica diversi fattori: dalla quantità d'acqua fuori e dentro caldaia all'intermittenza di funzionamento, dal valore del differenziale del termostato alla potenza introdotta nel focolare, dal carico termico istantaneo alle condizioni climatiche esterne).
Vediamo di apprezzare, almeno approssimativamente con dati verosimili, un valore possibile dell'errore di lettura dello strumento: supponiamo che il contenuto d'acqua equivalente sia di 1.000 kg; secondo i sacri canoni (Raccolta R, 8.1) si potrebbe trattare di un focolare da 80 kW.
Un'ipotesi accettabile è che il contenuto equivalente d'acqua del volano impianto sia il 50% del totale e che il salto termico di caldaia si annulli quando il volano termico impianto abbia disponibile ancora un delta t = 2 K, pari ad un terzo del differenziale del termostato di regolazione. L'energia minima che certamente sfugge al conteggio sarà: E = 500 x 2 x 1,163 = 1.163 Wh.
Se il gruppo termico effettua dieci cicli orari (e purtroppo la media ci sembra anche più alta) l'energia non contabilizzata in un'ora sarà di 11.630 Wh, la corrispondente potenza è pari a circa il 15% del focolare.
Il lettore avrà osservato che l'inghippo nasce dal posizionamento delle sonde di temperatura: la seconda (cioè quella all'uscita dalla caldaia) non può proprio essere messa a valle del volano impianto (esiste l'impianto e non il volano impianto che è un elemento del modello fisico-matematico): se la lettura dell'energia volanizzata non si può fare a cavallo della caldaia quando il salto termico sulla stessa è invariante, non resta che farla all'atto della sua estrazione dal volano stesso; ciò è possibile solo per quanto riguarda la caldaia (e non la rimanente parte dell'impianto): ciò costituisce un limite intrinseco dello strumento in questa applicazione.
3. CONCETTO DI CONSUMO SPECIFICO DELL'EDIFICIO E IL METODO DEI GRADIGIORNO
Un metodo classico, perché sovente usato dai gestori di calore, rapporta il consumo di un dato periodo temporale ai relativi gradigiorno ottenendo un dato che chiameremo "consumo specifico dell'edificio" (in questo caso la sua unità di misura sarà kg/GG per il gasolio e m3/GG per il gas): dal confronto tra i consumi specifici riferiti a due periodi qualunque, con e senza dispositivi di risparmio, si può ottenere una misura dell'efficacia del dispositivo stesso.
Questo, che ci risulta il metodo non intrusivo più diffuso, ci pare tra i meno peggio anche perché tiene contemporaneamente in conto dell'interazione complessiva dei tre elementi essenziali: funzionamento dell'impianto, involucro dell'edificio ed andamento climatico della stagione.
Tra i suoi limiti si deve annoverare che
- variando gli orari di funzionamento dell'impianto si cambia la temperatura esterna effettiva di funzionamento e quindi il
consumo specifico, a parità di tutte le altre condizioni
- quando il periodo di osservazione si protrae verso temperature medie esterne decrescenti (andando incontro all'inverno)
l'inerzia termica dell'edificio può tendere a far apparire più bassi i consumi specifici, viceversa in periodi di temperature
medie esterne crescenti (andando verso la primavera)
- sono necessari tempi lunghi (almeno un paio di settimane) per ottenere dati attendibili
- in presenza di vento l'adduzione all'involucro dell'edificio può equivalere ad una temperatura esterna più bassa. Ad esempio
i tecnici di Trieste sostengono che un vento a 10 km/h equivale ad una temperatura esterna minore di un kelvin (la questione
è trattata anche dalle Norme UNI 7357 al punto 7.1.1.2.)
- la temperatura media, ponderata nel tempo, comunicata dall'Osservatorio può differire anche sensibilmente (due, tre Kelvin
o più) dalla temperatura media ponderata del luogo dove si effettua la prova.
Va comunque ribadito un concetto fondamentale: il calcolo dei risparmi ottenuti da una determinata applicazione va effettuato confrontando il valore dei consumi specifici, relativi ad un dato riferimento (per esempio il gradogiorno), prima e dopo l'applicazione stessa.
4. IL METODO DEL DELTA t A PORTATA COSTANTE
Un metodo di misura del risparmio energetico che richiede tempi brevi per il confronto tra il "prima" e il "dopo" l'applicazione del dispositivo atto a produrre il risparmio stesso (v. Atti del 52° Convegno Nazionale dell'Energia, Cernobbio 22-26 Sett. 97, pag. 655 e segg., ripreso da "L'Installatore Europeo" N° 10/98) ci sembra meriti attenzione anche per la buona attendibilità dei risultati.
Riassumiamone la filosofia: poiché la potenza ceduta al fluido vettore di calore (generalmente acqua) dal gruppo termico produce una differenza di temperatura tra entrata e uscita oltrechè un incremento della temperatura media dell'acqua, d'accordo con la (1), si renda costante la portata in caldaia (generalmente è sufficiente fissare manualmente la valvola di 'egolazione climatica tutta aperta) allora una variazione nel salto termico misurato, in regime stazionario (cioè quando l'impianto dissipa tutta la potenza trasmessa all'acqua), sarà proporzionale alla variazione di potenza assorbita dal fluido vettore.
La strumentazione da noi adottata è di alta qualità pur nella sua semplicità: un registratore di temperatura (stampante, ad intervalli discreti, le temperature di andata e ritorno e la loro differenza, con intervalli riducibili anche a soli quindici secondi) ed un contatore di combustibile sono gli unici strumenti usati (il combustibile può venire conteggiato anche indirettamente).
La prova richiede tempi limitati ed è stata concepita per ottenere il dato di risparmio immediatamente nel corso dell'applicazione del dispositivo di risparmio. Il misuratore di temperatura ha il potere risolutivo di un decimo di Kelvin e la progressione delle stampate permette di seguire con attenzione la "rampa" del regime transitorio fino al raggiungimento del delta t corrispondente al regime stazionario (o permanente che dir si voglia).
In generale l'effetto del dispositivo applicato è quello di produrre un incremento del delta t misurato tra andata e ritorno a parità di tutte le altre condizioni.
Se, come è conveniente (v. Atti pag. 659 e "L'Installatore Europeo" citati), prima della seconda misura si procede ad una riduzione di portata di combustibile il delta t potrebbe variare di poco (o anche rimanere costante).
Ad ogni modo il rapporto tra la portata di combustibile ed il delta t ottenuto (a regime) rappresenta un consumo riferito all'ottenimento di un incremento di temperatura di 1 K cosicché il confronto tra questi consumi specifici prima e dopo l'applicazione consente di risalire al risparmio energetico relativo realizzato.
Fissiamo le idee con un esempio numerico: un gruppo termico consuma portata1=100 m3/h di combustibile producendo un delta t1=10 K; dopo l'applicazione di un Ottimizzatore Ceramico la portata viene ridotta a portata2=75 m3/h ottenendo un delta t2=9 K.
Poiché i due consumi specifici sono CSP1 = 10 m3/h K; CSP2 = 8,3 m3/h K, in termini percentuali, avremo un risparmio percentuale:

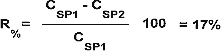
La precisione del dato dipenderà da molti fattori, alle volte (almeno nei dispositivi che sfruttano le proprietà del Corpo Nero) l'effetto dell'applicazione si manifesta lentamente ma progressivamente, finché la camera di combustione non si ripulisce delle proprie incrostazioni, grazie alla maggiore radiazione attiva. A vantaggio della precisione rimane il fatto che, nell'effettuare le differenze di temperatura gli errori dello stesso segno si compensano e, se si riesce ad operare in regime stazionario, gli effetti di volano termico non disturbano le misure.
5. IL METODO ENDL
Un protocollo di misura, ricorrente ad unità energetiche arbitrarie variabili da impianto ad impianto, che unisce tempi ragionevoli per il rilevamento dei dati di consumo ad una grande semplicità di strumentazione ed una discreta attendibilità è stato messo a punto recentemente dal ricercatore tedesco Bernhard Endl, con il quale da anni manteniamo rapporti di mutua collaborazione.
Poiché il bilancio energetico del gruppo termico è rappresentato dalla (1) che, per comodità, riscriviamo:

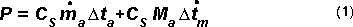
è ragionevole pensare che il contributo dei due addendi alla potenza P sia un rapporto caratteristico dell'impianto per ciascun regime di funzionamento e quindi che la misura del primo implichi l'apprezzamento del secondo.
Poiché è facile misurare con precisione il delta ta più di qualunque altra delle variabili che compaiono nella (1) osservando che esso è influenzato anche dalla portata di caldaia e dal funzionamento del bruciatore è nata l'idea di assumere la funzione


dove:

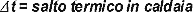



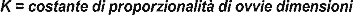
e gli altri simboli hanno il significato già detto, come rappresentativa dell'andamento della trasmissione di calore dalla caldaia all'impianto.
Delle grandezze che compaiono nella (2) ma punto è la più difficile da misurare (occorrerebbe inserire il già visto contatore ad impulsi nella tubazione di entrata o di uscita dalla caldaia): ma poiché le sue variazioni si ripercuotono immediatamente sul delta t, la funzione delta t(T) (essendo T il tempo di osservazione) contiene anche informazioni sulla portata.
Il tempo di funzionamento del bruciatore, e quindi il consumo di combustibile, dipende a sua volta da delta t(T) perché il bruciatore stesso è termostatato. A portate d'acqua minori (maggiori) corrispondono delta t maggiori (minori) e, quindi, tempi di funzionamento del bruciatore minori (maggiori).
In base a queste considerazioni una quantità elementare di combustibile è pensabile, dalla (2), legata al delta t nei seguenti termini:

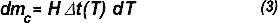
dove H è una nuova costante con le ovvie unità di misura.
Integrando separatamente le variabili si ottiene:

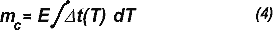
dove E, al solito, ha le unità di misura necessarie e congloba le costanti di integrazione.
Applicando questo concetto si misura il valore assunto nel tempo dalla funzione a secondo membro della (4) con degli integratori temperatura-tempo, disponibili correntemente, sul tipo di quelli usati nella ripartizione dei consumi energetici (tipicamente nei condominii).
Si tratta di dispositivi a microprocessore (molto noti i Techem da noi adottati) in grado di risolvere un centesimo di kelvin e dotati di un orologio al quarzo di estrema precisione associati ad una pila al litio in grado di alimentarli per dieci/dodici anni: essi forniscono un valore numerico proporzionale all'integrale a secondo membro della (4) che, entro limiti generalmente accettabili, è tipico di ogni impianto.
Lo schema dell'applicazione è riportato nella Figura N° 3.

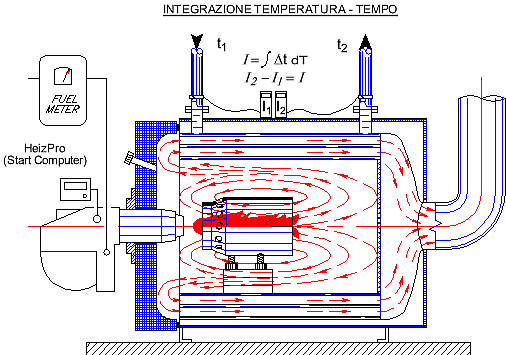
 Figura N° 3: Una delle disposizioni strumentali tipiche per i rilievi energetici con l'adozione di ripartitori.
Figura N° 3: Una delle disposizioni strumentali tipiche per i rilievi energetici con l'adozione di ripartitori.
Indicando con I il valore numerico fornito dall'integratore, dalla (4) si ottiene la semplice formula che proponiamo:
. 

E è una costante tipica dell'impianto che corrisponde al consumo specifico riferito alle unità rilevate dall'integratore.
L'applicazione di questo metodo (peraltro estensibile ad altri fini) consente di confrontare i consumi energetici con sufficiente precisione in tempi relativamente brevi (per esempio due settimane) avendo ridotto ai minimi termini le misure da effettuare, adottando un'attrezzatura semplice, precisa e poco costosa.
La lettura dell'integratore si effettua su di un display digitale (a cinque cifre) mentre la massa di combustibile consumato, nella peggiore delle ipotesi in mancanza di un contatore dedicato, si ottiene integrando la portata nel tempo.
A questo fine ci si può avvalere di un nuovissimo prodotto: il "Brennerstartcomputer" (computer per le partenze del bruciatore, denominato brevemente Heiz-Pro) che fornisce i tempi di funzionamento della fiamma su due gradini (oltre alla programmazione ottimale delle partenze del bruciatore secondo diversi programmi a scelta dell'installatore di cui parleremo in seguito).
Facciamo un esempio numerico tratto dalla nostra esperienza in proposito: su di un impianto sono stati applicati gli integratori (andata e ritorno) per una settimana registrando un consumo di 3.836 m3 di metano con 72 unità arbitrarie di energia: il consumo specifico è risultato, quindi, di 53,27 m3/u.a.e..
La settimana successiva, applicati i dispositivi atti al risparmio, il consumo è stato di 3.156 m3 con 78 u.a.e.: il nuovo consumo specifico è 40,46 m3/u.a.e.. Si deduce, quindi, un risparmio energetico percentuale del 24%.
Possiamo, quindi, dire che in questo caso nella prima settimana ogni unità fornita dall'integratore corrispondeva a 53,27 m3 di metano (circa 533 kWh/u.a.e.), mentre nella seconda settimana corrispondeva a 40,46 m3 (circa 405 kWh/u.a.e.).
6. IL PROGRAMMATORE DI PARTENZE
Più di un costruttore sta introducendo sul mercato (li abbiamo visti associati a sistemi di telecontrollo) dei dispositivi elettronici a microprocessore in grado di programmare cicli di ritardo, nelle partenze dei bruciatori, con risultati di risparmio a volte incredibili (abbiamo verificato anche R% > 5%). Essi riducono drasticamente il numero di partenze del bruciatore nell'unità di tempo (abbiamo registrato riduzioni anche maggiori del 60%; un caso per tutti: su di un impianto senza programmatore 18,6 partenze/ora, con programmatore soltanto 5,9; osservazione fatta in due settimane successive nel mese di dicembre 97).
L'intermittenza di funzionamento del bruciatore e la sua influenza sulle perdite energetiche è stata evidenziata dallo scrivente nel Convegno Nazionale di Cernobbio (Atti pag. 660) e su "L'I. E." 10/98.
Le perdite sono imputabili principalmente a:
- tiraggio naturale a bruciatore fermo (la caldaia contribuisce a riscaldare "l'universo cosmico" e non l'impianto utilizzatore)
- tiraggio forzato alla partenza durante la fase di preventilazione (questa perdita, assieme alla prima, forma quel che
possiamo chiamare perdite al camino in assenza di fiamma)
- combustibile incombusto durante il transitorio d'innesco della fiamma
- incompleta combustione fino alla stazionarietà dell'afflusso di combustibile e della fiamma.
Annoveriamo, inoltre, tra i guadagni diretti lo stabilirsi di una temperatura media dell'acqua dell'impianto minore (senza disagio per gli utenti perchè contenuta entro i limiti di capacità di adattamento della regolazione compensata di centrale), con i conseguenti benefici tipici degli impianti a più bassa temperatura.
In condizioni che si possono verificare comunemente abbiamo calcolato che le sole perdite al camino possano superare largamente il 10% (Atti e "L'I. E."). Considerate insieme le quattro cause di perdita descritte, è intuitivo quanto possa essere utile una riduzione dell'intermittenza.
Non si deve, anche, trascurare il prolungamento della vita del bruciatore con le ovvie conseguenze sui costi di manutenzione per la diminuzione dei guasti elettromeccanici.
La GSH di Norimberga, che lavora da anni per l'ambiente e per il risparmio, sta presentando il programmatore prima citato, l'HeizPro in Figura N° 4, che è dotato di cinque programmi che si selezionano commutandoli ciclicamente con un pulsante:
- Programma Zero: Non modifica i comandi del termostato di regolazione
- Programma N° 1: Applicazioni industriali
- Programma N° 2: Condominii
- Programma N° 3: Residenze bi- o tri-familiari
- Programma N° 4: Adatto per residenze monofamiliari.


 Figura N° 4: Il programmatore di partenze del bruciatore (Brennerstartcomputer).
Figura N° 4: Il programmatore di partenze del bruciatore (Brennerstartcomputer).
Si può applicare ai bruciatori mono- e bi-stadio ed anche a quelli di tipo atmosferico fino alle caldaiette murali.
Fornisce dati molto utili sulle modalità di funzionamento, quali:
- Numero di partenze per ciascun stadio
- Tempo di funzionamento di ogni stadio
- Durata temporale dell'accensione in atto.
Consente, quindi, di archiviare dati importanti per la statistica di conduzione (controllo dei consumi) e di manutenzione (controllo di anomalie nelle modalità di funzionamento).
La conoscenza del tempo di fiamma e della portata del bruciatore può essere inoltre utile per rivelare ammanchi di gasolio per foratura del serbatoio (o per opera d'uomo!).
7. RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO
La ripartizione delle spese di riscaldamento può indurre gli utenti ad autocontrollare i consumi ottenendo risparmi significativi: essa si può effettuare applicando un integratore temperatura-tempo (ripartitore) su di ogni piastra radiante.
Ogni ripartitore è fissato alla piastra radiante di cui si deve misurare l'energia emessa nel modo indicato nella Figura N° 5.

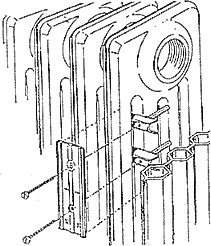
 Figura N° 5: Schema del fissaggio di un ripartitore al relativo terminale.
Figura N° 5: Schema del fissaggio di un ripartitore al relativo terminale.
Per mezzo di due sensori è in grado di misurare la temperatura ambiente e la temperatura superficiale del radiatore integrando la differenza nel tempo.
Prima di montarlo viene configurato in modo da sapere qual è l'emissione termica del terminale su cui viene applicato (ad esempio 2.000 W): né questo né gli altri dati impostati in sede di installazione e nemmeno i dati acquisiti durante il funzionamento sono alterabili da parte dell'utenza.
I dati possono essere teletrasmessi in modo che le letture non richiedano di disturbare l'inquilino
Il totale dei numeri annotati dai ripartitori viene fatto corrispondere al consumo totale di combustibile: in questo modo ogni unità del ripartitore finisce per rappresentare una quantità equivalente di unità energetiche.

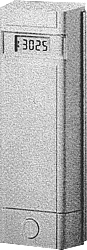
 Figura N° 6: Ripartitore di consumo in posizione di lavoro.
Figura N° 6: Ripartitore di consumo in posizione di lavoro.
Le caratteristiche funzionali di un buon ripartitore sono:
- Rilevamento continuo di due temperature: superficiale del radiatore e dell'ambiente (senza renderle leggibili)
- Data di avvio del conteggio programmabile
- Il giorno della lettura può essere programmato liberamente anche dall'utente
- Azzeramento automatico del display nel giorno stabilito con memorizzazione del precedente contenuto
- Autodiagnostica ogni due minuti e messaggio di guasto con archiviazione dell'istante in cui si verifica
- Riproduzione delle caratteristiche del radiatore
- Identificazione estate/inverno
- Memorizzazione di due periodi di riscaldamento precedenti.
8. CONCLUSIONE
L'applicazione di dispositivi in grado di produrre risparmio di combustibile è possibile ed ha degli effetti indotti sull'ambiente di grande rilievo: le portate di massa dei camini possono diminuire anche del 20% e la qualità dei fumi migliorare verso l'assenza di fuliggine e di Ossido di Carbonio.
Alcuni sistemi (come il programmatore delle partenze del bruciatore) hanno dei costi così contenuti che, se confrontati con i risparmi ottenibili sui consumi e sulla manutenzione del bruciatore, si pagano da sé in pochi mesi!
Dobbiamo registrare che, malgrado la voce combustibile+manutenzione sia la più consistente nel bilancio economico generale di qualunque utenza di tipo condominiale, ci sono molte resistenze irrazionali all'adozione di nuovi sistemi: l'immagine del bruciatore che brucia denaro e produce, a volte, anche veleni dovrebbe essere ben più radicata nella mentalità comune ed indurre tutti alla ricerca di configurazioni energetiche veramente ottimali.
Riassunto:
Il mercato presenta molteplici dispositivi che, applicati alle caldaie degli impianti di riscaldamento, tendono a produrre minori consumi a parità di prestazioni degli elementi terminali (nella maggior parte dei casi piastre radianti).
Si è visto che la determinazione dell'efficacia di ciascuno di tali dispositivi è non facile e, a volte, contraddittoria o insoddisfacente (come con l'adozione di wattorometri). Alle volte sono necessari tempi lunghi di osservazione per cui si sono escogitati sistemi in grado di conciliare tempi di prova brevi con risultati attendibili.
Tra i nuovi metodi che qui si propongono, oltre a quello classico dei gradigiorno, si esamina il metodo del delta t e quello degli integratori temperatura-tempo che richiedono una strumentazione facilmente reperibile sul mercato e non sono intrusivi: con questa metodologia la procedura diventa rapida ed attendibile.
E' essenziale introdurre il concetto di "consumo specifico" dell'impianto inteso come quantità di combustibile consumato per ogni unità di una grandezza di riferimento (il gradogiorno, il grado kelvin etc.).
Il confronto tra i "consumi specifici" caratteristici dell'impianto, con e senza sistema economizzante, consente di stabilire l'efficacia del sistema stesso.
L'adozione di minicomputers per il controllo delle partenze del bruciatore e l'uso di unità arbitrarie esteso alla contabilizzazione energetica possono concorrere alla realizzazione di sistemi ottimali sia per il risparmio energetico che per la ripartizione dei costi.
Abstract:
It is possible to find on the market many energy saving devices, increasing the efficiency and the features of the boilers in heating plants.
The measurement results reliability of any appliance are not easy to get and, sometime, not true.
Often, e.g. when the people uses the degree-day as reference, it takes many time to obtain reliable information on saving effect.
Here new procedures are suggested.
Any way all the procedures have the same purpose: to define a typical "specific fuel consumption" of plant with or without the energy saving device.
The comparison between the specific consumption before and after the appliance allows the definition of relative energy saving.
Moreover the maximum result is reached when many systems are applied together: the new burner start programmer (Brennerstartcomputer) with the local energy meters, for energy saving and also for dividing heating costs, is excellent.