L'ordine monastico - militare dei cava1ieri templari fu fondato in Terrasanta al tempo delle Crociate. Secondo una tradizione, accettata dalla maggioranza degli storici e riportata attraverso i secoli, l'Ordine fu costituito nel 1119 d
 a Hugues de Payns o Payens, cavaliere
della Champagne, assieme ad altri otto nobili francesi. I loro
scopi erano quelli di difendere le strade d'accesso ai luoghi
santi dai banditi e dalle incursioni saracene, di accompagnare
i pellegrini che ripetevano il rito del battesimo di Cristo, immergendosi
nelle acque del Giordano, e di presidiare i pozzi e le sorgenti.
Una cronaca dell'epoca, scritto da Michele il Siriano e riferito
del recente testo di Edward Hurman ("I Templari - L'Ordine
dei Poveri Cavalieri del Tempio di Salomone", ed. Corvino,
1988), ci presenta la fondazione dell'Ordine in maniera del tutto
diversa. Dalla sua lettera si apprende che Hugues de Payns non
era un semplice cavaliere, ma un gran signore feudale che si recò
in Terrasanta con trenta vassalli per mettere la sua spada al
servizio del regno di Gerusalemme, facendo voto di non ritornare
più nelle sue terre. Sembra che il fatto sia avvenuto nel
1116.
a Hugues de Payns o Payens, cavaliere
della Champagne, assieme ad altri otto nobili francesi. I loro
scopi erano quelli di difendere le strade d'accesso ai luoghi
santi dai banditi e dalle incursioni saracene, di accompagnare
i pellegrini che ripetevano il rito del battesimo di Cristo, immergendosi
nelle acque del Giordano, e di presidiare i pozzi e le sorgenti.
Una cronaca dell'epoca, scritto da Michele il Siriano e riferito
del recente testo di Edward Hurman ("I Templari - L'Ordine
dei Poveri Cavalieri del Tempio di Salomone", ed. Corvino,
1988), ci presenta la fondazione dell'Ordine in maniera del tutto
diversa. Dalla sua lettera si apprende che Hugues de Payns non
era un semplice cavaliere, ma un gran signore feudale che si recò
in Terrasanta con trenta vassalli per mettere la sua spada al
servizio del regno di Gerusalemme, facendo voto di non ritornare
più nelle sue terre. Sembra che il fatto sia avvenuto nel
1116.Forse agli inizi gli scopi di questo sodalizio non erano ancora ben definiti; solo dopo i primi anni della loro permanenza in Oriente, consci della situazione di estremo pericolo in cui versavano sia gli abitanti sia i pellegrini, essi decisero di fondare un gruppo di monaci-soldati che sostituisse la spada all'inerme bastone del pellegrino. Baldovino II, re di Gerusalemme, donò a Hugues ed ai suoi compagni, come sede, la Moschea Al-Aqsa, che sorgeva sulle rovine del tempio di Salomone nei pressi del palazzo reale.Do qui il nome di Cavalieri del Tempio o Templari. I nove gentiluomini francesi, o i trenta, secondo le due versioni prospettate, si
 presentarono dinanzi a Germondo,
patriarca di Gerusalemme, e pronunciarono i consueti voti monastici
di povertà, castità ed obbedienza, aggiungendone
un quarto: quello di combattere le crociate contro gli infedeli
e difendere le strade e i pellegrini. All'inizio seguirono la
regola di Sant'Agostino, come i canonici di S. Sepolcro. In questo
primo periodo vivevano di elemosine, vestivano abiti secolari
e per la loro semplicità di vita erano chiamati "Poveri
Cavalieri di Cristo". Nel 1128, essendo la Terrasanta carente
di difensori, il re di Gerusalemme, Baldovino II, inviò
Hugues de Payns con alcuni cavalieri in Occidente per portare
messaggi al Papa ed ai monarchi europei. In tali messaggi veniva
sollecitato l'invio di contingenti militari per arginare I'avanzata
delle truppe musulmane, nonchè l'approvazione ufficiale
del nuovo ordine già benemerito in Terrasanta. Nel Concilio
di Troyes del medesimo anno, tenutosi sotto l'alto patrocinio
del conte di Champagne, uno dei più grandi signori della
Francia di allora, e sembra, parente dello stesso Hugues de Payns,
presentarono dinanzi a Germondo,
patriarca di Gerusalemme, e pronunciarono i consueti voti monastici
di povertà, castità ed obbedienza, aggiungendone
un quarto: quello di combattere le crociate contro gli infedeli
e difendere le strade e i pellegrini. All'inizio seguirono la
regola di Sant'Agostino, come i canonici di S. Sepolcro. In questo
primo periodo vivevano di elemosine, vestivano abiti secolari
e per la loro semplicità di vita erano chiamati "Poveri
Cavalieri di Cristo". Nel 1128, essendo la Terrasanta carente
di difensori, il re di Gerusalemme, Baldovino II, inviò
Hugues de Payns con alcuni cavalieri in Occidente per portare
messaggi al Papa ed ai monarchi europei. In tali messaggi veniva
sollecitato l'invio di contingenti militari per arginare I'avanzata
delle truppe musulmane, nonchè l'approvazione ufficiale
del nuovo ordine già benemerito in Terrasanta. Nel Concilio
di Troyes del medesimo anno, tenutosi sotto l'alto patrocinio
del conte di Champagne, uno dei più grandi signori della
Francia di allora, e sembra, parente dello stesso Hugues de Payns,
L'Ordine fu ufficialmente riconosciuto da Matteo d'Albano, cardinale legato del Papa Onorio II, alla presenza di diversi signori feudali, dignitari ecclesiastici e degli abati cistercensi, tra i quali San Bernardo di Chiaravalle. I Cavalieri presentarono la loro primitiva regola, lasciando facoltà al Papa e all'autorità della Chiesa di accettare quanto in essa vi era di buono e di giusto, e di respingere quanto non era concorde alla loro duplice attività religiosa e guerriera. Dopo il Concilio, il de Payns viaggiò per l'Europa, facendo proseliti e ricevendo numerose donazioni sia da laici che da prelati. In questa occasione lasciò in Francia uno dei suoi primi compagni, Payen de Montdidier, detto Nivard, nominandolo Maestro di Francia,
quindi, con le: forze raccolte, ritornò in Terrasanta.
L'Ordine era alle dirette dipendenze dei pontefici, che lo colmarono di privilegi, fra cui
 l'esenzione dal
pagamento delle decime, la facoltà di costruire cappelle
a loro uso esclusivo, di seppellire nei propri cimiteri i morti
scomunicati e non, e di riscuotere la quarta parte delle tasse
mortuarie. Le donazioni fatte all'Ordine non consistevano solo
in elargizioni in terre o in denaro, ma anche in alcuni diritti
feudali, quali i diritti di fienagione, di pascolo, di taglio
dei boschi, di pedaggio, di traghetto, di pesca, di caccia, di
uso dei mulini, eccetera. In Oriente, i Templari rappresentarono
la crociata permanente. Combatterono la loro guerra
l'esenzione dal
pagamento delle decime, la facoltà di costruire cappelle
a loro uso esclusivo, di seppellire nei propri cimiteri i morti
scomunicati e non, e di riscuotere la quarta parte delle tasse
mortuarie. Le donazioni fatte all'Ordine non consistevano solo
in elargizioni in terre o in denaro, ma anche in alcuni diritti
feudali, quali i diritti di fienagione, di pascolo, di taglio
dei boschi, di pedaggio, di traghetto, di pesca, di caccia, di
uso dei mulini, eccetera. In Oriente, i Templari rappresentarono
la crociata permanente. Combatterono la loro guerra  santa
coprendosi di gloria e pagando ad ogni crociata un pesante tributo
di sangue: dall'assedio di Ascalona alla battaglia di Hattin,
dalla cruenta campagna di Damietta alla caduta di Gerusalemme,
dalla battaglia di Mansurah all'olocausto di Acri.
santa
coprendosi di gloria e pagando ad ogni crociata un pesante tributo
di sangue: dall'assedio di Ascalona alla battaglia di Hattin,
dalla cruenta campagna di Damietta alla caduta di Gerusalemme,
dalla battaglia di Mansurah all'olocausto di Acri.Per la migliore difesa del Regno di Gerusalemme costruirono grandi fortezze dislocate in punti strategici. Le più famose furono Baghras, nell'Amano, che controllava il passaggio obbligato dalla Siria, Saphet, che dominava il Giordano e arginava le avanzatedegli emiri damasceni, e l'imprendibile e mai conquistato Castel Pellegrino o Athlit, costruito su un promontorio dominante la zona costiera tra Acri e Haifa.
Nell'ultimo baluardo cristiano, San Giovanni d'Acri, i cavalieri possedevano un intero
 quartiere presidiato
da una fortezza sul mare. In Occidente, dove si diffusero rapidamente,
i Templari compirono un'opera altamente civilizzatrice. Furono
"pontifices" cioè costruttori di ponti, di quei
rari ponti in pietra di cui si possono ancora vedere gli avanzi.
Edificarono chiese, ospizi, strade e villaggi; bonificarono terreni
paludosi ed incolti, seguendo i sistemi cistercensi; svilupparono
il commercio, contribuirono all'emancipazione delle città
e delle Campagne, e in alcuni territori affrancarono i servi della
gleba, che divennero liberi lavoratori alle dipendenze del Tempio.
quartiere presidiato
da una fortezza sul mare. In Occidente, dove si diffusero rapidamente,
i Templari compirono un'opera altamente civilizzatrice. Furono
"pontifices" cioè costruttori di ponti, di quei
rari ponti in pietra di cui si possono ancora vedere gli avanzi.
Edificarono chiese, ospizi, strade e villaggi; bonificarono terreni
paludosi ed incolti, seguendo i sistemi cistercensi; svilupparono
il commercio, contribuirono all'emancipazione delle città
e delle Campagne, e in alcuni territori affrancarono i servi della
gleba, che divennero liberi lavoratori alle dipendenze del Tempio.Una fitta rete di case forti templari ricopriva tutta l'Europa , dalla Svezia all'Inghilterra, dalla Francia all'Italia , dalla Germania all'Ungheria e alla Russia.
In Spagna e in Portogallo gli insediamenti del tempio erano delle vere e proprie fortezze, impegnate nella lotta contro i mori .
In Francia erano dette " Commanderies", in Italia "Precettorie" e "Mansioni", a seconda della loro importanza.
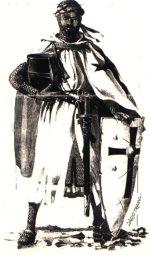 Erano dei complessi autosufficienti,
difesi da alte mura, comprendenti il convento con torri di vedetta
ai lati, la cappella (le precettorie cittadine, oltre alla cappella
dei cavalieri, avevano anche chiese aperte al pubblico), la scuderia,
la selleria, l'armeria, la fucina, il mulino, la cantina, i magazzini
per la conservazione delle derrate alimentari, l'infermeria, la
foresteria, il cimitero e il "vivarium", o pescheria,
dove si allevavano i pesci, di cui i Templari facevano largo uso
in quanto la loro astinenza dalle carni durava da Ognissanti a
Natale e per tutta la Quaresima. Gli insediamenti templari sorge-
vano dappertutto: alla confluenza dei fiumi, lungo le antiche
vie consolari romane, sui monti, nelle campagne, nei villaggi
e nelle città. Nei centri più importanti ve n'erano
due, a volte tre. Dalle città portuali salpavano le navi
templari per L'oriente, cariche di crociati, di pellegrini e di
cibarie per uomini ed animali. Dopo la perdita della Terrasanta
con la caduta di San Giovanni d'Acri, nel 1291, i Templari posero
il 1oro quartier generale a Cipro, prodigandosi per la riconquista
del regno di Gerusalemme. Il centro finanziario - politico ed
economico dell'Ordine era, però, Parigi, dove i cavalieri
possedevano una parte della città, "le Temple",
con un complesso di edifici vastissimo e fortificato che durante
le sommosse popolari ospitò perfino il re di Francia. La
cessata attività militare 1n Oriente pur continuando la
lotta in Spagna e in Portogallo indirizzò i Templari verso
il campo amministrativo-finanziario. Banchieri e tesorieri di
re, di papi, di principi e di signori feudali, furono gli inventori
della lettera di credito, grazie alla quale il denaro poteva circolare
ovunque con sicurezza. Le redditizie operazioni bancarie, le proprietà
terriere grandi come feudi, le immense ricchezze e i privilegi
acquisiti nei due secoli di vita dell'Ordine suscitarono l'invidia
di ecclesiastici e di laici. Tra essi il più accanito era
il re di Francia, che doveva ingenti somme al Tempio di Parigi,
dove era custodito anche i1 tesoro reale. Per abbattere la Potenza
politica - economica del tempio, che era diventato uno stato grande
dentro il suo stato grande, Filippo il Bello lo accusò
di eresia, sfruttando e deformando alcune dicerie messe in giro
da tempo dai detrattori dei Templari. Li si accusava di rinnegare
Gesù Cristo, la madonna e i Santi, di sputare sulla croce,
di non consacrare l'ostia durante la messa, di praticare la sodomia,
di idolatrare una divinità chiamata "Baphomet".
Inoltre, si imputava ai cavalieri il fallimento delle crociate
, dovuto alle loro "pseudo" intese con i musulmani.
Quest'ultimo punto è assolutamente privo di fondamento
in quanto buona parte delle tregue ed alleanze trattate con gli
infedeli fu firmata da re e da principi Cristiani e non dai templari.
Erano dei complessi autosufficienti,
difesi da alte mura, comprendenti il convento con torri di vedetta
ai lati, la cappella (le precettorie cittadine, oltre alla cappella
dei cavalieri, avevano anche chiese aperte al pubblico), la scuderia,
la selleria, l'armeria, la fucina, il mulino, la cantina, i magazzini
per la conservazione delle derrate alimentari, l'infermeria, la
foresteria, il cimitero e il "vivarium", o pescheria,
dove si allevavano i pesci, di cui i Templari facevano largo uso
in quanto la loro astinenza dalle carni durava da Ognissanti a
Natale e per tutta la Quaresima. Gli insediamenti templari sorge-
vano dappertutto: alla confluenza dei fiumi, lungo le antiche
vie consolari romane, sui monti, nelle campagne, nei villaggi
e nelle città. Nei centri più importanti ve n'erano
due, a volte tre. Dalle città portuali salpavano le navi
templari per L'oriente, cariche di crociati, di pellegrini e di
cibarie per uomini ed animali. Dopo la perdita della Terrasanta
con la caduta di San Giovanni d'Acri, nel 1291, i Templari posero
il 1oro quartier generale a Cipro, prodigandosi per la riconquista
del regno di Gerusalemme. Il centro finanziario - politico ed
economico dell'Ordine era, però, Parigi, dove i cavalieri
possedevano una parte della città, "le Temple",
con un complesso di edifici vastissimo e fortificato che durante
le sommosse popolari ospitò perfino il re di Francia. La
cessata attività militare 1n Oriente pur continuando la
lotta in Spagna e in Portogallo indirizzò i Templari verso
il campo amministrativo-finanziario. Banchieri e tesorieri di
re, di papi, di principi e di signori feudali, furono gli inventori
della lettera di credito, grazie alla quale il denaro poteva circolare
ovunque con sicurezza. Le redditizie operazioni bancarie, le proprietà
terriere grandi come feudi, le immense ricchezze e i privilegi
acquisiti nei due secoli di vita dell'Ordine suscitarono l'invidia
di ecclesiastici e di laici. Tra essi il più accanito era
il re di Francia, che doveva ingenti somme al Tempio di Parigi,
dove era custodito anche i1 tesoro reale. Per abbattere la Potenza
politica - economica del tempio, che era diventato uno stato grande
dentro il suo stato grande, Filippo il Bello lo accusò
di eresia, sfruttando e deformando alcune dicerie messe in giro
da tempo dai detrattori dei Templari. Li si accusava di rinnegare
Gesù Cristo, la madonna e i Santi, di sputare sulla croce,
di non consacrare l'ostia durante la messa, di praticare la sodomia,
di idolatrare una divinità chiamata "Baphomet".
Inoltre, si imputava ai cavalieri il fallimento delle crociate
, dovuto alle loro "pseudo" intese con i musulmani.
Quest'ultimo punto è assolutamente privo di fondamento
in quanto buona parte delle tregue ed alleanze trattate con gli
infedeli fu firmata da re e da principi Cristiani e non dai templari.Nel medioevo l'accusa di eresia era la più grave e veniva spesso usata per distruggere grandi avversari e personaggi politici. Inoltre, per la legge canonica dell'inquisizione agli eretici non si pagavano i debiti: questa clausola risolveva i problemi finanziari di Filippo il Bello. Il 13 ottobre 1307 i cavalieri francesi furono arrestati simultaneamente in tutto il territorio nazionale e rinchiusi nelle carceri reali dove furono ripetutamente torturati e interrogati confessando tutto ciò che i carnefici imponevano loro di dire. Coloro che in seguito ritrattarono le confessioni - irelapsi - furono condannati al rogo. Inoltre, molti cavalieri stremati dalle torture dalla fame e dalle abbiette condizioni delle prigioni, perirono in esse. Due anni dopo l'arresto, circa seicento templari si presentarono di fronte alle commissioni inquisitoriali papali, dichiarando di voler difendere I'Ordine, negando tutto ciò che avevano confessato sotto le torture. Nonostante queste numerose dichiarazioni, l"affaire" si trascinò per altri due anni, senza portare alcun vantaggio all'Ordine ed ai suoi membri, che compresero come il processo fosse una farsa e la loro sorte stata decisa in precedenza. Il Papa Clemente V, succubo del re francese, cui doveva la sua elezione, tergiversò ancora qualche anno tra ripensamenti vari. Per porre fine alla questione, convocò un concilio a Vienne, nel Delfinato. I cardinali e gli alti dignitari ecclesiastici ivi presenti erano concordi, tranne i prelati francesi, ad assolvere l'Ordine da ogni accusa. Filippo il Bello, avutone sentore dai suoi informatori, si presentò a Vienne con un forte contingente di armati e con intenti minacciosi. Il Papa, intimorito, decise allora di sciogliere la Milizia del Tempio con la bolla "Vox clamantis in excelso" senza peraltro condannarlo, per mancanza di prove "certe e documentarie". Era il 3 aprile 1312. L'u1timo atto del dramma templare si concluse il 18 marzo 1314 con gli ultimi bagliori del rogo su cui arse Jacques de Molay, ultimo Gran Maestro dell'Ordine, il quale, nonostante sapesse la fine che l'aspettava, ritrattò tutte le confessioni e proclamò ad alta voce l'innocenza dei cavalieri del Tempio.