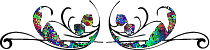A Raffaela Mulato, Treviso;
Venezia, 17 aprile 1999.
Cara Raffaela,
Ripensando al tuo "portico", e alle mie "risonanze", mi viene in mente il teatro tradizionale tibetano: essi si riuniscono ovunque ci sia uno spazio grande abbastanza, come una piazza o un prato; montano un altare al centro, e vi dispongono le immagini dei Maestri; il pubblico si riunisce - famiglie intere -, con cibi e bevande e bambini, per assistere a spettacoli che durano intere giornate; prima dell'inizio tutti, attori e pubblico, pregano insieme per circa un'ora, e poi iniziano le loro lunghe saghe, dove per vedere un mare o una montagna basta un gesto, per nascere o morire basta un grido.
Per lungo tempo io ho creduto che l'assenza di edifici destinati all'arte teatrale fosse la conseguenza del loro vivere in esilio (dalla Cina), finché ho scoperto che è la tradizione stessa a non volere luoghi deputati per il teatro: esso si deve svolgere nei luoghi della quotidianità. O meglio: l'edificio del loro teatro dev'essere solo quello che un pubblico riunito in preghiera può creare col suo desiderio di trovarsi riunito, e di ascoltare le voci dei loro antenati parlare in un tempo sospeso, dove il passato e il futuro sono solo figure che si indicano con un gesto, con una rapida sequenza di parole estranee ai dialoghi.
Questa è una Sinagoga: Bet ha-knesset, casa dell'assemblea. Questo è il luogo che noi abbiamo perduto, e il teatro che non sappiamo ricostruire...
L'arte non può vivere in mezzo alla mondanità e alla vanità: non ne resta che la materia grezza, gli oggetti, le cose pesanti e deperibili. E infatti si continua a cercare ossessivamente il "nuovo", pur di sentire ancora "qualcosa che vibra dentro"...
Meditiamo su questo...
Con grande riconoscenza , il tuo amico Claudio.