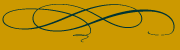Da “Il Vento Giallo”, edizione
italiana,
© 1988 Arnoldo Mondadori editore S.p.A.
Le
parti sottolineate verranno lette in lingua originale da David Grossmn,
e poi ripetute nella traduzione italiana da una voce recitante,
che leggerà l'intero testo qui riportato. Le parti in corsivo
sono frasi di collegamento scritte da Claudio Ronco. L'intersecarsi
dei brani musicali avviene nei punti in cui sono indicati i titoli
dei diversi brani.
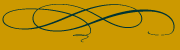
LETTURA INTEGRALE DELLA PREFAZIONE DELL'AUTORE ALL'EDIZIONE ITALIANA.
(Sottofondo musicale: "Elegia per Israele"
in versione elettronica)
“[...] il mio compito è porre il dito sulla piaga,
descrivere —in un linguaggio contro cui il lettore non ha ancora
fatto a tempo a corazzarsi— tutte le sfumature di una situazione
esistente, infrangere facili stereotipi, far presente a chi lo avesse
dimenticato che non è ancora scaduta l’importanza della
morale umana.”
LETTURA DI UN BREVE "POST SCRIPTUM" DELL'AUTORE,
A 14 ANNI DALLA PRIMA EDIZIONE DEL "VENTO GIALLO".
KLEZMER IMPROVISATION,
per due violoncelli e clarinetto.
pag. 231
Nel casamento in cui abito lavora, alla pulizia delle scale, un’araba.
Si chiama Amunah, è di Ramallah. Ogni tanto converso con lei.
Un bambino di tre anni, figlio di vicini, abituato a vederla sempre
curva sul secchio dell’acqua, ci ha visti conversare ed è
rimasto stupito; me ne sono accorto dalla sua espressione. Mi ha chiesto
come quella lì si chiamava, e io gliel’ho detto. Poi mi
ha chiesto perché parlavamo in arabo, e io gliel’ho spiegato.
Allora lui ha riflettuto un po’, e mi detto così: “Amunah
è un po’ essere umano e un po’ cane, vero?”.
Gli ho chiesto perché diceva così, e lui: “è
un po’ cane perché sta sempre a quattro zampe. È
un po’ essere umano perché sa anche parlare”.
È l’anno 1987, quando David vive questi fatti e scrive
queste parole:
pag. 233
Già
da vent’anni viviamo in una situazione falsa e artificiale, basata
su illusioni e sull’incerto equilibrio tra l’odio e il terrore,
in un deserto di sentimenti e di coscienza, e il tempo che passa diviene
pian piano un’essenza a sé, pesante e sospesa su di noi
come un giallo e soffocante strato di polvere. Da questo punto di
vista la situazione odierna —del nostro dominio sui Territori—
rappresenta una grande sfida personale a ognuno di noi. Un bivio umano
che pretende da noi azioni e impegno. In tal modo si può godere,
a volte, per un attimo, una boccata di vera, fresca aria montana.
Albert Camus ha detto che questo passaggio obbligato dalla parola
all’azione morale ha un nome. Si chiama: “divenire un essere
umano”. Nel corso di queste ultime settimane, e vedendo quello
che ho visto, mi sono chiesto quante volte durante gli ultimi vent’anni
sono stato degno di chiamarmi “essere umano”, e quanti fra
i milioni di partecipanti a questo dramma ne sono stati e ne sono
degni.
RECITATIVO,
per violoncello solo.
pag. 232
[...] Ho un brutto presentimento: temo che la situazione odierna continuerà
a essere così com’è ancora per dieci o venti anni.
A conferma di questo esiste una buonissima garanzia: la stupidità
umana e il rifiuto di vedere come il disastro si approssima. Però
sono convinto che arriverà il momento in cui dovremo pure far
qualcosa, e può darsi che allora ci troveremo in posizioni
peggiori di quelle in cui siamo ora.
E non è questione del dover giudicare e decidere che ha ragione
e chi ha torto, se noi o loro, se la sinistra o la destra; è
una questione di dati di fatto e di cifre, e di qualche altra cosa
che esula dai dati e dalle cifre, di qualche cosa che si trova nella
vaga e confusa zona che sta fra i cani e gi esseri umani. E chi non
è pronto ad accettare simili speculazioni riguardo al futuro,
che guardi, per favore, indietro: l’esperienza storica mondiale
ha dimostrato che una situazione come quella che noi cerchiamo di
immortalare qui non può durare a lungo. E se dura, richiede
un prezzo disastroso.
AGNUS DEI
pag.
83
«Gli ebrei ci hanno buttato fuori di qui e gli ebrei ci hanno
fatto ritornare» dice, sospirando, una vecchia, cieca da un
occhio, che ci sta a sentire da sopra un tetto di una casa vicina,
tra liste di lana di pecora da poco tosata stesa per arieggiarla.
Come una parafrasi della preghiera che gli ebrei pronunziano sulla
salma di un congiunto. “Iddio ha dato e Iddio ha ripreso”
dice la preghiera; e qui: “l’ebreo ha dato e l’ebreo
ha ripreso”, così le parole si traducono al mio orecchio.
RECITATIVO,
per due violoncelli soli.
Radja Shahadah, avvocato e scrittore, nella Conferenza di Baghdad
del 1978 creò un neologismo: ZUMUD, che significa “tener
duro”, tenere tenacemente una posizione.
pag. 161
La Conferenza creò il “Fondo per l’Appoggio alla
Resistenza Tenace”, che doveva inviare centocinquanta milioni
di dollari all’anno ai palestinesi —e anche agli arabi inclusi
nello Stato d’Israele dal 1948— ma in realtà quel
fondo quasi si esaurì già nei primi anni perché
gli Stati Arabi non mantennero la promessa di finanziarlo.
David dialogò con lui in inglese:
pag. 163
Dico a Shahadah che anche tra gli israeliani ci sono degli zamadin
di questo tipo: —degli ostinati che con una certa violenza
passiva, nel mordersi le labbra e attendere, ostinatamente, vivacchiando
in qualche modo finché non passa la bufera— gente
che non accetta la situazione così com’è ma non
sa cosa fare per mutarla, e “si attaccano” (in ebraico "zamud"
significa “attaccato con forza, afferrato”) alla loro volontà
di non sapere e non sentire, si attaccano a una semiottusità,
si immergono in una disperata e disgraziata sonnolenza morale, “svegliatemi
quando tutto sarà finito”...
pag.164
“Vi succede, a voi israeliani, quello che il professor Leibovitch
profetizzò subito dopo la guerra del ‘67. Disse, allora,
che non è possibile imporre un regime di dominio senza divenire
immorali. Perfino coloro le cui intenzioni erano del tutto morali
sono pian piano precipitati in una situazione immorale. E la situazione
diviene un mostro che vive per conto suo e non si può combattere.
Un mostro di ingiustizia e di immoralità.
[…] E poi voi vi chiedete ancora: perché gli arabi
sono così selvaggi, così violenti? Beh, come potete
trattare la gente per tanti anni in un certo modo e aspettarvi poi
che quella gente non reagisca?”
Io dico: “ A volte in Israele ci si chiede proprio l’opposto:
perché è così facile dominarvi? Come spieghi
il fatto che noi dominiamo più di un milione e mezzo di arabi,
quasi senza che nemmeno ce ne accorgiamo? Se si desse la situazione
opposta, noi non vi lasceremmo in pace nemmeno un minuto”.
RECITATIVO,
per violoncello solo.
pag. 92
Il vecchio, Abu Kharb, sospira a lungo, si passa una mano sulla faccia,
se la preme sugli occhi. I bambini lo guardano. No, il ritorno a casa
non ha cambiato quello che questa gente provava per noi israeliani,
non l’ha portata a amarci. E forse era da stupidi sperarlo. Abu
Kharb si alza a fatica, mi accompagna fuori. Stiamo lì fuori
a guardare insieme la valle così bela e il fumo che sale su
dai Tabun, dai forni fatti di terra battuta impastata con fili di
paglia, e si spande salendo su verso il cielo. I cespugli di spini
fioriti e e margherite selvatiche inondano tutto l’orizzonte.
Ho detto ad Abu Kharb che avevo deciso di chiamare questo libro “Il
tempo giallo”, e lui ha sorriso e mi ha chiesto se avevo mai
sentito parlare del vento giallo. Ho risposto di no. E allora lui
mi ha raccontato di questo vento, del vento giallo che spirerà
tra poco, e forse anche lui, Abu Kharb, farà a tempo a sentirlo
sulla pelle: dalla porta dell’inferno verrà questo vento
(perché dalla porta del Paradiso spira solo un vento fresco),
e sarà quel vento che gli arabi del posto chiamano Riah Azpar,
vento giallo, ed è un vento che viene dall’Est, dal deserto,
un vento tremendamente caldo, un vento che a volte, con lo scadere
di un certo numero di generazioni, di un certo numero di secoli, viene
e incendia tutta la nostra terra, e allora tutti scappano a rifugiarsi
nelle grotte e nelle caverne, ma, anche lì dentro, il vento
raggiunge quelli che vuole raggiungere e cioè i malvagi e crudeli
operatori del male, e lì, negli anfratti delle rocce, li uccide
tutti a uno a uno. E poi, quando questo vento sarà passato,
tutta la terra sarà coperta di cadaveri. E le rocce saranno
infuocate e si fonderanno, e i monti si disfaranno in polvere e la
polvere ricoprirà la terra come una coltre gialla.
ELEGIA PER ISRAELE
pag. 62
Ho timore di dover viver accanto a gente che si sente impegnata a
eseguire un ordine imperativo, totale. Ordini totali obbligano a compiere,
alla fin dei conti, azioni totali, e io, nebech, povero me,
sono un essere incompleto e difettoso che preferisce fare errori riparabili
invece di ottenere successi soprannaturali”
pag. 55
[…] chi cerca la giustizia assoluta rifugge anche lui da decisioni
e da azioni, […] io non cerco una giustizia assoluta, né
una resa-dei-conti storica, ma una possibilità di vita, cerco
una vita possibile anche se solo imperfetta e appena appena sopportabile,
facendo agli altri il meno male possibile.
KLEZMER IMPROVISATION,
per due violoncelli e clarinetto.
pag. 43
Dai sogni dei bambini del campo profughi di Kalandia emerge una realtà
dura e minacciosa, riflesso di un mondo fragile e del tutto indifeso.
La “trama” caratteristica di un sogno di questo tipo si
svolge entro i confini del campo: i limiti del sogno sono molto permeabili,
niente gli conferisce difesa e sicurezza, gente estranea invade la
casa e tormenta il bambino. Spesso lo torturano a morte. I suoi genitori
non sono capaci di difenderlo. Uno dei sogni ha attirato in special
modo la mia attenzione: “l’esercito sionista circonda la
nostra casa e vi irrompe. Mio fratello maggiore viene portato in prigione,
dove lo torturano. I soldati continuano a perquisire la casa. Buttano
all’aria tutto, ma non trovano quello che cercano (il bambino
stesso che sogna). Lasciano la casa, ma poi tornano guidati da un
vicino di casa traditore. Questa volta mi trovano, me e i miei parenti,
tutti nascosti dalla paura, in un armadio”.
L’Olocausto compare in molti sogni dei ragazzi di Kiriat Arba.
Una bambina undicenne scrive: “La mia amica e io abbiamo deciso
di andare a Gerico. Tutt’a un tratto abbiamo sentito dietro a
noi qualcuno che ci chiamava. Erano i miei genitori. Mi hanno detto
che dovevo togliermi il segno giallo che portavo addosso. Era una
toppa fatta di un grosso pezzo di carta gialla, significante che stavamo
per i partigiani. Quella città, Gerico, era contro i partigiani.
Tutt’a un tratto è arrivato qualcuno e ci ha portato in
un bosco e ci ha ordinato di strisciare per terra insieme a tanta
altra gente. Strisciando così siamo giunti a una galleria,
ma solo a mio padre fu permesso di entrare, io e mia madre dovemmo
continuare fino al posto destinato alle donne. Tutt’a un tratto
ho visto qualcosa muoversi: era una vecchia che spuntava su da una
tomba. Aveva la faccia coperta di terra”.
Il senso di colpevolezza appare solo nei sogni dei bambini ebrei.
Così, per esempio, nel sogno di una bambina dodicenne di Kiriat
Arba: “... All’improvviso qualcuno mi afferra, e vedo che
questo succede a casa mia, ma i miei se n’erano andati, e i bambini
arabi vanno su e giù nelle nostre stanze, e il loro padre mi
tiene ferma, e porta la kefiyah e ha una faccia feroce, e io non m
meraviglio affatto che sia così, che quegli arabi abitino ora
in casa mia. Lo accetto come se così dovesse essere”.
Lo studio degli psicologi è vasto e particolareggiato, ma mi
sembra che questi pochi esempi possano bastare. I sogni non concedono
un rifugio, non apportano alleviamento. Non c’è in essi
un attimo di pietà, un tocco di amicizia. In parte sono incubi
la cui descrizione è perfino duro leggere, e più duro
ancora è il pensare qual è il prezzo che i nostri bambini
e i bambini degli arabi devono pagare vivendo nella “situazione
vigente”, dalla quale non c’è scampo neppure nei
sogni.
Lo scrittore J.M. Coetzee, anch’egli vivente in un paese senza
pietà e preso in un intrico quasi disperato, citò, durante
la cerimonia in cui gli fu conferito il Premio Gerusalemme, una frase
di Nietzsche: “Abbiamo l’arte, per salvarci dal morire per
colpa della realtà”. “ In Sudafrica,” disse
Coetzee, “abbiamo oggi tanta realtà che l’arte non
la può più contenere. Una realtà opprimente,
che schiaccia ogni azione della fantasia.”
E anche i sogni —come la fantasia— sono schiacciati dal
peso della realtà.
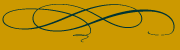
QUATTRO SCENE DAL MERCANTE DI VENEZIA
1) “JESSICA’S LOVE SONG”
pag. 38
“Non racconto mai ai bambini cose brutte su Israele” dice
la ragazza grassottella, sistemandosi il maglione. “Ma racconto
loro storie. Storie di animali”, dice ammiccando.
Cioè: apologhi esemplari.
“Per esempio... per esempio, che c’era una volta un albero
e sull’albero c’erano tanti passerottini, e ci giocavano tutti
allegri, e tutt’a un tratto venne un corvo nero e crudele e volle
prendersi quell’albero per sé e scacciò via gli uccellini.
E quelli erano tanto tristi, stavano per morire dal dolore, però
poi si riunirono tutti insieme, e tutti insieme volarono sul corvo,
in uno stormo grande e unito, e così riuscirono a scacciarlo
dal loro albero.”
“L’hai inventata tu, questa storia?”
“Sì. Ho inventato anche altre storie così. E i bambini
le capiscono di già.”
“E gli uccellini, sono davvero riusciti a unirsi insieme?”
“Sì. Sono intelligenti. Sono uccelli. Non sono Palestinesi.”
Verso sera ritorno a Gerusalemme. Ai lati della strada vedo vecchie
macchine arrugginite, rottami, lamiere, copertoni conficcati su recinti
di filo spinato, vecchi scaldabagni, porte scardinate, muri insudiciati
da scritte mezzo cancellate, vecchie scarpe rotte. Tutto buttato ed
esposto senza pudore ai lati della strada, tutto custodito qui, ammucchiato,
in modo da destare in cuore un senso di indefinita oppressione: tutto
questo abbandono è come un urlo di protesta per una situazione
fatta di rovina e di corruzione, una situazione disperata.
[…] È una sera grigiastra, nebbiosa, e la gente è
occupata in affari così non militari, così lontani dall’odio
e dal pericolo, e io passo fra loro come un messaggero apportatore di
una cattiva notizia passa fra gente inconsapevole. Con questa nebbiolina,
alla luce gialla dei fanali stradali, si può per errore scorgere
dietro a ognuno dei passanti qualcosa come una lieve aureola, come
se un sosia si affacciasse lì, per un attimo; qualcuno tanto
assomigliante a quest’uomo o […] a questa giovane donna, la
cui sorella gemella, a lei sconosciuta, ma con la medesima andatura
e la medesima calma sensualità, ho incontrato stamattina a Deheisha;
e anche ogni bambino ha il suo sosia; e tutti lo sanno e non si accorgono
di nulla.
KLEZMER IMPROVISATION,
per due violoncelli e clarinetto.
pag. 34
Nadij ha due anni e mezzo; è molto piccolo; ha gli occhi neri
e i capelli crespi.
“Un mese fa hanno preso suo padre, e il bambino non sa dov’è,
non sa se tornerà mai.”
“Qualche tempo fa” dice l’altra maestrina, che è
grassottella, ha gli occhi azzurri ed è truccata con un garbo
delicato, e pare sempre sul punto di ridere o di arrossire, “qualche
tempo fa è stato qui, in visita all’asilo, il governatore
militare, e mi ha chiesto se insegnavo ai bambini cose cattive, negative,
su Israele e sugli ebrei.”
“Cosa gli hai risposto?”
“Gli ho detto che io no, ma che i suoi soldati sì.”
“E cioè?”
“Cioè? beh, ti spiego: quando un bambino passeggia e vede
un albero, sa che l’albero fa foglie e frutta, no? E quando vede
un soldato, sa benissimo cosa fa quel soldato. Chiaro?”
“Cosa fanno i soldati?” chiedo ora a una bambina di circa
quattro anni, che si chiama Ne’imah, che sia in arabo sia in ebraico
significa “gentile, dolce, piacevole”; ha gli occhi verdi
e ai lobi degli orecchi porta piccoli cerchietti d’oro.
“Perquisizioni e botte” risponde.
“Lo sai chi sono gli ebrei?”
“Sì, sono i soldati.”
“Ci sono anche altri ebrei?”
“No”
“Cosa fa tuo padre?”
“E’ malato.”
“E tua madre?”
“Lavora a El-Kuds, a Gerusalemme, dagli ebrei. Pulisce le loro
case.”
Così mi risponde la piccola Nuova Questione Palestinese.
[…] D’un tratto si alza in piedi un bambino molto piccolo,
mi punta contro un bastoncino di plastica, e fa l’atto di spararmi.
“Perché mi spari contro?”
Il bambino abbraccia la maestra, mi scruta da dietro le sue braccia,
e ride. Ha due anni.
“A chi vuoi sparare?” gli chiedono le maestre, sorridendo
come due mammine orgogliose della bravura del loro bambino.
“Agli ebrei.”
Le labbra delle due maestre declamano la risposta insieme a lui.
“E ora digli il perché”, incitano il piccino a continuare.
“Perché gli ebrei hanno preso mio zio” dice il piccino.
“Sono entrati di notte e l’hanno rubato dal letto, e allora
io dormo sempre con la mamma”.
“E allora, dovremo educare altre e sempre nuove generazioni all’odio?
all’inerzia giustificata dall’odio? Perché non cercate
un’altra strada?”
“Non c’è altra strada” mi rispondono le due
ragazze in coro; ognuna a modo suo, una mormorando e l’altra con
sicurezza, ma tutt’e due con le stesse identiche parole.
Sto a sentire e cerco di essere neutrale, di capire senza voler dare
giudizi, ma anche senza essere come un giornalista straniero, del tutto
estraneo a quest’intrico di faccende, che si affretta a dare il
suo giudizio. Perché sono qui anche in veste di riservista dell’Esercito
d’Israele; e sono qui anche in veste di essere umano che si rivolta
contro questo modo di educare i bambini a un odio cieco, e contro il
terribile spreco di energia indirizzata all’odio invece di essere
utilizzata a uno sforzo teso a liberare tutto un popolo da quest’abbandono,
da questa miseria in cui è immerso quest’asilo, con questi
bambini di tre e quattro anni che così bene sanno odiarmi.
2) ”CLOSE THE EARS OF MY HOUSE!”
pag. 30
Per ora sono bambini dell’asilo. Un gruppetto rumoroso e ridanciano.
Dopo un certo sforzo interno —forse necessario a ogni straniero
in generale e a ogni ebreo, e israeliano per di più, in particolare—
comincio a distinguere le facce, le voci, i sorrisi, i tratti caratteristici,
e pian piano anche i tratti di bellezza e di gentilezza, e non è
una cosa facile, è una cosa che mi richiede un certo sforzo,
perché anch’io mi sono esercitato a guardare gli arabi con
quello sguardo rovesciato, ottuso, che mi facilita (solo me, facilita?)
lo stare a confronto con la loro presenza testimoniante, accusante,
minacciante, e ora, in questo mese in cui viaggio fra di loro, devo
fare proprio il contrario, devo penetrare nei miei più ardenti
focolai di paura e di ritegno, devo guardare in faccia gli Arabi
Invisibili, e tenermi di fronte a questa realtà messa in oblio,
e vedere come —quasi in un processo di sviluppo di negative fotografiche—
la realtà emerga pian piano dalla soluzione nella camera oscura
delle mie paure e delle mie fughe.
3) ”SHYLOCK’S SORROWFUL NIGHT”
pag. 26
La vecchia segue, a quanto pare il mio sguardo che vaga sui nudi muri
di cemento, sulla stufetta a petrolio, sulle coperte di lana distese
a terra. All’improvviso si accende: “Ti sembriamo degli zingari,
noi, eh? dei miserabili, eh? E invece siamo civili!”.
Sua sorella, la malata, fa con la testa grandi cenni che sì,
che sì, e il suo mento affilato le perfora il petto: “sì,
sì, civili!”. Le due vecchie tacciono, affannate. La giovane,
quella la cui presenza è selvaggia, esotica, vorrebbe dire qualcosa,
ma tace. Si tappa letteralmente la bocca con le mani. Nel tessuto delle
buone maniere e della gentilezza calcolata, arabescata, della conversazione
e dell’ospitalità cordialmente offerta, si tendono all’improvviso
dei fili di ferro. Io sono confuso. La giovane cerca di metter pace.
Di cambiare discorso. Forse sua suocera vuol raccontare a questo israeliano
qui qualcosa, per esempio, sulla sua infanzia a ‘Eyn-’Azrab?
No. Forse vuol ricordare i giorni in cui lavorava la sua terra? No e
poi no. Sale sulla ferita. Forse, ya mama, forse hai voglia di
cantarci le canzoni che allora cantavano da voi i Fellahin, i vignaioli,
i pastori? No. La vecchia non fa altro che stringere ostinatamente
le labbra screpolate, la sua testa un po’ calva tentenna, però
ecco che, come per l’imposizione della dominante forza dell’assenza,
ecco che la sua gamba sinistra comincia a danzare un ritmo lontano,
e il suo corpo si muove piano, avanti e indietro, e quando coglie il
mio trepido sguardo, si batte una mano tremante sull’anca e il
suo naso si fa rosso di collera: “Civiltà! Cultura! Voi
non sapete nulla della nostra civiltà, della nostra cultura!
Non le potete capire! Non è una cultura da televisiòn!”.
D’un tratto si svuota del tutto della rabbia: la sua faccia
prende di nuovo l’espressione vinta, onnisapiente, dell’antica
missiva scritta sulle facce dei vecchi: “Il mondo è duro
a viverci, tanto duro…”. Tentenna la testa con un dolore amaro,
gli occhi le si otturano in fronte alla stanzetta angusta e buia: “Non
puoi capire. Non puoi capire nulla, tu. Forse sarà meglio che
tu vada a chiedere a tua nonna, che te lo dica”.
4) ”JESSICA’S MORNING”
pag. 20
«L’arma più potente che gli arabi dei “Territori
occupati” hanno contro di noi» ha detto una volta un uomo
molto saggio «è il fatto che loro non cambiano e non cambieranno.»
E davvero, quando uno cammina per le strade del campo profughi di Deheisha,
sente come se questa concezione fosse stata qui interiorizzata istintivamente,
come se si fosse infiltrata nel midollo delle ossa della gente di qui
e si fosse fatta energia, una sfida: noi non muteremo. Non cercheremo
di migliorare le nostre condizioni di vita. Resteremo di fronte a voi
come una maledizione fusa nel cemento.
pag.17
L’acqua, a Deheisha, la portano dal pozzo. Acqua corrente, qui,
c’è solo nei solchi formati dai sentieri: acqua piovana
e acqua di fogna; e io salto sopra i rigagnoli, poi smetto di saltarli,
perché c’è qualcosa di ridicolo —quasi di immorale—
in questo mio delicato stare attento a non macchiarmi di qualche goccia
di sporcizia.
FINE DELLA PERFORMANCE.
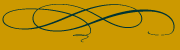
|