
Foto Maurizio Berlincioni
LINGUAGGIO FOTOGRAFICO
(Progresso Fotografico N°2/99 del Marzo 1999)
Foto Maurizio Berlincioni
Abbiamo visto che possiamo tranquillamente
considerare la fotografia, ed in particolare la fotografia di reportage, come una forma di
comunicazione.
Abbiamo anche detto che solo realizzando una serie di fotografia collegate tra loro
riusciremo a comunicare con precisione quello che vogliamo: occorre cioè costruire un
discorso fatto di immagini.
L’essenza della comunicazione tramite il fotogiornalismo sta nella realizzazione di
un lavoro compiuto composto da più fotografie.
Tant’è vero che abbiamo paragonato le singole belle foto alle singole belle parole:
le quali, da sole e senza essere inserite in una frase, non riescono a trasmettere
esattamente il nostro messaggio.
Molti sono in grado di realizzare singole bellissime immagini, pochi riescono a costruire
quello che per convenzione chiameremo d’ora in poi servizio fotografico. Ma è
proprio questo il passaggio fondamentale verso un uso della fotografia più consapevole,
consono alle proprie esigenze o addirittura professionale.
Vedremo insieme come arrivarci, esaminando insieme i passi necessari per farlo.
Cominciamo gettando le fondamenta che vi consentiranno di costruire il vostro servizio:
parliamo cioè del linguaggio fotografico.
Soffermatevi allora sull’esempio che segue.
Siete in vacanza e volete o dovete comunicare alla mamma, rimasta a casa trepidante, il
vostro stato di salute. Per prima cosa pensate a cosa volete/dovete dirle: fate cioè una
riflessione sincera sul vostro stato di salute e decidete se sia il caso o meno di
comunicarle la verità. Successivamente scegliete le parole da usare, decidete come
metterle insieme, componete mentalmente un discorso che abbia un senso logico in italiano,
aggiungendo magari qualcosa di superfluo ma simpatico.
Utilizzate poi il telefono per chiamarla e le dite il classico e rassicurante:
"Ciao mamma, sto bene e mangio!"
Questo è un semplice e magari banale esempio di comunicazione: in sostanza cosa avete
fatto? Dopo aver pensato al messaggio da inviare (cosa dire alla mamma) siete stati
costretti a compiere una serie di operazioni mentali tese a trovare un codice di
comunicazione comprensibile ed utilizzabile sia da lei che da voi (in questo caso la
lingua parlata italiana) e ad usare un canale per trasmettere il messaggio (il telefono).
Posto che senza uno qualsiasi di questi tre elementi (messaggio, codice e canale) non
potrebbe avere luogo la comunicazione, concentriamoci sul secondo (il codice) e cerchiamo
di uscire fuori dalla metafora per arrivare a parlare di una delle più diffuse forme di
comunicazione: il fotogiornalismo.
La conoscenza di un linguaggio è la condizione necessaria per ottenere una forma di
comunicazione: occorre cioè primariamente conoscere l’insieme di modi e mezzi a
nostra disposizione e secondariamente saper usare questi modi e questi mezzi per esprimere
quello che vogliamo comunicare.
Non è cioè sufficiente conoscere alcune nozioni, ma sono altrettanto necessarie delle
scelte per poterle impiegare al fine del raggiungimento di uno scopo comunicativo.
Per chiarire meglio il concetto ripensiamo al nostro esempio: se voi conoscete alcune
elementari nozioni di grammatica e di sintassi siete in grado di compiere delle scelte che
vi permettono di costruire il discorso "Ciao mamma, sto bene e mangio!".
La grammatica e la sintassi unite alle scelte compiute danno luogo, creano la lingua
parlata italiana. Senza questa unione di grammatica, sintassi e scelte (cioè senza
linguaggio) avreste emesso dei versi gutturali che probabilmente vi avrebbero resi
ridicoli e inquietanti, specialmente agli occhi di una madre trepidante.
In fotografia il procedimento può e deve essere lo stesso: alcune componenti accompagnate
ad alcune decisioni vi renderanno capaci di comunicare con le immagini.
L’unione di questi elementi, nozioni e scelte genera il linguaggio fotografico, è
linguaggio fotografico; che dunque possiamo definire come il codice di comunicazione della
fotografia.
E quali sono, nell’ambito del fotogiornalismo, questi elementi e queste nozioni che
sarebbe opportuno conoscere per poi poter effettuare delle scelte e dare luogo ad una
comunicazione per immagini?
Vediamole con due schemi che ci permettono anche di riassumere quanto detto finora e di
inserire questo discorso nell’ambito del fotogiornalismo.
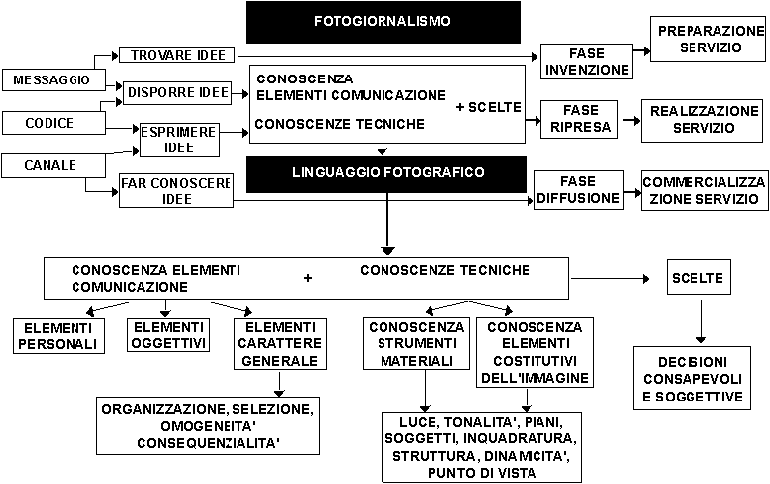
Come già detto e al contrario di quello che molti pensano, il fotogiornalismo è un
settore della fotografia in cui il momento dello scatto è solo un istante
all’interno di tre fasi operative: la fase dell’invenzione (in cui si trovano le
idee), la fase della ripresa (in cui si dispongono ed esprimono queste idee) e la fase
della diffusione (in cui si fanno conoscere e si vendono le idee espresse
fotograficamente). Riportando il discorso su un piano più concreto, possiamo anche
chiamarle: la fase di preparazione di un servizio fotografico, la fase della realizzazione
del servizio e la fase della commercializzazione del servizio.
Ma attenzione: non solo prima di arrivare a scattare, ma addirittura prima di arrivare ad
una qualsiasi delle tre fasi operative, per poter riuscire cioè a mettere in atto
l’intero processo comunicativo, è necessario conoscere il linguaggio fotografico.
Altrimenti non riusciremmo nemmeno ad immaginare un’utilizzo della fotografia a scopi
giornalistici, cioè ai fini della comunicazione.
Ripensate infatti al nostro esempio: senza la conoscenza della lingua italiana non saremmo
in grado di comunicare per telefono.
Non potremmo nemmeno immaginare di chiamare la mamma, sarebbe inutile.
Addirittura non potremmo pensare nei modi in cui siamo abituati a farlo.
Insomma la conoscenza di un linguaggio è fondamentale per pensare di poter instaurare un
sistema comunicativo.
E arriviamo dunque al linguaggio fotografico, che altro non è se non l’unione tra
conoscenza di elementi di comunicazione, conoscenze tecniche tipiche del mezzo fotografico
e scelte che ne derivano. Vediamole nel dettaglio.
Iniziamo considerando gli elementi che ci permettono di mettere in atto la comunicazione
tramite la fotografia.
Nella comunicazione coesistono elementi di carattere personale, elementi oggettivi ed
elementi di carattere generale.
Gli elementi della comunicazione di carattere personale sono semplicemente quelli che
riguardano la vostra personalità: e quindi la vostra educazione, le vostre esperienze, il
vostro carattere, la vostra formazione professionale, la vostra sensibilità, la vostra
cultura e di conseguenza il personale modo di esprimervi e comunicare le opinioni che
derivano da tutto ciò.
Sono caratteristiche che riguardano soltanto voi e non solo in qualità di fotografi ma
soprattutto in quanto esseri umani: riguardano la vostra persona, il vostro intimo e su di
essi quindi potete e dovete intervenire solo voi.
In generale gli elementi oggettivi della comunicazione sono quelli esterni
all’operatore ma da prendere in considerazione soprattutto tenendo presente il
messaggio da inviare.
In particolare, voi, in quanto operatori dell’immagine, dovrete tener conto del
momento storico-politico-culturale in cui state vivendo (e in cui come fotografi dovrete
inserirvi), dei mezzi economici e tecnici a vostra disposizione (in generale e nel vostro
caso particolare), dei generi fotografici a cui rivolgervi (lo still-life, il ritratto in
studio, il ritratto ambientato, la foto di moda, il paesaggio, la foto di architettura,
etc. etc.).
Sono caratteristiche che bisogna conoscere, specialmente tenendo presente il soggetto da
affrontare fotograficamente.
E anche questi sono elementi che riguardano solo voi e soprattutto dai quali non potrete
prescindere nel momento in cui dovrete fare delle scelte.
Gli elementi della comunicazione di carattere generale, infine, sono quelli su cui
intendiamo concentrare maggiormente la vostra attenzione.
Sono le caratteristiche essenziali della comunicazione, gli elementi che la rendono
possibile.
Cerchiamo di individuarli tornando al nostro esempio.
Tranquillizzare la mamma circa il vostro stato di salute in vacanza era lo scopo da
raggiungere e raggiunto mediante l’ormai celebre messaggio "Ciao mamma, sto bene
e mangio".
Non sarebbe stato sufficiente dire "Ciao mamma!" e basta. Quella povera donna
sarebbe morta d’infarto se non le avessimo dato altre informazioni!
Così come sarebbe stato divagante e terroristico dire: "Ciao mamma, mi sono tuffato
dagli scogli!" e basta. Avrebbe avuto un malore prima di riuscire a chiedervi se
siete ancora interi!
E non avrebbe avuto nemmeno senso dire: "Ciao mamma, faccio la dieta e mangio!",
così come altrettanto pazzesco sarebbe stato dire "Mamma sto ciao mangio e
bene". La poveretta sarebbe corsa sul posto a verificare il nostro stato di salute
mentale!
Per comunicare il nostro stato di salute alla mamma in modo tranquillizzante abbiamo
compiuto, prima di parlare, un processo mentale che ci ha permesso di mettere in ordine
pensieri e parole, di individuare i concetti principali da esporre, di trovare un nesso
logico tra loro e infine di metterli in sequenza. Dopo abbiamo trovato le parole e ci
siamo espressi verbalmente in italiano.
Il risultato, ottenuto grazie ad una preventiva disposizione dei concetti da esporre, è
una semplice frase che però ha comunicato efficacemente quello che doveva: un nostro
messaggio tranquillizzante.
Queste operazioni che abbiamo messo in atto mentalmente, spontaneamente e quindi molto
velocemente, sono un esempio di utilizzo degli elementi essenziali della comunicazione.
In sostanza: è l’insieme di organizzazione, selezione, omogeneità e
consequenzialità delle cose da dire che dà comunicazione.
E nel fotogiornalismo deve essere lo stesso: dopo avere trovato un tema (un soggetto da
affrontare, un servizio da realizzare) è indispensabile fare chiarezza nella mente.
Prima di tutto per capire che tipo di messaggio inviare.
In secondo luogo per compiere un fondamentale passo verso la decisione su come inviarlo,
verso un utilizzo consapevole del linguaggio fotografico, del vostro codice comunicativo.
Prima di arrivare a scattare le vostre fotografie è essenziale dunque disporre idee,
sensazioni, opinioni, emozioni che avete in testa a proposito del tema che avete scelto.
In modo da organizzarle (dargli un ordine, predisporre un collegamento) per poi poter
essere concisi e selettivi nella loro esposizione (cioè evitare che idee marginali
prevalgano sulle principali) quindi riuscire ad avere omogeneità nel tutto (cioè trovare
un nesso logico tra un concetto e l’altro) ed infine ottenere una certa
consequenzialità (costruire una sequenza e dare unità di stile ai contenuti).
Queste operazioni devono essere fatte, è fondamentale che vengano fatte: senza una
disposizione dei contenuti non si potrebbe passare ad una loro esposizione e quindi non si
potrebbe avere comunicazione.
Volete un esempio riferito alla fotografia di un utilizzo concreto di questi elementi
essenziali della comunicazione? Eccolo!
La prima esercitazione che avete fatto, quella da eseguire con la macchina usa e getta,
voleva essere un esempio pratico di quanto teorizzato finora.
Abbiamo intenzionalmente richiesto di raccontare una storia con le immagini e abbiamo
volutamente imposto l’utilizzo di una ed una sola macchinetta senza flash proprio per
farvi utilizzare (anche se inconsapevolmente) gli elementi della comunicazione.
Cosa avete dovuto fare infatti, prima di arrivare a scattare, se non organizzare le vostre
idee, individuare i momenti emblematici da riprendere, trovare un nesso logico tra loro e
infine pensare ad una sequenza?
Lo avete fatto? Bene, avete usato i mezzi della comunicazione. Avete raggiunto un
risultato che vi soddisfa? Allora siete riusciti a comunicare con le immagini!
Certo, probabilmente avete agito in maniera inconsapevole, ma consideratelo come un primo
importante passo.
Passiamo adesso a considerare la seconda componente del linguaggio fotografico: le
conoscenze tecniche specifiche del mezzo fotografico.
Facciamo un piccolo sforzo per vincere la nausea e ripensiamo all’esempio della frase
utilizzata per comunicare alla mamma il nostro stato di salute mentre siamo in vacanza.
Per poter esporre il nostro messaggio è indispensabile essere al corrente di tutte quelle
nozioni, convenzioni, usi, costumi, regole e tradizioni proprie della comunità in cui
viviamo e specifiche della comunicazione verbale.
Occorre cioè sapere come utilizzare il nostro corpo per emettere suoni, come abbinare
questi suoni a delle lettere, come usare suoni e lettere per formare delle parole
comprensibili, come combinare queste parole per mezzo della grammatica e della sintassi in
modo da costruire un discorso chiaro.
E’ necessario cioè conoscere tutti gli strumenti a nostra disposizione per poter
esprimere i concetti che fino ad ora avevamo solo ordinato mentalmente.
Allo stesso modo, per poter esporre fotograficamente le vostre idee, dovete sapere quali
sono gli strumenti dei quali potete servirvi.
Le conoscenze tecniche specifiche della fotografia saranno il vostro strumento espressivo.
Attenzione: per conoscenze tecniche non si deve intendere soltanto la conoscenza di
strumenti e materiali (macchine fotografiche, obiettivi, flash, accessori, pellicole,
metodologie di sviluppo e stampa, effetti speciali, e chi più ne ha più ne metta) ed il
loro corretto utilizzo.
Queste informazioni devono essere sapute, è indispensabile che lo siano, ma in questa
sede le diamo per scontate: sia perchè chi vuole affrontare la foto di reportage deve
già conoscere le nozioni tecniche di base della fotografia, sia perchè mettersi a
considerare nel dettaglio questi aspetti della fotografia significherebbe dover scrivere
un’enciclopedia che non appena terminata sarebbe già vecchia, sia perchè ci sembra
che questi argomenti siano ampiamente e fin troppo trattati dalle riviste specializzate,
sia perchè nel fotogiornalismo costituiscono solo uno dei tanti elementi da prendere in
considerazione e noi preferiamo proprio affrontare questi elementi, meno conosciuti, meno
trattati sulla stampa di settore ma di fondamentale importanza per una crescita
professionale.
Ci limitiamo dunque ad invitarvi a considerare la conoscenza di strumenti e materiali come
oggetto di aggiornamento irrinunciabile, continuo e costante.
Noi piuttosto per conoscenze tecniche soprattutto intendiamo la considerazione degli
elementi che caratterizzano un’immagine fotografica.
Con la loro disamina completerete la conoscenza degli strumenti a vostra disposizione per
poter compiere con sicurezza delle scelte consapevoli e soggettive al fine di comunicare
con la fotografia.
Su questi aspetti intendiamo richiamare la vostra attenzione, inizialmente come spettatori
poi come operatori, perchè a proposito di ognuno di essi dovrete poi prendere delle
decisioni ben precise in sintonia con quanto pensato al momento della disposizione delle
idee.
Dovete imparare a porre sempre l’attenzione su ognuno di essi anche e soprattutto
quando guardate una foto.
E finalmente vediamoli questi elementi, uno per uno:
1) la luce: secondo il tipo di ombra che si posa o che crea il soggetto cercate di capire
il tipo di luce utilizzata dal fotografo: può essere più o meno diffusa (ombre più o
meno morbide), più o meno dura (ombre più o meno nette); in base alla fonte di
illuminazione può essere luce ambiente, oppure luce artificiale; a seconda della
posizione della fonte di luce principale può essere di tre quarti, laterale, controluce.
La luce è la componente fondamentale della fotografia: qualcuno è arrivato a dire che un
fotografo è soprattutto un tecnico delle luci (pensate al cinema, dove il direttore della
fotografia è colui che decide e dispone le luci per creare una determinata atmosfera)
2) la tonalità: fate attenzione al contrasto della foto (un’immagine può essere a
toni duri o a toni morbidi, cioè con una varietà più o meno vasta di grigi), alla
cromaticità (cioè alla saturazione o alla morbidezza dei colori), al tipo di stampa
utilizzato
3) i piani: soffermatevi su profondità di campo e sfondo, in modo da notare il rapporto
tra ciò che sta in primo piano e ciò che sta dietro o il motivo che collega soggetto e
sfondo
4) l’inquadratura: guardate se il fotografo ha inquadrato solo un particolare del
soggetto, oppure ha utilizzato la figura intera, il piano americano, il mezzo busto o il
primissimo piano; se la ripresa è ravvicinata, da media distanza o da lontano; ma
soprattutto imparate a considerare l’importanza di tutto ciò che l’autore ha
incluso nell’inquadratura, considerando che tutto quanto vi è contenuto è voluto:
guardate quindi i bordi dell’inquadratura e cercate di capire perchè il fotografo ha
deciso di includere alcune parti di realtà e di escluderne altre, cosa ha incluso e cosa
ha escluso.
5) il punto di vista: vedete se si tratta di una ripresa dall’alto, dal basso o ad
altezza d’uomo; quali sono gli effetti compositivi così ottenuti; quali sensazioni
dà il punto di ripresa utilizzato; perchè si è ottenuto un certo effetto mediante
l’uso di quel punto di vista
6) i soggetti: osservate se l’immagine è costruita su un unico soggetto, o su due
soggetti interagenti, oppure su numerosi soggetti alla pari; cercate di capire se
c’è e qual è il soggetto principale e come visivamente il fotografo è riuscito a
farlo diventare tale
7) la simmetria o l’irregolarità: esaminate la struttura dell’immagine cioè le
linee visive che sono state utilizzate, la posizione del o dei soggetti
nell’inquadratura, la posizione del fotografo al momento dello scatto; anche in
questo caso è essenziale cercare di capire perchè si è utilizzata una struttura
simmetrica invece di una irregolare o viceversa, quali sono cioè le motivazioni
espressive che hanno spinto il fotografo a prendere tali decisioni visive
8) la dinamicità o la staticità: notate se e come il fotografo è riuscito a dare
all’immagine un effetto di movimento o viceversa un senso di stabilità; vedrete che
queste caratteristiche non dipendono solo dal fatto di trovarsi in una situazione caotica
o all’opposto in una condizione di tranquillità e nemmeno dal fatto che il soggetto
sia fermo oppure in movimento, ma dipendono anche dalla struttura della foto, che può
rendere visivamente dinamica anche una situazione effettivamente statica.
Conoscere e soffermarsi su tutte queste componenti di una foto, una per una, significa
studiare una fotografia cioè analizzare un’immagine per imparare prima e applicare
poi quanto appreso.
E’ indispensabile farlo: guardare le foto altrui, o anche le vostre, esaminando tutte
le caratteristiche proprie di ogni fotografia, alla lunga vi porterà inevitabilmente a
pensare ad esse anche al momento della realizzazione di un’immagine, cioè mentre
state scattando. Vi sarà capitato di farlo, forse inconsapevolmente, anche prima di
leggere queste righe.
Operativamente infatti sarete sempre obbligati a pensare a quegli elementi che vi
consentono di prendere con sicurezza alcune decisioni preventive allo scatto e di riuscire
a metterne velocemente in atto altre al momento dello stesso.
L’importante d’ora in poi è farlo con cognizione di causa e con un fine: cioè
con un progetto e per l’ottenimento di un risultato.
Sono queste le scelte consapevoli e soggettive che riguardano la fase della ripresa, che
sono fondamentali per arrivare al momento dello scatto.
Consapevoli grazie all’attenzione che da adesso dovrete sempre porre agli elementi
tecnici e comunicativi sui quali abbiamo posto l’accento.
Soggettive perchè applicherete questi strumenti utilizzando la vostra personale fantasia,
intelligenza, apertura mentale, arguzia, cultura, educazione, sensibilità, etc. etc.
Sono scelte che devono fondere disposizione ed espressione delle vostre idee, che devono
unire il dito, l’occhio e la mente in un singolo gesto di una frazione di secondo.
Questa è la grande difficoltà ed il grande fascino della fotografia: ridurre tutto ad un
attimo, condensare tutti questi bei discorsi in un "clic", impiegare grandi
energie mentali e fisiche per fissare quello che spesso neanche il nostro occhio riesce a
cogliere, far vedere e fermare l’invisibile.
Capite che per fare questa cosa enorme qualche sforzo dovete metterlo in programma.
Siete infatti in grado di compiere spontaneamente e con grande velocità operazioni tali
che vi permettono, ad esempio, di mettere insieme la frase "Ciao mamma, sto bene e
mangio!"; perchè ormai certi meccanismi sono stati assimilati dalla nostra mente se
non addirittura dal nostro patrimonio genetico.
Ma in fotografia purtroppo la cosa non avviene così spontaneamente e velocemente come con
il linguaggio parlato.
Costruire un lavoro fotografico, un servizio (che metaforicamente potremmo paragonare ad
un discorso) è molto meno facile e molto più faticoso. Implica un’attenzione ad
alcuni aspetti comunicativi e ad altri tipici del mezzo fotografico ai quali non siamo
abituati a pensare e che talvolta ci sembra superfluo dover considerare.
Implica un’attenzione al linguaggio (fotografico) che non siamo abituati ad avere.
Infatti la facilità di accesso ed utilizzo delle apparecchiature insieme alla facilità
di fruizione delle immagini, che il bombardamento continuo e quotidiano dei mass media
mette in atto, ci fanno dimenticare quanto la fotografia ed il suo linguaggio siano
giovani e quindi ancora tutti da imparare e da assimilare (hanno poco più di 150 anni,
nulla rispetto ai secoli di vita dei linguaggi di altre forme di comunicazione che per
questo usiamo con tanta spontaneità e velocità).
Molti credono che sia sufficiente possedere delle attrezzature e premere un pulsante per
essere fotografi, può darsi, ma essere fotografi professionisti è un’altra cosa.
Esprimersi con la fotografia vuol dire altro.
Le considerazioni presenti in questa serie di articoli vogliono stimolarvi ed aiutarvi a
fare le cose con più attenzione, con consapevolezza, con meno superficialità.
Attenzione: non sono regole, ma solo strumenti ed elementi da tenere sempre in
considerazione, a cui pensare sempre: prima, durante e dopo i momenti della ripresa. Si
tratta di nozioni da conoscere ai fini di un loro meditato utilizzo, non di regole da
seguire con il paraocchi.
Così come si insegna la lingua parlata e scritta ad un bambino associando lettere e
parole ad una figura (A = ape) così abbiamo fatto noi associando delle immagini
fotografiche ad un linguaggio.
Adesso tocca a voi usarlo.