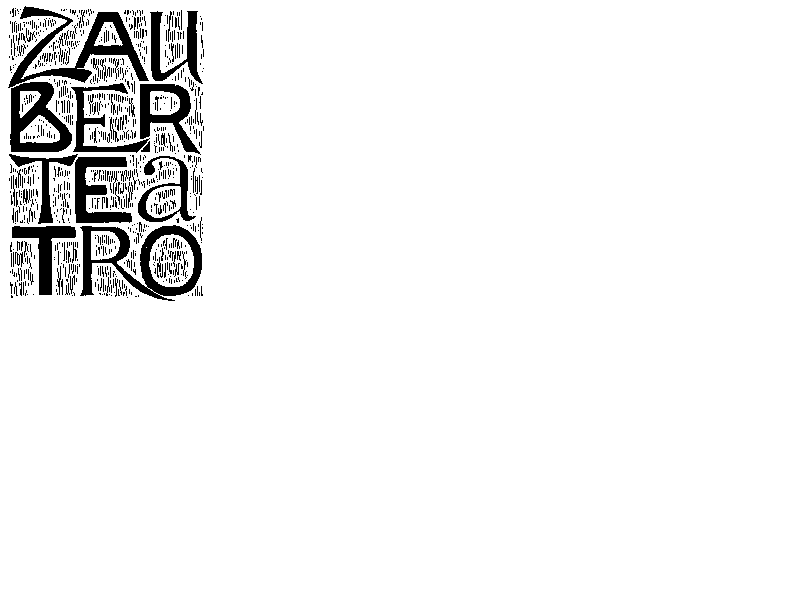
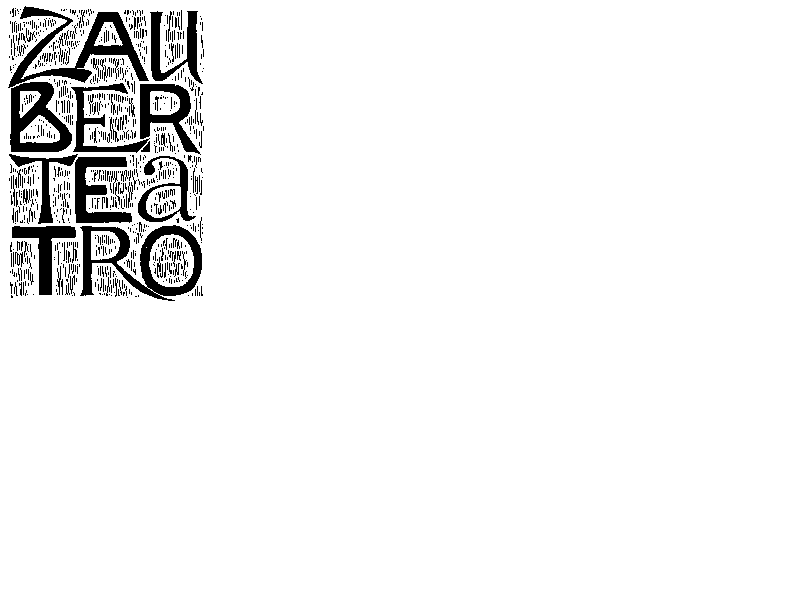
Quando muore qualcuno scompare una biblioteca. Così dice un poeta africano e non a caso il nostro spettacolo, che niente ha di funereo, comincia con una sorta di commemorazione funebre nella quale dietro il ricordo che Guicciardini traccia di Lorenzo si nasconde una scomparsa ancora più vasta: di un pensiero, di un'idea e, appunto, dei libri di Lorenzo. Non i suoi libri, ma le opere su di lui o vicino a lui.
Di queste ci ha ammaliato la diversità degli autori, dei toni e degli scopi, ciascuno col suo modo di vedere e raccontare Lorenzo.
Francesco Guicciardini snocciola un racconto dove nessun particolare è tralasciato. Che si tratti del bilancio sul personaggio del Magnifico o della tumultuosa congiura de' Pazzi, punto cardinale dell'esercizio del potere di Lorenzo, Guicciardini si aggrappa a una meticolosa concatenazione di causa-effetto su causa-effetto. Il destino umano è compiuto da un insieme di casi prodighi di conseguenze: la storia è fatta dai dettagli. Guicciardini padroneggia una lingua lucida e tagliente, un fiorentino rinascimentale che Sandro Carotti offre senza correzione alcuna e che appare, nel vocabolario forbito e nella costruzione
sintattica, uno strumento formidabile quale metodo di analisi.
Della oceanica letteratura neoplatonica abbiamo scelto i due autori che più hanno animato gli spazi di Careggi: Pico e Ficino, e qui si vola. La dissertazione sul sole, recitata in una loggetta le cui decorazioni raffigurano giustappunto un sole mediceo, è un tale pozzo di sapienza, di riferimenti, di linguaggi per noi ormai così lontani che teatralmente abbiamo saputo risolverla solo con la semplicità e la disinvoltura di un gioco.
Il giudizio di Pico sulle opere letterarie di Lorenzo, ben oltre l'adulazione, è di un'eleganza e di un'argomentazione tali che non ha paura di prendere di petto Dante e Petrarca. E ancora Ficino si rivolge al sommo statista europeo evocando l'etica della responsabilità in una luminosa pagina sul rapporto fra uomo e tempo che varrebbe la pena di fotocopiare e distribuire a tutti noi spettatori di un'epoca affrettata e sintetica come strumento di meditazione. Del resto, questi neoplatonici vivevano senza inibizioni, e sarà di nuovo Pico, di fronte all'intero creato, a esaltare il libero arbitrio individuale come l'unica educazione che valga la pena di maturare.
Dietro i filosofi si agita il predicatore intransigente. Demolendo la concezione del potere di Lorenzo, la voce di Savonarola non fa sconti a nessuno e riecheggia quasi come un corpo estraneo, col quale i conti si è tentati di farli con una risata. Ma almeno nel Magnifico i piagnoni trovavano un avversario forse beffardo ma credibile; dopo la sua morte non rimarrà loro che lo scontro finale ed il rogo.
Storici, filosofi, predicatori. Ma il vero monumento a Lorenzo lo si svela scendendo nei bassifondi della società del tempo, in una bettola nella quale dello statista non viene ricordata dal popolo avvinazzato nessuna impresa diplomatica o militare, nessun gesto da mecenate. La novella del Lasca costituisce un'apoteosi popolare del Magnifico, nella lunga sequela di atroci beffe che sono una delle espressioni più alte del cinismo e dell'intelligenza fiorentina: dal Grasso legnaiuolo del Brunelleschi fino agli intrighi del Machiavelli. Storie dove per divertirsi si ordiscono macchinazioni complesse e perfette, ma dove la vittima ne esce sempre a pezzi e, come se questo non bastasse, derisa a futura memoria. Ma qui il vero protagonista è ancora una volta l'unico che non compare. L'ombra di Lorenzo si fonde nell'odore del vino
e in una voglia grezza e vitale di essere un corpo unico con l'umanità della città e con la risata.
Di sicuro quando nel 1492 scompare il Magnifico scompare un modo di pensare in grande. Lorenzo resterà l'unico ad avere imbastito un progetto se non di unificazione almeno di riscatto dell'Italia. Pico era andato ancora oltre, proponendo un ecumenismo che partendo da Platone e dalla Bibbia si riappropriasse degli antichi riti conciliandoli con gli arabi e la cabbala ebraica, perchè sapeva che se non si comincia dalla parte teologica non si può approdare ad alcun lido. Gli orrori dei secoli successivi fino ai giorni nostri, alimentati da contrapposizioni etniche, tribali, religiose, razziali e quindi, in definitiva, da una profonda scissione mentale dell'uomo, sono forse la strada obbligata per una civiltà che non prese in considerazione i propositi di Pico (pragmaticamente ne discusse anche al Vaticano) per passare, di lì a poco, alla
rottura con islam ed ebraismo ed alla frattura interna della Riforma e della Controriforma.
1492: anno strano, di capriole della storia e pesanti eredità. Colombo scopre il Nuovo Mondo e l'Europa comincerà il lungo cammino dell'espansione imperialistica e in seguito della sua decadenza. Per un mondo che si apre ambiguamente, altri due si chiudono all'Europa: con la caduta di Granata l'islam e la sua tollerante civiltà maura, l'alambra, lasciano per sempre il mondo latino, mentre a completare un isolamento sempre più intollerante, ancora nel 1492 viene decretata l'espulsione degli ebrei.
Solo un anno così potente poteva scuotere l'avventura della villa di Careggi: vi muore Lorenzo e con lui finiscono la signoria illuminata, l'unica voce autorevole d'Italia, il mecenatismo della corte intellettualmente più luminosa, e, soprattutto, il respiro di tolleranza, dialogo e armonia del cenacolo neoplatonico. Eppure, sicuri della loro variegata idea di bellezza che è intima felicità, noi restiamo a sfogliare i libri di Lorenzo.
Niccolò Rinaldi, Agosto '92
Affrontare uno spettacolo come "1492" è per un interprete una vera prova di trasformismo. I vari personaggi evocati durante questa visita-spettacolo si presentano, come in un caleidoscopio, di volta in volta, differenti: ognuno di questi risulta pertanto caratterizzato non solo da una propria personalità assai distinta, ma anche dal proprio particolare modo di esprimersi, dai gesti, dagli atteggiamenti, dal modo di argomentare ma soprattutto dal proprio modo di utilizzare la lingua. Si alternano in scena infatti il raffinato storico Guicciardini, l'affettato letterato Pico, il didattico scienziato Ficino, l'eccessivo Savonarola, il truculento Oste, il perenne avvinazzato Manente.
La prima difficoltà che ho incontrato, affrontando questo impegno, è stato il lavoro sulla lingua che, ad una prima lettura, mi è sembrata ostica e complessa nella sua sintassi. La preoccupazione principale è stata per me quella di oggettivizzare fisicamente un'espressione, una comunicazione e per far questo ho cercato, per essere credibile, una sicurezza di pensiero e di espressione che poi è la base elementare sulla quale si fonda il mio lavoro.
Ho passato molto tempo a impratichirmi nell'uso di tutti quei termini quali perrocchè, conceperonne, drieto o drento; superato questo primo scoglio, la mia analisi si è concentrata sulla logica intricata del testo, per cercare di render chiari, a chi ascolta, quei punti di appoggio indispensabili per evidenziare e rendere viva la narrazione che necessariamente si deve comporre come un film mentale della vicenda che scorre libero nella fantasia dello spettatore.
Un lavoro quasi esclusivamente basato sulla forza della parola e sul fascino evocato dalla musicalità di una lingua antica che ci proietta, attore e spettatori, fin dalla prima scena, in un tempo distante mezzo millennio da noi. Una vera sfida, per un attore, che, spogliato di tutti quei mezzi tecnici e degli effetti che sono spesse volte solo la confezione elegante di uno spettacolo di maniera, deve questa volta giocare solo su tutta la sua forza mentale e fisica, senza quei paraventi teatrali che lo nascondano in caso di insuccesso.
Chiarito questo, non resta all'attore che il piacere di abbandonarsi con fiducia a questo viaggio nella memoria con tutto l'agio e la duttilità di chi è cosciente e disponibile ad essere usato da questi eccellenti fantasmi che, per una sera, riecheggiano, misteriosi dal passato, nelle stanze della villa di Careggi.
Sandro Carotti, '94
rassegna stampa |
immagini |
altre produzioni |
