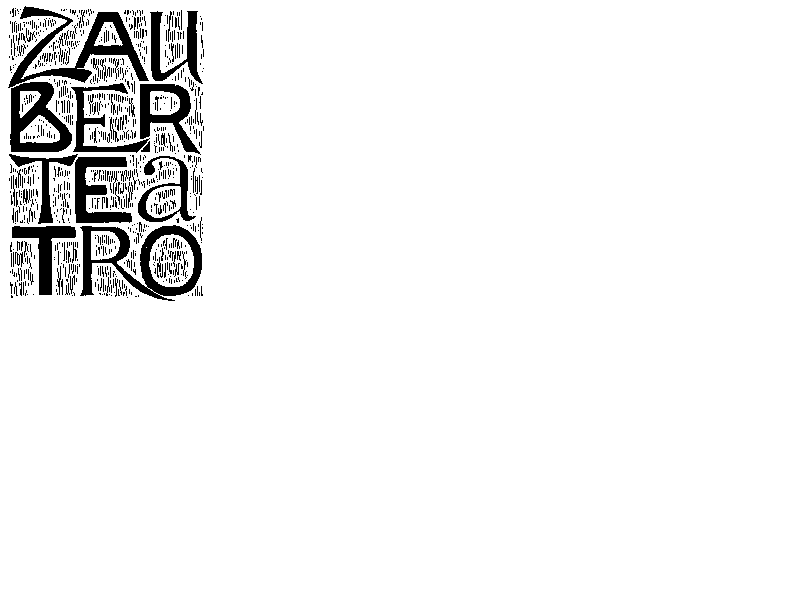
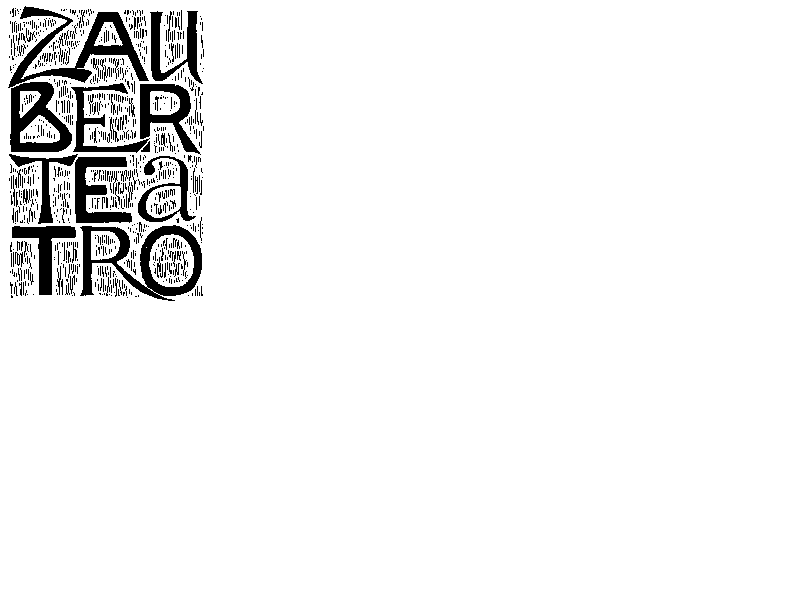

Se anni fa ci siamo innamorati del teatro, montandoci la testa tanto da affondare in questa maledetta attività, in parte lo dobbiamo proprio ad "Aspettando Godot". Quando a scuola sfogliavamo annoiati l'antologia della letteratura, la nostra attenzione era rapita dagli stralci dei dialoghi riportati di Vladimiro ed Estragone, messi lì quasi per uno scherzo dei curatori del libro. Tanto lontane da ogni retorica e ricercata eleganza, ogni volta che tornavamo su quelle battute così inconsuete fra tante citazioni preziose del Gotha letterario, la nostra curiosità si accresceva. E dal primo momento di affezione a quei personaggi così buffi, di anno in anno, abbiamo sempre più tenuto a mente la magia particolare di quegli scambi di battute, intuendo, in modo via via più consapevole che una ovvietà talmente poco letteraria ed insistente aveva qualche cosa che ci riguardava davvero, anche troppo.
Ma sarebbe insufficiente osservare che quell'attesa snervante e riempita di avventure immaginarie, di balle inventate con foga, assomiglia a quella di una generazione mai appagata, piegata da una secolarizzazione incessante e da uno scetticismo che mette in dubbio persino se stesso. Nell'universo di Vladimiro ed Estragone c'è soprattutto l'essere così poco eroici, così poco universo, ma piuttosto una balordaggine strampalata, fatta di due caratteri inconciliabili eppure bisognosi l'uno dell'altro. E in tanta blanda meschinità, nel trascorrere le giornate annoiati davanti ad un televisore od all'angolo di una piazza, nel riempirsi di citazioni pseudo-intellettuali surrogato degli studi di massa, in questo tentativo di interpretare il tempo abbandonato a sè stesso, il futuro e le proprie responsabilità, con un cifrario della realtà formatosi su un Bignami del sapere umano e della storia della civiltà, ecco, in tutto questo si scorge una vicenda d'animo poco nobile ma con una sua dignità ed anche una certa poesia, epopea fra la noia esistenziale gloriosa e suo malgrado comica tanto più è banalmente quotidiana, inconsapevole di sè stessa e della tragedia che reca. Una innocente indecenza di sopravvivere.
E in un mondo in cui tutto è mediato, in cui il rapporto fisico, lo scambio concreto, sono disattesi, in cui i nostri Godot sono immagini effimere, fantasmi, stupide alternative in attesa del vero Godot - che oramai Vladimiro ed Estragone hanno aspettato fin troppo anche per noi - l'attesa è dettata da una macchina, un televisore che se pure concederà qualche immagine o addirittura Godot non sarà per poterla toccare ma solo per osservarla a due dimensioni.
In questo senso il nostro allestimento di Aspettando Godot è andato un pò oltre Beckett. Questo video perennemente acceso non è solo una polemica sulla tele-dipendenza, ma vuole richiamare il misterioso intrecciarsi di valori che attribuiamo alla tecnica, oggettivazione delle nostre speranze e delle nostre paure, uno strumento che ci coinvolge sempre di più psicologicamente.
Esso è capace di creare e di distruggere le sue creature, illuse per un attimo di avere un pò di voce in capitolo ma subito riciclate o scartate, come accade a Pozzo e Lucky (il cui rapporto è un cinico schiavismo al quale vediamo abituati fra l'altro certi interpreti delle immagini televisive che ci sono più frequenti). Ma dato che da sempre l'umanità all'emancipazione dei vincoli della natura ha sostituito gradualmente quelli dei rapporti sociali, attendendo sempre il suo Godot, Pozzo può ben pontificare che "le lacrime del mondo sono immutabili. Non appena qualcuno si mette a piangere, un altro, chi sa dove, smette. E così anche per il riso. Non diciamo troppo male, perciò, della nostra epoca; non è più disgraziata delle precedenti. Ma non diciamone neanche troppo bene, anzi, non parliamone affatto".
Perplessi al cospetto di tali dissertazioni, chiusi in una stanza, sebbene non costretti, perchè quando vogliono ne escono ma per rientrare innervositi poco dopo, diffidenti verso ciò che è altro rispetto a loro, Vladimiro ed Estragone si accontentano di qualche successino personale - un'emozione passeggera, un giochetto da due soldi - per vedersi riconfermati nel loro ruolo di sopravvissuti.
Nella lunga gestazione dello spettacolo, nelle inevitabili incertezze nel fare scelte originali e rischiose, ma con la consapevolezza che ne valeva la pena - ma forse è proprio un dovere per una formazione giovanile - un incontro importante è stato con la musica di Peter Gabriel, che abbiamo scelto non per il gusto degli abbinamenti improbabili (già per "La lezione" di Ionesco avevamo utilizzato Bach), ma perchè lo riconosciamo un interprete straordinario dei nostri anni, protagonista di un fenomeno culturale, come il rock, snobbato dagli intellettuali, che non si è lasciato prendere la mano dai meccanismi di consumo, ma nelle cui opere ritroviamo una tensione vitale e tragica, paradigma di umori assai diffusi. Ed il sommeso coro del brano di apertura è stranamente vicino ad Estragone e Vladimiro, cantando: "noi facciamo ciò che ci è stato detto. Una voce,...una verità,...un sogno".
Niccolò Rinaldi - Ottobre '87
rassegna stampa |
immagini |
altre produzioni |
