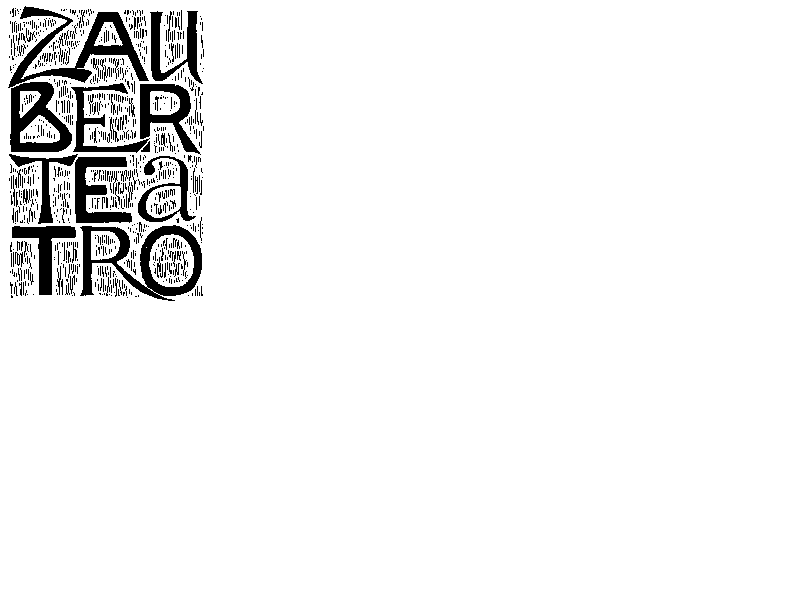
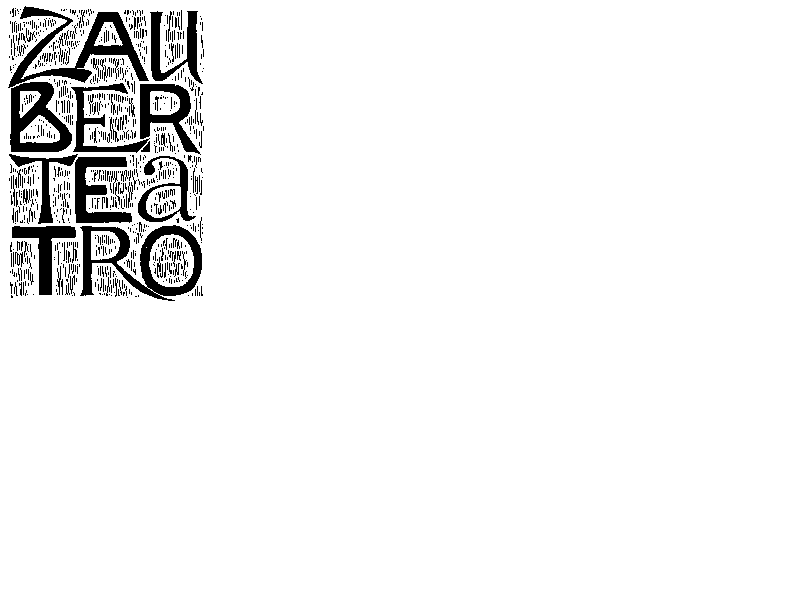

Rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1951, "La lezione" di Eugènè Ionesco, tra lo stupore del
pubblico e le polemiche della critica per le sue innovazioni drammaturgiche, si è presto affermata come una
sorta di classico del teatro contemporaneo e come uno dei testi più significativi dell'autore, Accademico di
Francia e protagonista del teatro del dopoguerra.
Definita dall'autore "dramma comico in un atto", "La lezione" verte sul rapporto tra un professore ed un allieva, apparentemente del tutto normali (un pò timido lui, sicura di sè lei), ma che gradualmente appaiono
sempre più degli esseri mostruosi e grotteschi, artefici, nei loro ruoli di carnefice e di vittima, di una delirante e
paradossale, ed alla fine criminale, lezione di matematica e di filologia.
Testo di grande capacità comunicativa, grazie anche ai suoi aspetti assai umoristici, e di raro spessore culturale, "La lezione" è destinata ad un pubblico molto vasto, da quello scolastico a quello più preparato e
qualificato.
Zauberteatro incontra "La lezione" nel 1985: possiamo dire, anzi, che Zauberteatro nasce con "La lezione". Comunque il testo ci affascina subito e questo amore risulta tutt'oggi vivissimo, tanto che la pièce di Ionesco è,
fra i nostri spettacoli, fra quelli che abbiamo ripreso il maggior numero di volte negli anni.
Negli spazi, squallidi o piacevoli che siano, utilizzati di volta in volta - dalla Biblioteca dell'Orticoltura a Villa
Fabbricotti, da Piazza Santissima Annunziata al Teatro Verdi di Carrara - si aggirano tre personaggi carichi di
quella ottusa inquietudine che dà particolare fastidio: quella che fa ridere. Creature di un testo teatrale che ha
ormai perso molto della sua vena provocatoria e dissacrante (è rimasto ancora qualcosa da dissacrare?), ma
che è ancora capace di divertire il pubblico spaventandolo, sotto il loro carico di convenzionalità un pò
arrugginita, essi sono in grado di esprimere una credibilità pari solo al loro orrore.
Una governante dal passato ambiguo, fidanzata con un prete, la cui vera attività è di essere la becchina dei
cadaveri che si accumulano nelle sue stanze; un professore criminale incallito che sotto la maschera ha un
volto ed una voce da adolescente, invasato dalla logica perversa del suo sapere assurdo; una giovane
studentessa dalla voce stridula tutt'altro che inconsapevole vittima, piuttosto rintronata dai suoi folli scopi di
conseguire la libera docenza totale, capace di imparare a memoria i risultati di tutte le moltiplicazioni possi
bili (siamo già forse all'uomo-computer?) e, come dichiara, di saper contare fino all'infinito - e c'è da crederle.
Chi sono questi signori se non tre spaventosi mostri?
Attraverso le loro azioni ed i loro dialoghi, in bilico fra ridicolo e paradosso, le intuizioni di logica pura ("non
c'è nulla fra tre e quattro, il quattro viene immediatamente dopo il tre, non vi sono unità fra tre e quattro"),
attraverso la loro fisionomia di burattini senza fili, si consuma questa terribile lezione, nel corso della quale la
loro presunzione di dominare il linguaggio, che invece li porterà ad imprigionarli nelle loro fissazioni, li relega
all'assoluta incomunicabilità, al non-ascolto, alla violenza.
Ionesco, beffardamente nichilista, non ci racconta una storia, ma irradia un fascio di luce su uno spezzone di una vicenda cominciata da tempo (da sempre?) e destinata a ripetersi in eterno senza che ai suoi protagonisti si presenti alcuna speranza di redenzione. Rinchiusi nella loro esistenza dal corso irreversibile, i tre personaggi hanno ormai perso il volto di uomini, ma si muovono inchiodati nei loro ruoli, si chiamano"il Professore", "l'Allieva", "la Governante Maria" (il più convenzionale dei nomi per il suo ruolo), sono poveri stereotipi, marionette amiche di un loro probabile antenato: il Re Ubu di Jarry, il meschino, ingordo, crudele, ridicolo antieroe di una umanità finita che ha ormai chiuso con la serietà, assurda tanto da sapersi costruire una sua serietà ... assurda. Non a caso si è parlato di questi grotteschi personaggi di Ionesco come di "manichini, pupazzi, non identificazioni dell'uomo come è, ma dell'uomo come è diventato o come si preferisce. La preferenza inconscia corrisponde all'apparenza di un mondo che si crede esistente e che si rassicura trovandosi confermato da un linguaggio istituzionalizzato in maniera grottesca che lo trascina in un vortice di parole che non si collegano a nulla. Ma non mancano mai all'appuntamento" (Rebora).
In questo nulla il bisogno di Dio, apparentemente così assente da "La lezione", la sua mancanza è pari alla disperazione irreparabile dei condannati ad una pena che si ripete continuamente (ed il canto di Bach invoca: "Pietà per me, o Signore, io soffro, piango, prego / nel mio cuore che tormento, che pena / Pietà per me, Signore"). Ma è un canto che passa sopra le loro teste, incapaci di gridare una qualche speranza ed al tempo stesso così vicino alla loro condizione di anime perse o di fantocci con la maschera.
Niccolò Rinaldi
rassegna stampa |
immagini |
altre produzioni |
