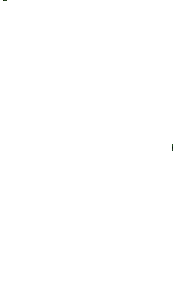ITE
ANGELIJ, ANGELIJ MEI, ITE FORTISSIMI
CÆLESTIS AULE MILITES SUPERBIENTEM.
EXTERMINATE, EXTERMINATE LUCIFERUM.
 «...mentre ch'esso
Iddio, quasi Primaio, & sovrastante, batteva la misura, &
dava regola all'armonia, subito [...] appena incominciato il
concerto, ecco chi lo guasta, & disturba. Lucifero fù
il primo ch'escì di tuono...»
«...mentre ch'esso
Iddio, quasi Primaio, & sovrastante, batteva la misura, &
dava regola all'armonia, subito [...] appena incominciato il
concerto, ecco chi lo guasta, & disturba. Lucifero fù
il primo ch'escì di tuono...»
Gio. Battista Marino, Dicierie Sacre, Venezia 1643, pag 132.
ITEPUGNATEFUGATEREBELLES
DAMNATESUPERBOSADFLAMMASAVERNI.
TARTAREIVADANTADLUMINAFUNDI
ESSTIGIJCADANTADIMAPROFUNDI
HASADDITEPOENASININFERIPORTIS
PARATECATENASEVINCULAMORTIS
MERENTESDOLENTESINIGNELOCATE.

 «"Dolce
è il mondo, dolce è la sua polvere",
«"Dolce
è il mondo, dolce è la sua polvere",
questo grande inno intono nel mio cuore.
Esso dà senso alla mia vita.
Giorno dopo giorno gemme vitali come un dono vengono a me,
- la loro, è bellezza che non si può offuscare.
È al confine della morte, questo cantico:
"Dolce è il mondo, dolce è la sua polvere",
è un eco nel cuore della gioia.
Quando la terra mi toccherà per l'ultima volta,
allora io proclamerò:
"Il segno della vittoria è sulla mia fronte, scritto
nella polvere!"
Dietro il Maya del male,
là ho visto la luce dell'Eterno.
La bellezza della verità ha preso forma nella polvere
della terra;
poiché ho visto questo, io acclamo la polvere.»
 Rabindarnath Tagore,
Calcutta, 1937.
Rabindarnath Tagore,
Calcutta, 1937.
«...Il castello, inoltre, era di una bellezza magicamente incantevole: quattro torri rotonde, intorno a un corpo a due piani di bellissime proporzioni, su pianta quadrata; era il "donjon", la fortezza difensiva di un maniero del dodicesimo secolo, ma ingentilito, o addolcito nei primi del Settecento da un immenso tetto coperto d'ardesia, in forma perfetta di piramide, e da bellissime, ampie finestre. Nel fossato intorno pascolavano delle vecchie carpe, enormi e quasi solenni nei loro movimenti, e sul ponte in muratura due statue di cani da caccia ricordavano l'uso di quell'edificio ai tempi degli ultimi nobili proprietari.
Di fronte a quella facciata sorridente c'era un vasto prato, e al fondo di quello iniziava la foresta della proprietà. Ci andai poco prima del tramonto, da solo, entrando nell'ampio viale centrale, tagliato molti secoli prima in modo perfettamente prospettico al castello, per offrire una passeggiata di alcuni chilometri in linea retta, nell'ombra assoluta dei grandi alberi. L'impressione era quella di esser penetrati in una meravigliosa, immensa Cattedrale gotica, con gli archi a sesto acuto, alti quanto un cielo lontano e superbo, fatto di perfetti, simmetrici intrecci di rami, e coperto di foglie verdissime, luminose, quasi trasparenti come preziosi smeraldi.
Sulla sinistra, a metà del lungo viale, c'era un passaggio nel fitto degli alberi. Mi venne voglia di penetrarlo, di seguirlo, e dopo pochi passi trovai uno spiazzo, in cui un tumulo coperto d'erba ed edera mi rivelò la presenza di una tomba. Appena nascosta, un'apertura scurissima aveva dei gradini in pietra per discendere a quelle silenziose sepolture. Rimasi là davanti un tempo lunghissimo, come ad ascoltare il lieve canto di pace che tutte quelle cose erano là a raccontare.
Più tardi, a cena, mi spiegarono che quella era la tomba degli antichi castellani, poiché avevano scelto di non essere sepolti nella Cappella, ma nella loro foresta, nella terra consacrata solo dal loro amore, nella Cattedrale fantastica e cangiante degli alberi vivi e del canto degli uccelli nel segreto della natura.
Dormii in una stanza rotonda, all'interno della torre dell'Est. Dal balconcino vedevo il nero della foresta, e la bellezza immensa ed eterna del cielo di stelle. Dritto, di fronte allo sguardo di quella finestra, era il grandissimo semicerchio del prato, come un ampio anfiteatro rivolto al castello, e alle spalle il bosco dov'era quella tomba protetta dall'amore degli alberi; questi mi parevano più vivi nel buio, come esseri gentili, infinitamente saggi, o angeli, messaggeri di pace.
Sentivo quel luogo come un dono prezioso, qualcosa che mi sembrava di ricevere in premio, per riposarmi dal viaggio, o dalla battaglia, per curare le mie ferite. Restavo sul mio balconcino, immobile nell'aria fresca della notte, a farmi amare dalla brezza, mentre tutto di me sembrava trovare la calma.
Poi, d'un tratto, dalla foresta venne un grido acutissimo, disperato; continuava, gemendo, poi eccitandosi, a singhiozzi strozzati e poi con lugubre piattezza, in fiati lunghissimi: era la morte lunga e crudele di un piccolo animale, forse un roditore, forse nella morsa di un uccello rapace.
Quasi sentivo il suono del becco terribile, impietoso, tuffarsi nelle carni vive, strapparle, e gli artigli penetrare, possedere quell'essere e la sua vita, attraverso l'amplificazione del suo grido. Crudele legge di natura, morte troppo lunga e dolorosa, richiamo disperante, a un'anima forse negata, o forse legata a quei lacci suadenti del ciclo vitale, uguale a se stesso nel non conoscere il tempo, nell'ignorare la morte, eppure temerla, fine di un ciclo, fra la trama e l'ordito di rami e foglie intessute da Dio.
Quella notte, quel luogo, mi rivelavano verità che non volevo conoscere, e le ricacciavo nel buio, le allontanavo con odio dalla mia coscienza. Dentro di me volevo l'oppio denso dell'illusione di quella serenità, i profumi della notte, la carezza del vento sulla mia fronte, la percezione dell'eternità in un istante di piacere perfetto.
Certo la mia anima è ancora là, al balconcino di quella antica torre; e là io tornerò in eterno, discreto visitatore solitario di quella tomba d'innamorati, a godere col sogno delle loro unioni, a sperare senza fine in un nuovo inizio, in un'altra possibilità...»
Claudio
Ronco
(Da: "Il violoncello errante", © C.Ronco 1998)