LA POCHETTE DI ISTAMBUL 
"...nello
stesso modo in cui certi esseri sono gli ultimi testimoni di
forme di vita abbandonate dalla natura, io mi domandavo se la
musica non sia l'unico esempio di quel che sarebbe potuta essere
senza l'invenzione del linguaggio, la formazione delle parole,
l'analisi delle idee, la comunicazione delle anime."
Marcel Proust

 Il mistero del passato mi affascinava, i suoi odori e suoni carichi di infinite intensità. Ebbi fortuna, così un giorno della mia gioventù scivolai via da me stesso, su un treno per l’Oriente. Il mistero del passato mi affascinava, i suoi odori e suoni carichi di infinite intensità. Ebbi fortuna, così un giorno della mia gioventù scivolai via da me stesso, su un treno per l’Oriente.
Fu un lungo viaggio, con l’animo agitato dal lento e graduale avvicinarsi d’un mondo sempre più antico, ora dopo ora, giorno dopo giorno, fino a quella porta d’oriente tanto sognata e desiderata: Istambul dai tramonti incantati, immersi nei profumi di spezie.
Restai due settimane in quella città, meditando nelle sue moschee, percorrendone mille volte le strade più nascoste i mercati, fino a saturare i miei sensi di odori e di magia. Il penultimo giorno, in una bottega della città antica, vidi un piccolo violino da tasca: una pochette, com’era chiamata nella Francia del Settecento, quando i maestri di danza usavano infilarla nelle profonde saccoccie delle redingote ed estrarla a mo’ di spada per insegnare passi e volteggi al suono delle sue corde, e anche un secolo dopo, quando romantici amanti delle passeggiate nella natura potevano incamminarsi con quello strumento appresso, leggero quasi quanto un flauto, per offrirsi, nelle soste, il prezioso diletto di far musica.
Entrai e l’acquistai subito. Per le venticinque lire turche del suo prezzo ricevetti pure il suo nome: Lyra, come quella di Orfeo.
Era un oggetto grazioso, molto semplice, tratto da un blocco di legno di lauro chiaro, lungo quanto un avambraccio e largo tanto da poter entrare in tasca, scavato per ricavarne il corpo e il manico con la sua  scatoletta dei piroli; su quella cassa allungata e sottile era poi incollata una sottile tavola in cipresso di venatura dritta e fine, coi fori armonici ritagliati come le feritoie dei castelli antichi; fra quelli, infine, era posto un grazioso ponticello d’acero bianco, per poggiarvi tre sole corde di rame. L’archetto, invece, era d’un legno denso e scuro, e ricordo che tendeva dei bellissimi crini color nero corvino: lo stesso colore dei capelli delle ragazze turche che doveva ammaliare con la sua danza. scatoletta dei piroli; su quella cassa allungata e sottile era poi incollata una sottile tavola in cipresso di venatura dritta e fine, coi fori armonici ritagliati come le feritoie dei castelli antichi; fra quelli, infine, era posto un grazioso ponticello d’acero bianco, per poggiarvi tre sole corde di rame. L’archetto, invece, era d’un legno denso e scuro, e ricordo che tendeva dei bellissimi crini color nero corvino: lo stesso colore dei capelli delle ragazze turche che doveva ammaliare con la sua danza.
Organizzai nel mio zaino un alloggiamento per la pochette, e un anziano sarto che aveva bottega sotto il mio albergo mi cucì con poca spesa una bella custodia di lino rosso scuro, bordata d’oro e seta verde smeraldo.
Partii il giorno dopo, con un vecchio pullman che circa due volte al mese copriva il percorso da Istambul a Mashad, confine tra Iran e Afganistan. Il viaggio durava una lunghissima settimana e faceva a pezzi la schiena con i sobbalzi e le dure notti sui sedili di legno. Quel mezzo era rumoroso, scomodo, lento, ma aveva il pregio di una grande radio di cui l’autista andava orgoglioso: la teneva legata con una robusta corda al centro del parabrezza, sempre accesa a gracchiare musichette allegre a pieno volume. Io, seduto meglio che potevo sulla parte soffice dei miei bagagli, passavo il tempo ripetendo sul mio nuovo strumento tutte le melodie di quella radio chiassosa, e i miei compagni di viaggio, coi quali non avevo altro modo di comunicare fuor di quel mio goffo passatempo, rispondevano cantando, ridendo, battendo le mani come per incitare alle danze.
Non eravamo in molti: alcuni nuovi passeggeri erano saliti a Teheran, ma in tutto il viaggio non ci furono più di una quindicina di viaggiatori, tutti uomini, ricordo, e una sola donna con un bambino in età da allattamento. Il pullmann, fra mille rallentamenti, arrivò finalmente alla frontiera afgana, ma di sera tardi e appena in tempo per trovarla già chiusa per la notte. Non ci restò altra possibilità che attendere il mattino nell’unico albergo esistente; di sicuro, pensai, la percentuale sui clienti avrebbe arrotondato il misero guadagno del nostro autista.
Scendemmo in un piazzale spoglio, di fronte a un’enorme muraglia che non pareva mostrare segni di porte, finestre, tetti o terrazze; era infatti – mi spiegarono poi – un’antica fortezza in pietra arenaria e fango disseccato, ideata per mimetizzarsi nel paesaggio. Di quell’edificio non riuscivo a scorgere altro che un muro pieno, liscio e inquietante, finché apparve come dal nulla un ingresso, illuminato dalla torcia elettrica del nostro autista.
Si entrava in un corridoio stretto, e dopo alcuni metri in salita giungemmo in un enorme, squallido stanzone dormitorio, dove due porte molto basse si aprivano verso corridoi privi di luce, e in alto, nel mezzo della parete centrale, si apriva un’ampia finestra tonda, irraggiungibile perché appena sotto l’altissimo soffitto a volta. Due file di letti arredavano le pareti, divisi l’uno dall’altro da vecchi paraventi di tela ingiallita. Io occupai una delle prime brande, la più vicina a una delle porte laterali. Disposi le mie cose in ordine a fianco del giaciglio; mi sedetti e cominciai a guardarmi intorno.
Tutto quell’immenso ambiente era illuminato solo da due fioche lampadine appese al loro stesso cavo elettrico, nel centro del soffitto; mi immergevo in quell’atmosfera straniante, affascinato; era greve di squallore, sì, ma pure di indecifrabili evocazioni, come estratte da frammenti di una memoria non mia, eppure famigliare.
Lasciai che tutti i miei compagni di viaggio uscissero per recarsi a cena; volevo restar solo. Mangiai un poco del pane che mi era rimasto nel bagaglio, poi presi la mia pochette, l’accordai con cura e cominciai a suonarla; provavo la sua voce per la prima volta nel silenzio e nel riverbero di una grande sala, così cominciai a suonare con piacere, per narrare a me stesso, con la musica, le storie meravigliose del mio viaggio.
Un ricordo era più intenso degli altri: lungo la strada ci fermavamo due volte al giorno ai forni per il pane; da Teheran in poi erano tutti uguali: dei larghi capanni con quattro colonnine e un tetto di lamiera, tre muretti bassi e un lato aperto, costruiti su rialzi del terreno, intorno a un forno d’argilla, fatto a forma di cupola, quasi del tutto interrato. Dal lato della strada, su un rialzo in muratura coperto di cuscini, c’era un uomo, generalmente obeso, di regola vestito con una giacca all’europea di lana scura, indossata sopra al tipico camicione tradizionale; da lui si compravano lunghi pani schiacciati, impilati l’uno sull’altro come fogli d’un libro. Li consegnava avvolti in un pezzo di carta, e le poche monete di quel commercio finivano dentro a una scatola di latta appesa al suo fianco, vicino all’immancabile radio gracchiante che rantolava musichette dall’alto del cassone per la farina. Sedevano come dei re a corte, dominando ogni cosa con occhio svelto e instancabile quanto il volo delle mosche.
A poca distanza dal cassiere-proprietario c’era sempre un altro uomo con giacca scura, intento a pesare sessole di farina o pezzi d’impasto su lunghe bilance di bronzo; un altro, generalmente senza camicia ma invariabilmente accucciato al suo fianco, impastava farina e sale e la divideva in striscie; i pezzi pesati venivano infine stirati in lunghi fogli ovali da un operaio, e un quarto uomo vi disponeva sopra, con geometrica esattezza, dei sassolini piatti e neri che, mi dissero, avevano lo scopo di migliorare la cottura. Infine, dietro a tutto ciò e alla flemma ritmata da quelle serene attività, c’era uno sfondo annerito, fumoso, frenetico e primordiale: un ampio cerchio magico, una pedana tonda di legno brunito, sulla quale si svolgeva una danza arcaica e meravigliosa, quasi un sabba, intorno alla bocca di un pozzo fumante, simile all'ingresso di una diabolica grotta sotterranea; lì due uomini seminudi, scheletrici ma agilissimi, i capelli fasciati da bende bagnate, agitavano lunghe pertiche di ferro immerse nelle viscere fiammeggianti di quel forno interrato.
Per tutto il tempo delle soste io restavo lì, incantato, a contemplare quella scena: le faville e le lingue di fuoco che a tratti, rigurgitate da quell’antro, balenavano fra le gambe di quei due uomini saettanti, indomabili e maestosi come antichi eroi guerrieri. E quelli parevano ricacciarle in basso, nei profondissimi interni, schivando il fumo ribollente e i lapilli, sollevandosi e abbassandosi con i loro corpi tesi e nervosi, coperti d’un sudore lucido, come un olio a lubrificarne il movimento veloce, sicuro, impavido, gli occhi sempre vigili su quella bocca alitante fiamme. E poi, la lunga arma impugnata alta sopra la testa, volteggiavano l’uno verso l’altro, schivandosi con formidabile precisione, saltellando senza pausa, quasi i loro piedi, nudi sopra quelle labbra brucianti, dovessero fuggire il pericolo di un prolungato contatto.
La pertica uncinata che manovravano con tanta destrezza agganciava e raccoglieva con gesti ben calibrati le lingue di pasta stirata, bagnate da un lato e infarinate dall’altro, e viste volteggiare nell'aria parevano lunghi pesci piatti e guizzanti; poi con una giravolta e uno scatto degli avambracci le introducevano nella bocca del forno, il lato inumidito in alto, lanciandole verso la sommità della calotta, dove restavano sospese, sostenute dal soffio del calore delle fiamme. Pochi secondi di cottura, mentre altre se ne aggiungevano lì intorno, poi l’uncino le raccoglieva ancora, e ormai indurite e colorate dal fuoco le faceva girare in alto sopra le loro teste, e poi cadere di peso su un legno inclinato, per scuoterle e liberarle dai sassolini neri ancora attaccati, facendoli così rotolare in una cesta da cui venivano raccolti dall’operaio accucciato presso la bilancia. Nel gesto finale di quella danza continua e ciclica, i pani volavano ancora una volta nel vortice di fumo della fornace, e con l’ultima mossa della pertica si staccavano, finendo l’uno sull’altro a fianco dell’obeso padrone, mentre nel suo ritmo vorticoso la danza continuava, ininterrotta, sullo stretto palcoscenico della bocca infuocata.
Ecco: tutto ciò riviveva negli occhi della mia mente, e il mio arco scorreva sulle corde della pochette, narrando ancora e ancora quella storia, mentre il mio braccio tratteneva la sua forza e il suo peso, per non sottrarsi al gioco di sfioramenti delicati, quasi aerei, che quel piccolo strumento pretendeva per poter risonare e muovere il suo canto nei miei ricordi. Ora il mio archetto agganciava il pane tra le fiamme, ora lo faceva roteare nell’aria, ora era l’uno e ora l’altro di quei due uomini ad affondare la lancia e ritrarla con abilità meravigliosa, mentre suoni come luminescenze roteavano intorno, fra bagliori di fiamme rituali, schivando ombre e luci, schegge di follia antica, danzando in cerchio, di vertigine in vertigine.
E d’un tratto mi accorsi di loro. Erano due bambini dall’età indefinita, uno poco più alto dell’altro, con grandi occhi scuri segnati dalla stanchezza e dal sonno; erano di fronte a me, immobili, dentro ai loro lunghi camicioni verde-azzurro, lisi e unti tutt’intorno alle tasche. Se ne stavano lì, di fronte alla mia branda, chissà da quanto tempo. Li fissai a lungo, come colto da una visione angelica, ammirando nella penombra i loro volti. E presto vidi che il loro sguardo era penetrante e duro come quello di chi non ha avuto tempo per vivere da bambino.
Si scambiarono qualche occhiata, poi si rivolsero a me in modo sbrigativo e un po’ sommesso, ma in una lingua che mi era incomprensibile. Il più alto, di fronte al mio silenzio, si rivolse al compagno con poche parole monotone e senza neppure guardarmi mi prese per mano, obbligandomi a seguirlo. L’altro raccolse la pochette che avevo frettolosamente riposto nel mio bagaglio, e insieme mi guidarono oltre la porta, lungo quel buio, inquietante corridoio.
Camminammo per passaggi stretti e scuri, poi per brevi, ripide scale, scendendo e salendo, e ancora altri interminabili cunicoli, fino a un salone caldo e ben illuminato, dove un ampio soffitto a volta scendeva sui lati come una grande tenda rigonfia. Là i muri terminavano su due lunghi rialzi in mattoni d’argilla cruda, divisi in sezioni da una serie di muretti scoscesi, simili a braccioli di poltrona, che scandivano con cadenza regolare spazi simili a piccole stanze confortevoli, arredate con abbondanza di cuscini e tappeti. L’ambiente era illuminato soltanto dalla luce gelida dei tubi al neon, ma la l’eleganza delle stoffe dai colori caldi e piacevoli rendeva l’effetto di una grazia nobiliare. In quei confortevoli rialzi, tra bassi tavoli di legno intagliato, sedevano a piccoli gruppi una ventina di uomini in costume afgano: i camicioni color sabbia o verde-azzurro, e quelle loro brache, larghe abbastanza da non impicciare gambe né ginocchi quando salgono all’altezza del cuore, per appoggiarvi il braccio che regge il bocchino del narghilè, la bevanda, o la conversazione. Alle pareti erano appesi i loro fucili e i cinturoni con i preziosi pugnali ricurvi; i sandali erano disposti in lunghe file ordinate lungo il bordo del pavimento; dei loro mantelli facevano cuscino o coperta, e nell’aria l’aroma forte e dolce del tabacco delle pipe ad acqua si miscelava al profumo del tè, dalle brocche tenute al caldo, sulla cima dei grandi samovar d’argento.
Verso il fondo della sala riconobbi il nostro autista. Sedeva con alcuni anziani, fumando il narghilé da un lungo tubo fasciato di seta color porpora, e parlava animatamente di me (i suoi gesti erano inequivocabili). Un vecchio mi sorrise, e senza muovere nulla più d’un dito, mi indicò il punto in cui avrei dovuto accomodarmi; alle mie spalle, nel centro preciso dell’ampio ingresso del salone, i due bambini avevano portato un tappeto e un cuscino, e su quello era già stata disposta la mia pochette. Mi fu chiaro, allora, che ero stato richiesto in quel luogo per allietarli col suono del mio strumento, come era compito dei musicisti di corte, nei tempi antichi.
Ma capii pure che lungo quei corridoi, quelle scale, quegli interminabili passaggi che io avevo percorso per giungere a loro, altro non avevo fatto se non ripercorrere con i miei piedi ciò che il suono del mio strumento aveva già attraversato, muovendosi leggero nell’oscurità, e portando con sé i volatili fantasmi dei miei sogni.
Cominciai così a far suonare il mio strumento, felice del mio incarico: tutti tacquero per qualche istante, per giudicare o confermarsi la bontà della scelta; poi, soddisfatti, ripresero le loro rilassate conversazioni, fra il piacere di versarsi l’un l’altro bicchieri d’un tè liquoroso dall’intenso color rosso rame, e quello di far borbottare le loro pipe ad acqua.
I due bambini tornarono da me portando un vassoio di dolci, un bicchiere e una teiera piena; li disposero ai miei piedi, ma io non interruppi la musica. Suonavo la danza del fuoco e del pane, sui modi e i gesti delle melodie che avevo appreso dalla radio del pullman, e finalmente mi sentivo capace di offrire a i miei ricordi una voce e un senso.
Nota dopo nota, ricordo dopo ricordo, mi sembrò che tutte le cose lì attorno suonassero insieme a me: il vociare in quella sala, il sereno gorgoglìo dell’acqua nei narghilè, lo schioppettare delle braci nei fornelli dei samovar; ogni rumore entrava a far parte di un certo ritmo perfetto, e tutto, in qualche modo imprevedibile, seguiva le mie melodie come un accorto accompagnamento, dolce e straniante come il suono della pioggia d’estate.
Rientrarono ancora i due bambini, e cominciarono ad andare e venire quasi correndo, per consegnare ad ogni tavolo una scatola di cartone. Gli ospiti iniziarono ad estrarne oggetti di cui non riuscivo a capire il significato: c’erano forbici, carte colorate, filo di ferro, piccole pinze, tondi di latta sottile. Tutti continuavano a conversare, bere e fumare nell’atmosfera della mia musica, ma nel frattempo, con quei curiosi attrezzi, costruivano o assemblavano oggetti e forme, ognuno piacevolmente assorto nel ritagliare, piegare, stirare fogli o annodare fili. Poco più tardi, i bambini tornarono portando diverse lampade a petrolio; poi si dedicarono ai fuochi, soffiando per riattizzare le braci di carbone destinate ai fornelli dei grandi samovar. Mi fu chiaro, a quel punto, che di lì a poco sarebbe mancata l’elettricità; forse c’era un’ora precisa in cui ciò doveva succedere, e forse accadeva ogni sera, come un rituale quotidiano.
Così fu, infatti; d’un tratto si spensero tutte le luci, e com’era prevedibile si accesero le lampade a petrolio, una per ogni tavolo. Il grande salone d’improvviso mi sembrò immenso, sconfinato; le lunghe ombre si curvavano sulla superficie delle volte, come anime inquiete, e i volti degli uomini, nella luce delle fiammelle, ritrovavano i tratti dei loro antenati. Sulla sommità di ognuna di quelle lampade, in cima al tubo di vetro che ne proteggeva la fiamma luminosa, gli uomini si indaffaravano a posare, a ritorcere, a mettere in equilibrio dei piccoli, curiosi treppiedi in fil di ferro; gli occhi roteavano nel cuore della luce, guidando le dita a correggere un nodo o a stringerne un altro, finché quel fragile sostegno riusciva a reggere il peso di una piccola ventola ritagliata da un tondo di latta, e questa cominciava allora a girare su se stessa, mossa dal calore della fiammella. Più in alto ancora, su quello stesso filo intrecciato e diventato asta, con gesti abilissimi e pazienti cominciarono a posizionare delle figurine di carta colorata, ritagliate nelle forme più fantasiose, silouettes di guerrieri ed eroi, languide danzatrici, uccelli e alberi meravigliosi, favolose navi volanti. Quelle figure fantastiche ora volteggiavano tutte insieme sulla grande vela del soffitto, e l’intero salone pareva gonfiarsi di vento e alzarsi in volo, verso viaggi senza fine, epopee gloriose e straordinarie, storie di amori e di guerre, lotte di eroi e di eroine famose. In quell’immensa nave fluttuante su un mare di luce, io timoniere e padrone, ebbro d’incanti, col gesto leggero e veloce del mio arco comandavo il vento, rinvigorivo i fuochi, calmavo e dirigevo tempeste, narravo storie ai cuori impauriti e oppressi dalla notte, e nel chiarore della luna illuminavo ogni figura coi colori della mia musica.
Il mistero del “Hâl”, di quella certa estasi dell’anima che ogni musicista deve cercare, i sapienti maestri persiani dicono essere soltanto “una modalità dell’istante; non è possibile mantenerla o afferrarla: essa viene o si ritira senza causa apparente”.
Claudio Ronco, Venezia, ottobre 1998

© Claudio Ronco. Tutti i diritti riservati.

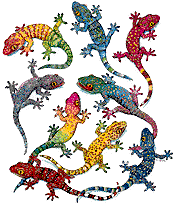
vai al giardino
LABYRINTHUS
|

 scatoletta dei piroli; su quella cassa allungata e sottile era poi incollata una sottile tavola in cipresso di venatura dritta e fine, coi fori armonici ritagliati come le feritoie dei castelli antichi; fra quelli, infine, era posto un grazioso ponticello d’acero bianco, per poggiarvi tre sole corde di rame. L’archetto, invece, era d’un legno denso e scuro, e ricordo che tendeva dei bellissimi crini color nero corvino: lo stesso colore dei capelli delle ragazze turche che doveva ammaliare con la sua danza.
scatoletta dei piroli; su quella cassa allungata e sottile era poi incollata una sottile tavola in cipresso di venatura dritta e fine, coi fori armonici ritagliati come le feritoie dei castelli antichi; fra quelli, infine, era posto un grazioso ponticello d’acero bianco, per poggiarvi tre sole corde di rame. L’archetto, invece, era d’un legno denso e scuro, e ricordo che tendeva dei bellissimi crini color nero corvino: lo stesso colore dei capelli delle ragazze turche che doveva ammaliare con la sua danza.